Joshua Cohen: la versione di Nethanyahu
L’anniversario della Kristallnacht mi ha trovato che leggevo il nuovo libro di Joshua Cohen. E mentre scorrevo le cronache italiane, d’un tratto mi sono sorpresa a simpatizzare con il suo arrogante e dogmatico protagonista: Ben-Zion Nethanyahu, storico e padre di tre figli terribili, Jonathan, Iddo e Benjamin – proprio quel Bibi che le elezioni israeliane hanno da poco riconsegnato alla poltrona di primo ministro. Dopo averlo detestato per un centinaio abbondante di pagine, Ben-Zion all’improvviso mi è sembrato di una lucidità abbacinante. Un profeta. In altre parole, mentre una certa vena pedante stava diventando troppo, I Nethanyahu – Dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della storia di una famiglia illustre (trad. Claudia Durastanti, Codice, 271 pp.) mi ha assestato un pugno nello stomaco da togliere il fiato.
Nei giorni in cui i deliri antisemiti di rapper, atleti e celebrities assortite deliziavano gli Stati Uniti, a catturare la mia attenzione è stata una scheggia di attualità. Succede che qualche idiota ha pensato bene di celebrare la Notte dei cristalli – cioè l’avvio in Germania della persecuzione antiebraica – tracciando una scritta ingiuriosa sulla candida facciata della sinagoga di Trieste.
Nella medesima posizione, una nota foto degli anni Quaranta mostra un florilegio di fasci e svastiche. In primo piano, una giovane coppia sorride nel giorno delle nozze. Le leggi razziali sono da tempo in vigore e i due sposi imboccheranno presto la via della fuga. La città sarà occupata dai nazisti e il Tempio oggetto di devastazione.
In questo doloroso corto circuito della memoria, come non trovarsi in sintonia con lo storico Ben-Zion Nethanyahu? Finora è sempre andata così – il pregiudizio non muore, il trauma si ripete e chi siamo noi per pensare che domani è un altro giorno? È l’asse più provocatorio, uno dei tanti, attorno a cui ruota questo romanzo vincitore del Pulitzer e osannato dalla critica e nella scrittura portentosa di Joshua Cohen diventa un’arma micidiale.
A seconda dei gusti e dell’umore, se n’è parlato come di una commedia domestica, un esilarante campus novel, una meditazione sull’identità ebraica, una riflessione sull’immigrazione, una coraggiosa lezione di storia, un excursus brillante nel sionismo, un distillato dell’America d’oggi. Se non che a chiuderlo in un’etichetta gli si fa un torto. La scommessa di queste pagine è invece di tenere tutto insieme in un flusso sconnesso e precipitoso come la vita.
L’episodio annunciato dal sottotitolo è stato raccontato all’autore da Harold Bloom, ammiratore di Joshua Cohen al punto da includere il suo Il libro dei numeri (2019) nell’elenco dei 48 romanzi da leggere e rileggere. A suo tempo, Bloom si era trovato a fare da chaperon a Ben-Zion Nethanyahu in visita alla Cornell University dove insegnerà dal 1971 al 1975 – quando tornerà in Israele dopo l’uccisione del figlio Jonathan nell’operazione Entebbe.
I due hanno poco o niente in comune. Uno diventerà il critico letterario più noto del mondo anglosassone, celebre per la sua difesa del canone letterario occidentale. L’altro è specializzato in storia ebraica del Medioevo e scriverà un’opera monumentale e discussa sull’Inquisizione spagnola. Però sono entrambi ebrei e agli occhi dell’università tanto basta.
Allo stesso modo, nel racconto di Cohen, Ruben Blum, storico della tassazione al Corbin College nello Stato di New York, con suo sconcerto è chiamato a ricevere Ben-Zion e valutare il suo lavoro in vista di una possibile assunzione. “Io sono di storia ebrea, ma non sono uno storico degli ebrei” si affretta a precisare, ma non importa a nessuno. Malgrado la sua preparazione vada in ben altra direzione, realizza alla svelta che la versione della storia di Nethanyahu è il contrario di quanto ha imparato a scuola.
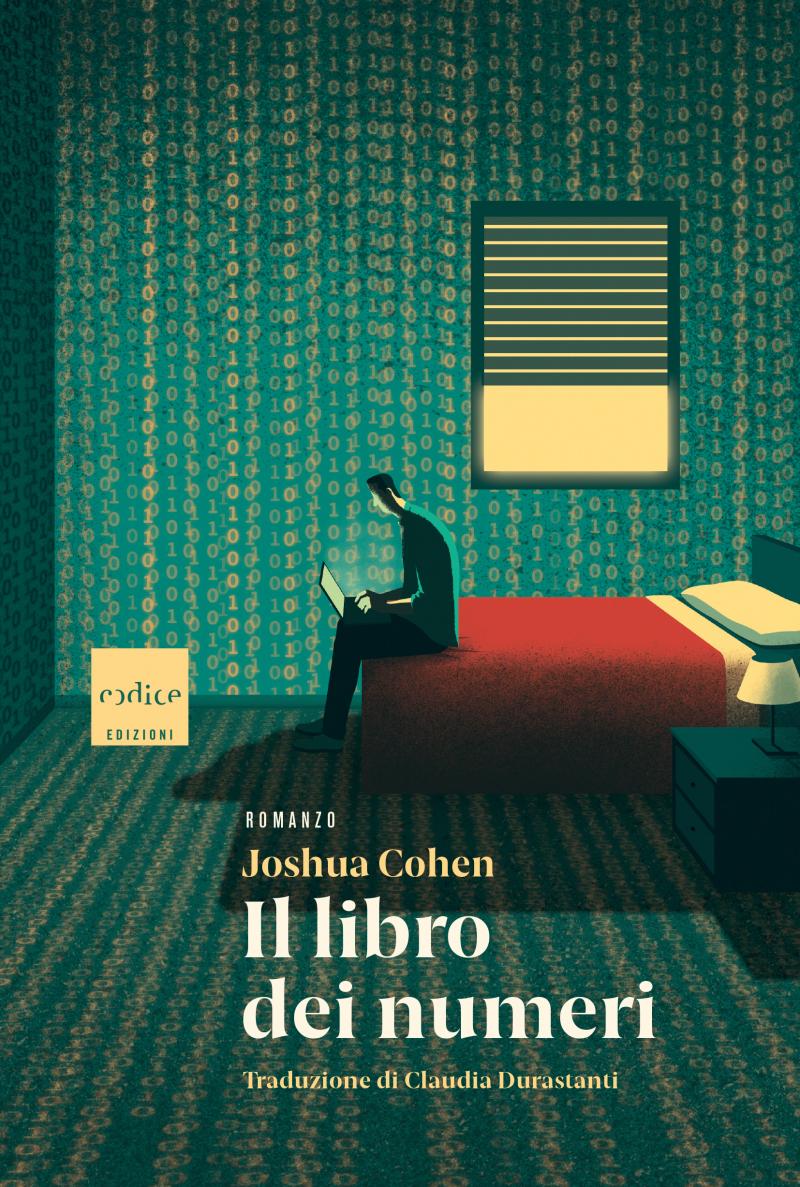
Stando a Ben-Zion, l’accanimento dell’Inquisizione contro gli ebrei non discende della volontà di convertirli al cristianesimo ma è un atto di puro razzismo. Obiettivo, allontanare i convertiti dalla loro nuova religione così da restituirli al loro ruolo di capro espiatorio e al loro destino di olocausti: “I cattolici avevano ancora bisogno di un popolo da odiare, gli ebrei dovevano restare un popolo destinato a soffrire”. Blum finisce per trascorrere notti insonni in compagnia di quegli scritti. E mentre sempre più gli diventa chiaro che quella teoria non ha basi, che è una forma di “teologia” con Ben-Zion nel ruolo di credente, si trova a riflettere sul ruolo e sulla sua identità.
I Nethanyahu arrivano nel pieno di una tempesta di neve, nel gennaio 1959. E a sorpresa sono quattro – Benzion, la lagnosissima moglie Tzila e tre ragazzini maleducati da far paura. Quella che segue è una farsa vorticosa che fra realtà e fiction svela un groviglio di pregiudizi, aspirazioni deluse e umane compiacenze. Lo scenario è quello raccontato da Philip Roth in romanzi come La macchia umana o Indignazione. Sono i tempi in cui un antisemitismo strisciante pervade il mondo accademico. I docenti ebrei sono ridotti al minimo (Harold Bloom è il primo professore ebreo di ruolo a Cornell) e alcune università non esitano a modificare i meccanismi d’iscrizione per tenere alla larga gli studenti ebrei.
Una sedicente facciata di tolleranza cela veleni di ogni tipo e Joshua Cohen ne trae il meglio.
Come dimenticare il professor Blum richiesto di travestirsi da Babbo Natale (così “le persone che festeggiano davvero la ricorrenza potranno sentirsi più libere di divertirsi”) che al party della facoltà deve consegnare in dono ai colleghi minuscoli tagliacarte che gli feriscono le dita? Come ignorare la fastidiosa condiscendenza del suo capo o il country club che con pretesti vari si ostina a rimandare la sua iscrizione? Soprattutto, che farne della penosa richiesta di ricevere Ben-Zion Nethanyahu per la sola ragione che “quest’uomo è uno dei tuoi”?
Il racconto illumina la crisi di Ruben Blum di una luce dissacrante. Figlio di immigrati dall’Est Europa, il suo ebraismo si riduce a qualche ricordo d’infanzia e a una manciata di tradizioni superficiali. La sua identità si riassume idealmente nella proclamazione con cui Saul Bellow apre Le avventure di Augie March: “Sono americano, nato a Chicago [...] e affronto le cose come ho imparato a fare, liberamente [...]”. Cinquant’anni dopo, l’orgoglio di quella rivendicazione è però costretto a fare i conti con la realtà. “Per la mia generazione – dice Blum – un ebreo era fortunato a essere scambiato per bianco [...] per qualsiasi minoranza lo stile e anche la forma di protezione più affidabile era assimilarsi, non differenziarsi”.
È uno sforzo fallito in partenza. Della sua doppia identità di ebreo-americano gli altri vedono solo il primo termine e lo proiettano, scrive Cohen, nello stereotipo più corrente: “l’incarnazione rigonfia, ipertensiva ma soprattutto apprensiva e alimentata ad angoscia del maschio ebreo che si automortifica, scoordinato e iperintellettuale, quello che uno come Woody Allen, per esempio, e tanti autori letterari ebreo-americani hanno preso in giro fino a trovare un inconsueto successo economico e sessuale (Roth nella generazione successiva alla mia, Bellow e Malamud in quella precedente)”.
Sono contraddizioni scontate, nella visione del suo ospite. Mentre rilegge l’intero passato con il filtro della Shoah, Ben-Zion sconfessa i miti di fondazione degli Stati Uniti – la fiducia nel progresso, la libertà di scelta, la promessa delle opportunità. Il potere del cambiamento, a suo giudizio, appartiene invece “alla vasta gamma di gentili nel mondo, esseri umani che agivano per odio, giudicando gli ebrei in continuazione e opprimendoli e generando cambiamenti con le loro oppressioni: convertendoli, sconvertendoli, massacrandoli ed espellendoli”.
Quello fra Blum e Nethanyahu è un conflitto che ricapitola un contesto più ampio. In pagine ricche di spunti e informazioni, Joshua Cohen ripercorre il tumultuoso processo che a metà del secolo vede l’identità ebraica ricrearsi, in modi ben diversi, in America e in Israele (il libro si svolge dieci anni dopo la fondazione dello Stato).
Vicino al sionismo revisionista di Vladimir “Ze’ev” Žabotinskij, Ben-Zion è convinto che solo nella Terra dei Padri al popolo ebraico sarà dato di trovare salvezza. L’Europa porta morte ed è finita. Quanto agli Stati Uniti, sono votati al collasso “una volta che l’assimilazione fosse stata rivelata come una truffa, o una volta che si fosse scoperto che il Paese non conteneva nulla a cui assimilarsi – nessun centro, nessun cuore innato – non solo per gli ebrei, ma per chiunque”.
È un passaggio che travalica lo specifico ebraico e chiama in causa le convulsioni che oggi scuotono l’America, dagli estremismi delle identità alle paranoie suprematiste e dovrei ragionare di questo. Eppure la mia testa resta fissa su quel muro imbrattato oltreoceano. Scorro le dichiarazioni di condanna, le espressioni di solidarietà ma per quanto mi sforzi la sintonia con Ben-Zion resiste.
Poi per ordine della Soprintendenza la scritta viene cancellata. Nella foto, un operaio ripulisce le lettere finché sono invisibili. A una seconda occhiata, noto il suo colore di pelle ed è l’antidoto migliore al dogma revisionista. La città è oggi meta di immigrati e nella piazza in cui Mussolini nel 1938 proclamava le leggi razziali si intrecciano lingue e culture diverse. L’odio resta ma la Storia si muove.









