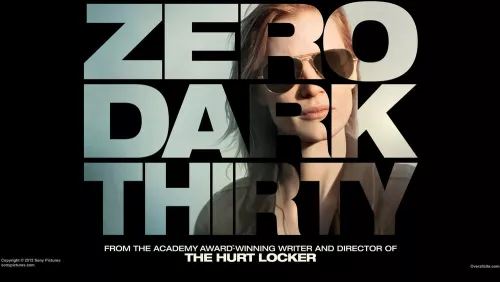Kathryn Bigelow. Zero Dark Thirty
È possibile che una caccia ai fantasmi si trasformi in un’evocazione, che la pretesa razionalità di un dispositivo rivolto alla cattura di un nemico evanescente diventi una trappola che inghiotte chi l’ha progettato. L’oscurità che emana da Zero Dark Thirty è forse il risultato di un simile rovesciamento, e andrebbe considerata al contempo come una riuscita e un fallimento: evitando di fornire un quadro sufficientemente articolato dello scenario storico e politico affrontato (ovvero il “post-undici settembre”) e delle parti coinvolte così come di sintetizzarlo in un discorso assimilabile da una di esse (dunque senza essere né autenticamente critico né smaccatamente propagandistico), il film riesce tuttavia a dire qualcosa su tale scenario, o forse qualcosa, dal profondo, arriva a parlare attraverso di esso, facendo breccia nella sua impassibile superficie.

Nella nube di questioni sollevata da un’opera che tocca punti cruciali riservandosi un ampio margine di ambiguità, l’unico dato apparentemente solido e condiviso è che Zero Dark Thirty sia un prodotto ottimamente realizzato, asciutto e teso nel tempo pur dilatato che si prende (più di due ore e mezza, secondo un ormai affermato standard industriale) per ricostruire i dieci anni di indagini che hanno portato la C.I.A. a rintracciare ed eliminare Osama bin Laden. Va anche detto che non si tratta di un instant movie su commissione, dato che Kathryn Bigelow e Mark Boal – sceneggiatore anche per il precedente The Hurt Locker (2008) – lavoravano già al progetto quando la notizia dell’uccisione di bin Laden fu resa pubblica, prima quindi di avere un happy end. E del resto sarebbe difficile considerare felice la chiusa del film, che si congeda con un senso di disagio e smarrimento impensabili per un’opera ‘di regime’. Allo stesso tempo non siamo certo di fronte a un film ‘di denuncia’, intenzionato a scandagliare tutto il sommerso di una guerra la cui sostanziale invisibilità non le ha impedito di assumere un’opprimente concretezza. Pur astenendosi dalla funzione di lapide celebrativa posta sulla “guerra al terrore”, Zero Dark Thirty resta in sostanza e visceralmente embedded, ma proprio in ragione del suo posizionamento interno ai confini e alle preoccupazioni della sicurezza nazionale, si offre come un film sintomatico, la cui ostentata lucidità finisce per riflettere, come uno specchio oscuro, le ossessioni che nell’ultimo decennio hanno pervaso quella nazione - e, volenti o nolenti, noi con essa.

Come ci si poteva aspettare, l’uscita del film è stata accompagnata da un vespaio di polemiche, che nel complesso mostrano una fondamentale distorsione. Al di là delle radiografie che puntualizzano sulle inevitabili mancanze e approssimazioni della ricostruzione, il dibattito si è concentrato soprattutto su una questione: l’impianto narrativo mostrerebbe che le informazioni chiave per l’individuazione del nascondiglio pakistano del leader di Al Qaeda sono state ottenute grazie alla tortura e, di conseguenza, ne giustificherebbe l’uso alla luce del successo dell’operazione. Addirittura, sostiene Slavoj Žižek, rifiutando di mostrare una presa di distanza da parte dei personaggi, ne favorirebbe la normalizzazione. Senza scendere in dettagli che non si possono qui trattare, si può dire che la maggior parte degli opinionisti dimostra un eccesso di ingenuità o malafede nel rimproverare alla Bigelow una mancata presa di posizione, propugnando implicitamente un approccio didascalico a tutela dello spettatore sprovveduto. Al contrario, mi sembra che proprio il gelido pragmatismo mostrato dagli agenti della CIA sia ciò che rende efficacemente disturbanti le scene di tortura. Ma il punto è un altro: ci si arrovella sugli ignobili mezzi adottati in vista del fine strategico e narrativo, mentre si tralascia di interrogare a sufficienza il fine stesso.

Anche sorvolando sulla giustapposizione schiaffata in apertura, dove allo schermo nero agitato dalle voci delle vittime dell’undici settembre segue immediatamente il black site pakistano in cui si svolge l’interrogatorio sotto tortura di uno dei complici dell’attentato (mossa che assume una sfumatura ricattatoria), è piuttosto la tensione procedurale con cui il film si dirige verso il proprio punto di fuga a farne l’insensibile catalizzatore di un’ideologia che cova sotto all’ostentata obiettività giornalistica (“reported film” l’ha definito l’autrice). L’orizzontalità con cui la narrazione aderisce ai fatti “riportati” si dimostra così un piano inclinato, che la spinge verso un territorio sempre meno rassicurante. E l’inquietudine che sorge non dipende tanto dal rifiuto di tracciare linee nette entro la zona grigia dei servizi segreti, quanto dal fatto che il suo procedere mostra come la ragione di stato, che passa sopra ai corpi di cui si impossessa per dare corpo allo spettro che la minaccia, finisca per negare al nemico qualsiasi realtà autonoma rispetto ai propri meccanismi di individuazione e, in questo modo, alimenta a dismisura i fantasmi che intende scongiurare, in una continua reversibilità di visibile e invisibile che la vincola sempre più strettamente alla propria ossessione. Ma mentre mette in evidenza questa dinamica, il film sembra in qualche modo soggiacervi, aderendo alla stessa logica di denegazione e respingendo quello che sarebbe (qui davvero) un necessario distacco critico.

L’ossessione è la stessa che anima la protagonista, Maya, giovane agente C.I.A. senza passato, il cui intuito condurrà al corriere e quindi al covo dello “sceicco”. La durezza e la determinazione con cui si muove in un campo dominato dai superiori maschi, più che voler attirare simpatie femministe, sembra farne soprattutto una pura incarnazione dell’operatività, un personaggio refrattario alla psicologia e assolutamente cavo, ovvero scavato e sostanziato dalla propria dedizione al lavoro di intelligence: una figura forse più sfaccettata, ma sostanzialmente speculare a quella del militare protagonista di The Hurt Locker, che abbracciava la dimensione di rischio permanente della guerra in Iraq come un’irrinunciabile dipendenza. E proprio da questa cavità emerge il cuore oscuro della razionalità indagatrice. Via via che l’azione avanza tra deviazioni, stalli, svolte impreviste, la figura di Maya acquisisce spessore e autorità agli occhi dei superiori (nonché degli spettatori) in ragione di una fedeltà alla traccia, di una convinzione, che affronta l’incomprensibile al cuore del terrore accumulando in sé una forza che ha tutti i tratti dell’irrazionale: Maya vede più degli altri, è una veggente, ma il suo sguardo guadagna in penetrazione quanto sacrifica all’estensione del proprio campo percettivo, un po’ come i visori a infrarossi indossati dai soldati durante il raid nella villa di Abbottabad. Paradossi dello sguardo (e del potere da esso incarnato) che culminano proprio nella superba sequenza di azione finale: lungi dal portare a una qualsiasi catarsi, l’epifania dell’agognato bersaglio diventa una ridda di apparizioni sfuggenti e consegna a un definitivo occultamento il corpo del nemico sconfitto, che solo per un secondo balena sul display di una macchina fotografica. Allo spettatore è così negato ciò che è stato negato anche alla Storia.