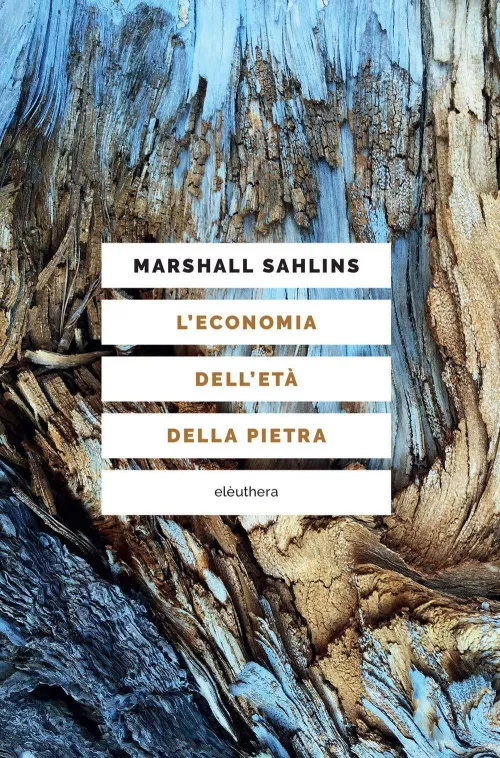Pigrizia / La dolce vita all’età della pietra
Conoscevo un tizio, anni fa, che sosteneva di abitare nel suo zainetto. Un modo buffo per dire che lo considerava la sua vera casa, l’estremo rifugio, il luogo più intimo dove trovare asilo. Non che fosse privo di abitazione, con tanto di letto, fornelli e doccia; solo che non ci si sentiva a suo agio come quando partiva e viaggiava, o anche semplicemente girovagava per la città. Con lo zainetto sempre in spalla portava con sé ciò che gli stava più a cuore, tutta roba poco ingombrante che non si identificava con le cose supposte indispensabili (spazzolino da denti, ricambio di biancheria) ma con ciò che gli piaceva avere sempre a disposizione (il walkman, un paio di libri, alcune fotografie). Un hippy fuori tempo massimo? Macché: semmai qualcuno che aveva capito prima di tanti altri come stava girando il vento, e cioè verso dove, senza accorgercene, ci stavamo tutti dirigendo, e dove siamo da tempo giunti: una società senza radici e senza ubicazioni fisse, in perenne movimento e trasformazione, dove il nomadismo – al netto di confinamenti e altre forme di pervicace territorializzazione – è divenuto, se non un’abitudine, una necessità, un valore, una diffusissima forma di vita.
Che avesse letto Marshall Sahlins? Riprendendo in mano L’economia dell’età della pietra finalmente ripubblicato da Elèuthera (prefazione di David Graeber, cura e postfazione di Roberto Marchionati, pp. 452, € 25) viene fuori che il celebre ritratto dell’uomo paleolitico disegnato dal grande antropologo americano era un prototipo esemplare di questo spensierato signore e dei suoi numerosi avatar. Non sarà del tutto un caso, come ricordano prefatore e curatore, se la prima edizione di questo testo ormai classico dell’antropologia economica sia stata pubblicata a Chicago nel 1972: dunque un libro scritto negli anni d’oro della contestazione giovanile americana, della lotta alla guerra nel Vietnam, della rivendicazione dei diritti civili e quant’altro. L’idea di una forma di vita alternativa, tendenzialmente lontana dallo spirito accaparratore del capitalismo e perciò aperta, vagabonda, erratica, si coniuga perfettamente con l’immagine di un uomo preistorico che, nomade, sa badare a se stesso dovunque si trovi, sentendosi dappertutto a casa propria, con pochi beni e tanto tempo libero per riposarsi o spassarsela. I paleolitici, dunque, tutti peace and love? Una battuta non del tutto peregrina.
Stone Age Economics, questo il titolo originale del volume, è un libro gioioso, scritto – si capisce – con passione militante, intento politico. Ed è tanto più engagé quanto più è serio, rigoroso, profondo. Leggibilissimo. La tesi di base, diametralmente opposta a quella dell’antropologia mainstream, è abbastanza semplice, ma le sue conseguenze sono, ancor oggi, assai importanti.
Ricorda Sahlins come molte indagini etnologiche sul campo presso diverse etnie del pianeta, diverse tra loro ma tutte a loro modo comparabili agli abitanti del Paleolitico (aborigeni australiani, Boscimani del Kalahari e parecchie altre etnie dal Labrador alla Terra del Fuoco, dalle Fiji alla Nuova Guinea), tendano a smentire la tesi antropologica tradizionale secondo la quale l’economia all’età della pietra fosse di pura sussistenza: da cui una vita piena di disagi perché condizionata dalla scarsità di risorse, da una continua ansia per accaparrarsi di che nutrirsi, e perciò da una perenne fame di fondo.
L’uomo paleolitico, secondo l’ipotesi abituale, sarebbe stato una specie di sfigato cronico: privo dei mezzi tecnici adeguati, non sarebbe mai riuscito a far fronte all’insufficienza dei beni a sua disposizione, restando in un stato di precarietà che permeava l’intera sua esistenza. Da cui le peregrinazioni in cerca di acqua e di cibo, lo stremante nomadismo. Ma una tale visione del mondo, secondo Sahlins, è vittima del pregiudizio etnocentrico che proietta le nostre moderne categorie economiche (ossia, in fin dei conti, l’idea dell’accumulazione capitalistica, della massimizzazione pianificata dei profitti, della vita dedicata al lavoro) su una realtà che non può recepirle perché impregnata d’altri valori, d’altri orizzonti di pensiero e d’azione.
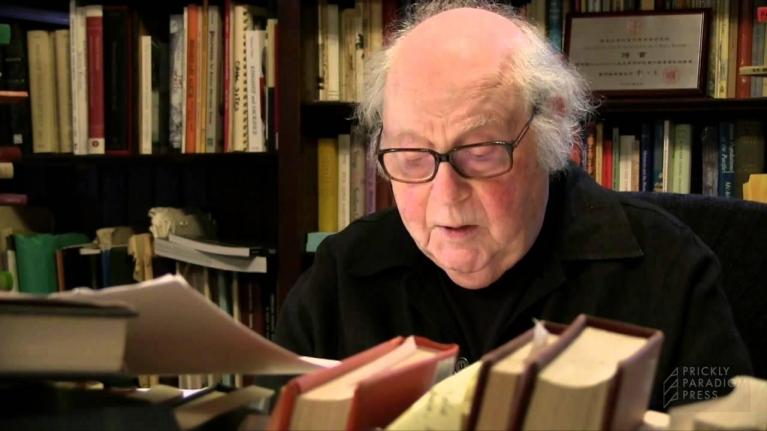
L’uomo paleolitico, ricorda Sahlins, non viaggiava per necessità ma per euforica abitudine: cacciava e raccoglieva giusto il necessario per sfamarsi, per il resto della giornata riposava, chiacchierava coi vicini, danzava, fumava, trascorrendo a suo piacimento l’enorme quantità di tempo libero a sua disposizione. Quando le risorse in zona terminavano si spostava altrove, portando con sé poche leggere suppellettili, ricacciava e riraccoglieva l’essenziale, e poi di nuovo a oziare. Altro che vita di stenti: desiderando pochissimo era più che felice, di modo che qualsiasi cosa ostacolasse questo stile di vita lietamente nomade (robe ingombranti, riserve di cibo, oggetti superflui) veniva gettata via. Sembra il ritratto del tizio con lo zainetto. La sua, ne conclude Sahlins, era un’economia della ricchezza, la ricchezza di non desiderare alcun surplus materiale: insomma, una “via zen all’opulenza” o, se si vuole, una prassi strategica della pigrizia vincente. Ben riassume Graeber: “Nel Paleolitico – un’era che peraltro costituisce il 90% della storia umana – la vita non è mai stata una lotta per l’esistenza. Infatti, per gran parte della loro storia gli esseri umani hanno vissuto una vita di grande abbondanza materiale. Questo perché l’‘abbondanza’ non è un valore assoluto: c’è abbondanza quando si ha facile accesso a una gran quantità di cose che si desiderano o che si ritengono necessarie. In rapporto ai loro bisogni, la maggior parte dei cacciatori-raccoglitori è ricca. E soprattutto, il loro orario lavorativo susciterebbe l’invidia di qualsiasi schiavo salariato moderno”. Arrivando poi il Neolitico, tutto è cambiato: allevamento, agricoltura, lavorazione dei metalli, manifattura della ceramica, cottura dei cibi…: uno stress – che molte popolazioni, non a caso, hanno a lungo rifiutato.
Le lunghe descrizioni dell’esistenza paciosa e godereccia del cacciatore-raccoglitore presenti nel libro sono al tempo stesso esilaranti e durissime: val la pena leggerle per intero. Sono esilaranti perché sorprendenti nella loro icasticità. Durissime perché sferrano un attacco senza sconti non solo all’antropologia evoluzionista carica di etnocentrismo, ma, più in profondità, al cosiddetto razionalismo economico che – tornando all’oggi – si continua troppo spesso a considerare l’unica forma possibile di organizzazione dell’esistenza umana e sociale. Non c’è, sottolinea Sahlins, da un lato una razionalità presunta universale, identificabile con i principi basici di quella scienza triste che è l’economia, e dall’altro le varie culture, pregne di pregiudizi e insensatezze varie. Ci sono semmai varie forme di razionalità che s’innestano in varie culture, essendone parte costitutiva. “La razionalità – scrive – opera all’interno di un ordine culturale relativo che a sua volta ha una logica propria”. Tutto il resto è mistificazione autocelebrativa dell’Occidente, un Occidente che, autorappresentandosi come logico e razionale, mal nasconde le sue proprie esigenze culturali, le proprie forme non utilitaristiche di comportamento, i propri valori esistenziali e ludici. Sahlins fa l’esempio del supermercato: andando a far la spesa, adoperiamo sempre e comunque criteri razionali basati sul bisogno? Certamente no. Scegliamo piuttosto seguendo criteri simbolici anche molti diversificati fra loro, come la differenza, l’estetica, lo sfizio, il divertimento, la curiosità…
Una prospettiva teorica fondata sul relativismo culturale? Se così fosse, non ci sarebbe l’intento politico che dicevamo. L’operazione di Sahlins non è quella di dire che anything goes, e che il nomadismo paleolitico vale come le passeggiate del flaneur benjaminiano o le avventure di Marcovaldo al supermarket. Molto diversamente per Sahlins, in questo seguace di Marcel Mauss e di Karl Polanyi, i sistemi culturali, per quanto costitutivamente diversi, hanno comunque delle zone di permeabilità che ne permettono continue ibridazioni e che, proprio per questo, possono – e devono – essere confrontati fra loro, soppesati, messi in dialogo e in contrasto, proprio per decidere cosa è meglio e cosa peggio, verso dove puntare e che cosa escludere. In altre parole: l’uomo paleolitico ha tanto da insegnare all’uomo moderno, e più ancora a quello postmoderno, postmediatico o come altro lo si voglia definire. Lo aveva capito il mio amico giramondo che faceva dello zainetto la sua umile dimora. Lo stiamo capendo tutti quanti, adesso, costretti in lockdown di cui non cessiamo di fiutare l’ambiguità.