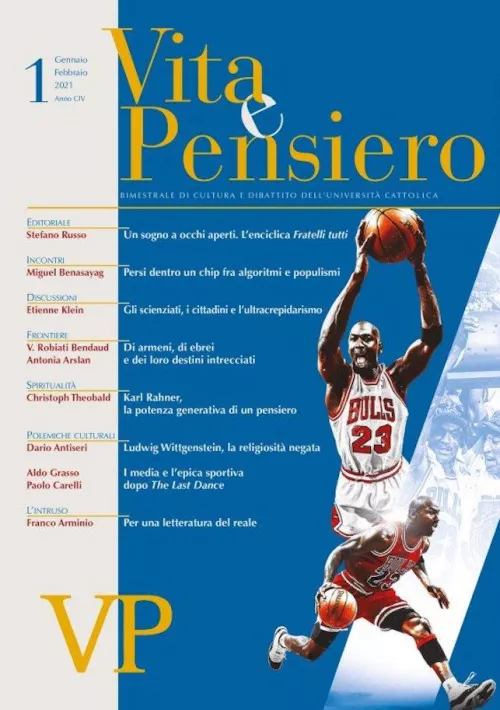Epistemologia virale / La scienza pensa?
Nel cuore della tragedia pandemica – ha osservato il filosofo della scienza Etienne Klein (Vita e pensiero, n. 1, 2021) –, vi è stata l’opportunità rara di svolgere un’opera di divulgazione sulle procedure della metodologia scientifica. Al di sotto del baccano assordante di tanti dibattiti, qualche voce accorta ha cercato di chiarire cosa fossero un esperimento a doppio cieco o randomizzato, quale fosse la differenza fra una correlazione e una relazione di causa-effetto, ha spiegato come fare buon uso delle statistiche. Sforzi tanto più meritevoli nel nostro paese, dove il preoccupante analfabetismo di ritorno si allea talvolta con l’atavica diffidenza verso il sapere scientifico (anche negli ambienti “culturali”).
Nell’esplorare l’ignoto o il poco noto, la ricerca scientifica, soprattutto in ambito terapeutico, richiede un lungo e paziente lavoro di analisi, di sperimentazioni e controlli; confronti serrati e critiche severe devono (dovrebbero) intrecciarsi fra ricercatori di molteplici laboratori, nel lavoro collettivo che si svolge all’interno della comunità o della città scientifica, come la chiamava Gaston Bachelard. Quel che abbiamo sperimentato in questi due anni è che la ricerca del vaccino anti-Covid può restare a lungo immersa nel chiaroscuro delle incertezze, conoscere tentennamenti ed errori. E non sempre si tratta degli errori “giusti” che, come vorrebbe l’epistemologia popperiana, confutando le prime congetture riorientano la ricerca verso strade più proficue.
Purtroppo anche qualche esperto ha dimenticato che la temporalità della ricerca scientifica non obbedisce alla logica implacabile dell’immediato, cara ai media e ai social network, all’impazienza di massa che attende risposte rassicuranti. A rileggere oggi alcuni annunci precipitosi dei primi mesi di pandemia sull’efficacia dei farmaci o della prima dose del vaccino, vien da pensare che si desse risposta al bisogno diffuso di rassicurazione collettiva più che alla ragione procedurale del sapere efficace. Certo, lo scienziato non ha mai avuto vita facile nei confronti del ciarlatano: nella Psicologia delle folle del 1895 Gustave Le Bon rievocava un episodio della sua infanzia. Un imbonitore in vesti dorate, accompagnato da un corteo di suonatori, vendeva un elisir che guariva tutte le malattie e assicurava la felicità; le argomentazioni del farmacista, che nel preparato ha trovato solo un composto di acqua e zucchero, non riescono a smuovere quell’elemento irrazionale che induce gli ingenui all’acquisto dell’elisir: la speranza. “I preti di tutti i culti, i politici di tutti i tempi, hanno mai venduto qualcosa di diverso?”.
Nei tempi del sapere diffuso attraverso la rete, la diffidenza nei confronti degli “esperti” si è fatta ancor più spietata e si è rafforzato, osservava Klein, quel vezzo che già la formula latina stigmatizzava: Sutor, ne ultra crepidam (“Ciabattino, non andare più su delle scarpe”, la cui variante milanese, rivolta al pasticciere, suona “Ofelè, fa el to mesté”). E l’ultracrepidarismo, la tendenza diffusa a parlare con supponenza di argomenti che non si conoscono, si salda al noto effetto “Dunning-Kruger”, dal nome dei due psicologi americani che lo hanno tematizzato: la distorsione cognitiva per cui occorre competenza per riconoscere la propria ignoranza, mentre l’ignoranza fa crescere la presunzione di competenza.
A complicare il quadro, vi è il contesto epocale, la forma di potere post-moderna che si esercita sulla vita, a cui, sulla scia di Michel Foucault (nel corso tenuto al Collège de France nel 1976, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, 2005), diamo il nome di biopotere. Nel tempo in cui il nuovo “diritto di sovranità” si esprime come capacità di “far vivere”, il sapere medico, ormai in grado di intervenire sui processi biologici delle popolazioni, finisce per giustificare le norme che, da un lato, rispondono alla domanda crescente di salute degli individui e, dall’altro, nutrono la gestione “disciplinare” delle popolazioni. Diceva Louis Pasteur: “Se soffri, mi appartieni, e io ti darò sollievo”: una formula che suona conferma del legame, suggerito dall’etimo (il germanico var), fra guarire, guardare, proteggere e difendere anche in senso militare, un senso conservato nel desueto termine di “garitta”.
La preoccupazione per la “vita sana”, ricordava lo psicanalista Miguel Benasayag (La salute ad ogni costo. Medicina e biopotere, Vita e Pensiero, 2010), ci rende disponibili ad accogliere tutte le indicazioni terapeutiche: smettere di fumare, evitare zuccheri e grassi, aumentare frutta e verdura, fare sport, ecc. Il che non ci ha resi sudditi obbedienti (spetta pur sempre a noi scegliere quale regime di vita adottare), semmai ha accentuato il senso di responsabilità (se non di colpa) nei confronti dei danni che possiamo infliggere a noi stessi per aver mal gestito il nostro capitale-salute e, soprattutto in tempi di trasmissione virale, per la minaccia potenziale che rappresentiamo per gli altri.
La “diagnosi” di Benasayag accentuava una prospettiva critica nella quale si avvertivano gli echi della Nemesi medica di Ivan Illich (Mondadori, 1977): benché non sia mai stata tanto potente, paradossalmente la medicina appare a molti lontana dal suo obiettivo storico di vincere la malattia. Anche in buona salute, ci viviamo come malati potenziali e la nostra esistenza somiglia sempre più a una storia clinica; in età matura finiamo spesso per convivere con patologie che oggi il sapere/potere della medicina è in grado di tenere a lungo sotto controllo, dal diabete ai disturbi circolatori, fino ai tumori. Più che la sperata vittoria nella “guerra contro la malattia”, sembra di assistere a una tregua prolungata, in cui l’ombra della patologia non smette di perseguitarci.
Viene da chiedersi se i tanti proclami di un fiducioso avvenire per la salute dell’umanità non abbiano creato un orizzonte d’attesa che, oltre a rimuovere le nostre relazioni con la natura e i suoi vincoli, ha indotto a dimenticare anche la nostra storia, come se le catastrofi pandemiche del passato non ci potessero più colpire. Ma dovremmo anche rivedere l’immagine “euforica” della scienza come istanza portatrice di verità consolidate, per dare maggior spazio a quel che Karl Popper ha espresso con la formula che dà il titolo alla sua autobiografia: “la ricerca non ha fine”. Italo Calvino osservava che l’atteggiamento scientifico condivide con quello poetico lo spirito di progettazione, di scoperta e d’invenzione. La scienza “costruisce modelli del mondo continuamente messi in crisi” e il suo esempio è prezioso per la “paziente modestia di considerare ogni risultato come facente parte di una serie forse infinita d’approssimazioni”. Una visione della razionalità “incerta” che si costruisce progressivamente, sorretta dal ricorso al dubbio e dal riconoscimento del chiaroscuro in cui si muove, potrebbe servire da antidoto alle tante forme di avversione nei confronti della scienza.
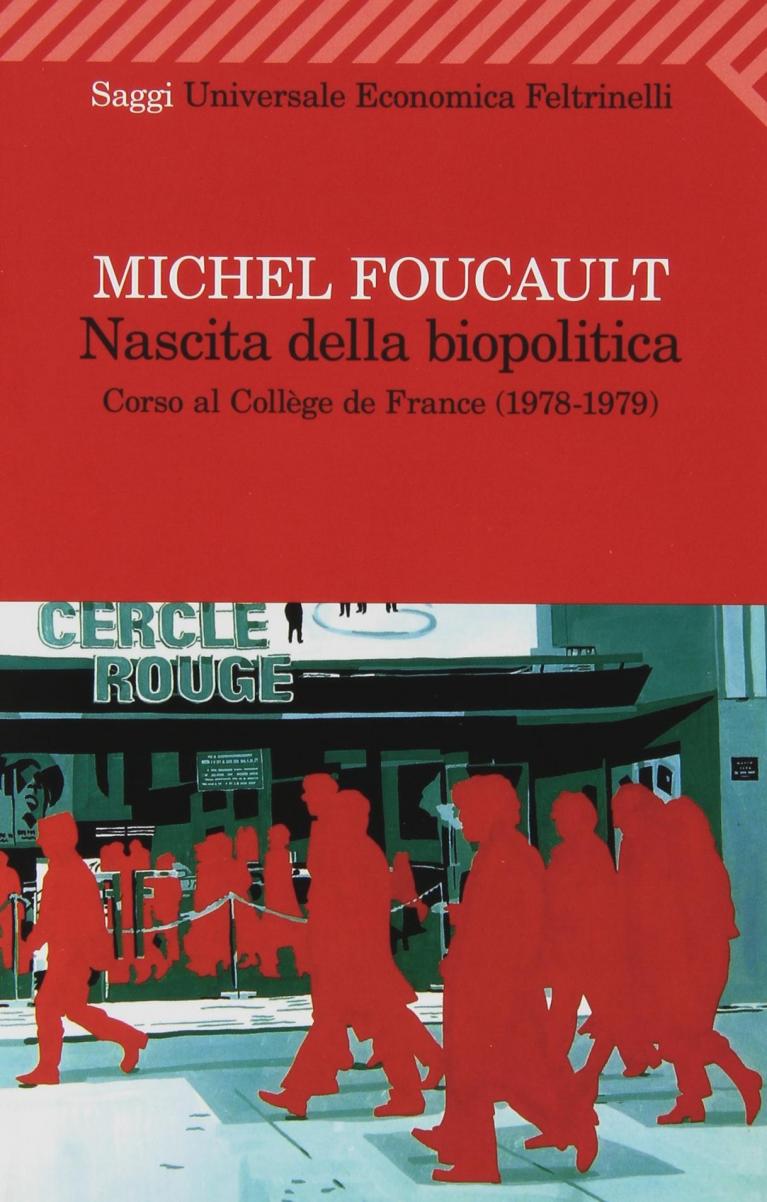
La formula di Heidegger, “la scienza non pensa”, ha trovato da noi un terreno già dissodato dai lasciti del neoidealismo, dalla convinzione che la scienza abbia solo scopi pratici, non sia né formativa né inventiva. Andrebbe ricordato però che il passo di Che cos’è la metafisica, pur nella protervia a cui la filosofia spesso non riesce a rinunciare (e che rende talora sgraditi i filosofi), non invitava a disinteressarsi delle scienze: “proprio perché la scienza non pensa, il pensiero deve nella situazione attuale prestare insistentemente attenzione alle scienze – ciò che esse non sanno fare per loro conto”. Interessandosi solo dell’ente, rinchiuso nei parametri oggettivanti della ragione calcolante, la scienza non coglierebbe il fondo senza fondo, abissale (Abgrund), in cui l’ente pur sempre si radica, quell’Essere che, nell’esporsi degli enti, non si rivela che ritirandosi. Per prestare “ascolto” all’Essere, si finisce però per restare sordi alla forme che la razionalità assume, ai mutati criteri di verità (o veridizione, per dirla con Foucault) e purtroppo, in qualche caso, anche al dolore degli uomini. E si rischia di bloccarsi su posizioni che sono in ritardo di qualche generazione rispetto al divenire delle scienze.
Si ribadisce così l’antico contrasto aristotelico fra tecnica e natura, si guarda alla natura in una prospettiva pre-ecologica, ci si affida ad un’antropologia pre-darwiniana e pre-etologica, ancora debitrice dell’umanesimo classico, invischiato nello “scarto ontologico” fra natura e cultura, fra umano e animale. Si pretende di applicare rigidamente il buonsenso popperiano della falsificabilità, i cui criteri di prevedibilità e controllabilità piena valgono al più per le teorie semplificatrici della scienza classica, ma appaiono deboli quando si entra nell’ambito biologico e dell’umano, ancor più nella medicina. Popper aveva gioco facile quando si scagliava contro la psicoanalisi e il marxismo, ma era rimasto incerto nel valutare la scientificità dell’evoluzionismo.
Alla formula “la scienza non pensa” preferisco quella suggerita da Gaston Bachelard, “è la scienza ad istruire la ragione”. Proprio dalla scuola di Bachelard e di Georges Canguilhem proveniva François Dagognet (1924-2020), medico e filosofo, indagatore “obliquo” dei modi in cui la ragione si è incarnata nelle materie (in chimica e biologia, nelle arti plastiche e nelle tecniche, nelle forme e nelle immagini del Paese d’Enciclopedia). Un “materiologo” più che un materialista, diceva di se stesso, un pensatore dal progetto ambizioso: quello di una filosofia che, prendendo distanza dallo psicologismo e dall’intimismo, sveli come la molteplicità variegata delle materie si è arricchita e complicata, anche grazie al contributo della scienza, “la grande produttrice d’essere”. La traiettoria della ragione passa attraverso la materialità: non può conoscersi a vuoto, deve transitare attraverso i successi e i fallimenti davanti alle cose, “l’uomo non conosce che quel che può trasformare”. Con ben maggiore risolutezza rispetto al progetto di Husserl, Dagognet poteva affermare che “la filosofia deve andare risolutamente alle ‘cose’ e lasciarsene penetrare”.
È quanto già mostra la sua tesi di dottorato ès Lettres, La ragione e i rimedi. Saggio sull’immaginario e il reale nella terapeutica contemporanea (Puf, 1964). Un testo che oggi ci appare datato in virtù degli enormi sviluppi che il sapere e la tecnologia medica hanno compiuto negli ultimi cinquant’anni, ma su cui merita tornare perché muove dal proposito di concettualizzare il potere della materia medica per eccellenza, il farmaco. Sulla scia del Bachelard della Formazione dello spirito scientifico (1938, Cortina, 1995), Dagognet indaga l’evoluzione storica dei medicinali, un campo che ha conosciuto terapie molteplici e pittoresche, dal quale non si cancellano archetipi profondi, sedimentati da proiezioni inconsce. L’immaginario della malattia non si separa mai del tutto dallo sfondo emotivo che evoca il male e i suoi fantasmi religiosi; si conserva in noi il lascito arcaico dell’intromissione nociva che bisogna cacciare dal corpo “posseduto”, mentre il rimedio che interviene sul corpo mantiene l’ombra della profanazione.
Gli atti che riguardano la terapeutica vivono sur-determinazione (usando il lessico di Bachelard), faticano a emanciparsi da antichi pregiudizi; ancor più nel caso dell’infezione causata da germi o virus, perché nulla alimenta terrori e deliri più dell’insinuante. Il latino infectus significa guasto, corrotto, in origine per la forza espansiva di esalazioni nauseabonde, fetori e miasmi. Ancora per Pasteur la malattia è invasione, l’organismo è infestato (infestare equivale ad attaccare e perseguitare) come fanno le erbe cattive nelle terre coltivate. Si finirà poi per conservare il primo termine, infectus (da inficere, avvelenare e impregnare), pur attribuendogli il significato del secondo (infestus, ostile, aggressivo). La microbiologia attizza la fobia del nemico camuffato e ubiquo, sornione e prolifico, pronto all’assalto. Lo schema marziale, l’arcaico manicheismo di un’aggressività venuta insidiosamente dall’esterno, fatica a cancellarsi, anche quando con la vaccinazione la terapeutica anti-infettiva non si scaglia più contro l’invasore, si colloca provvisoriamente dalla parte del male contro il malato, ma a profitto di quest’ultimo. La farmacologia ha imparato che dal male si estrae il rimedio, la terapeutica efficace utilizza i suoi nemici per giungere alla vittoria.
È attraverso gli erramenti del passato che la filosofia deve transitare, perché, per un autentico razionalismo, sostiene Dagognet, è l’errore a definire da principio la verità e non esiste un campo d’esperienza in cui l’errore sia fiorito così in abbondanza; “nel falso, se non nell’insensato, il vero già si mette alla prova e si cerca”. Ancor oggi, quando l’industria farmaceutica non ha del tutto abbandonato la dipendenza dall’universo arboreo, restano persistenti le illusioni taumaturgiche nelle virtù dei rimedi “naturali”. Natura sola medicatrix, recitava il detto ippocratico, attribuendo all’organismo poteri innati di guarigione.
Questa medicina naturalista, nel proporsi di restituire un’armonia perduta, si è saldata con la fede nei poteri di agenti naturali, minerali o vegetali. Ma la Natura ingloba tutto, il migliore e il peggiore, ricorda Dagognet; una stessa sostanza può essere dannosa e benefica, tossica e salvatrice (non è forse questo fin dall’origine l’essere di quella materia equivoca che è il pharmakon, veleno e rimedio?). La presunta saggezza della Natura dimentica l’importanza della posologia e del dosaggio; ogni rimedio ha bisogno dei suoi modi d’incorporazione, richiede il rispetto di esigenze materiali di assorbimento: “La materia, per rivelarsi, demande une manière”. Se la Natura possiede un rimedio curativo ne nasconde le tracce; il farmaco non si raccoglie, si produce, se ne costruisce l’edificio molecolare, magari isolando il principio attivo da materie organiche. Ci sono voluti anni fra la scoperta che la coltura di un fungo, penicillium notatum, impedisce lo sviluppo di germi e l’utilizzo dell’antibiotico; la penicillina (Fleming, 1929) sembra ancora legata all’antico naturalismo, ma in realtà è un caso esemplare di una chimica innestata su di un naturalismo elaborato.
Talvolta la farmacologia ha posseduto un potere a cui non corrispondeva un sapere. L’inoculazione contro il vaiolo è già praticata nel Settecento, per volontà di Maria Teresa d’Austria e di lady Montagu; la vaccinazione precede di molti secoli la batteriologia che la fonda e la spiega, ed assume statuto di scienza solo a metà Ottocento, grazie soprattutto a Pasteur. L’umanità è riuscita a estinguere gran parte dei flagelli che la decimavano, spesso senza neppure conoscere il volto e la forma dei suoi nemici. Nelle Filippine, i Cinesi rispettavano la tradizione di bere thè solo in acqua bollita, non sapendo che questo li risparmiava dal colera che sterminava i locali. Gli Indiani d’America conoscevano gli effetti benefici del chinino e dell’ipeca, ben prima che si sapesse cosa fosse il paludismo o la dissenteria amebica che quei vegetali curavano. Il potere talvolta precede il sapere. Ma il rimedio ha imparato sempre più a limitarsi, a controllare la sua potenza, ad agire contro i suoi possibili danni: senza un sapere, il potere diventa lo strumento di un cattivo e pericoloso volere.
Come la corporeità, sorgente infinità di significati, anche la terapeutica, terra del fantastico, del positivo sperimentato e dell’inventiva, ci introduce in un mondo più culturale che naturale, che la filosofia dovrebbe celebrare, non disprezzare. Qui non ci si muove nel “materialismo razionale” della chimica, esaminato da Bachelard, dove regna quasi incontrastata la coerenza delle sostanze; nella farmacologia abbiamo una materia percorsa da speranze e disillusioni, sempre alla ricerca di sé, oppressa dalle “miserie” della sperimentazione ininterrotta, dei riferimenti sensibili, dei controlli fastidiosi. È un razionalismo impedito, suggerisce Dagognet, dove lo stesso o il simile producono l’altro, i dissimili possono generare l’identico, dove l’alogicità sembra sfidare le regole elementari della spiegazione. Il farmaco resta il beneficio maggiore e più umano che ci sia; eppure, conserva sempre un che di equivoco, ombre di contingenze, frange d’indeterminazione.
Anche quando nasce nella luce del sapere rigoroso, il divenire del farmaco rischia sempre di intorbidare la limpidezza originaria. E in terapeutica quel che conta è il poter-essere: l’essere del farmaco esiste solo in ragione dei suoi effetti o delle sue virtù e rimane uno scarto (sempre più trascurabile?) nel passaggio dalla previsione originaria in laboratorio all’applicazione sugli umani. Non sempre è facile affermare che un certo farmaco, a una certa dose assunta con rigore, avrà esattamente determinati effetti. La guarigione sfugge alla conoscenza astorica del laboratorio, anche se oggi possiamo attenuare il giudizio di Dagognet: “Il criterio della guarigione e del successo terapeutico manca sorprendentemente di rigore”. Qui i parametri dell’oggettività sono scompaginati da fattori molteplici: il decorso temporale, intolleranze e assuefazioni individuali, la dimensione esistenziale della relazione medico-paziente, oltre alla “risonanza” che prova chi ne beneficia. Il farmaco, mondo del “fugace e del labile”, non obbedisce alla riposante ontologia di un “in sé” definitivo: non esiste un’entità immutabile, il rimedio vive una sua dinamica che numerosi fattori, non sempre riducibili a parametri numerici, relativizzano.
Il leitmotiv di La ragione e i rimedi è il rifiuto del sostanzialismo assoluto che vorrebbe definire l’essenza del farmaco, un farmaco noumenale che avrebbe in sé una serie di effetti costanti e infallibili. Qui siamo nel regno del probabile, non in quello della necessità e dell’assoluta certezza. L’episteme del farmaco è lontana dall’universo monotono e prevedibile delle traiettorie della meccanica newtoniana, non è quella delle scienze dure, si apparenta invece agli altri saperi che caratterizzano l’età contemporanea, gli ambiti incerti delle scienze della vita, dell’ecologia o della meteorologia. Gli effetti che suscita il farmaco sono mutevoli, suggestioni e componenti psichiche non totalmente eliminabili possono intorbidarli e turbarli. Nella dinamica curativa non si deve forse ricorrere all’utilizzo di test a doppio cieco in cui non solo i pazienti ma anche gli operatori ignorano se è stato iniettato un farmaco o un placebo, l’elemento che prende a prestito le forme del reale, menzogna che simula il vero più che deformarlo? La terapia antica utilizzava quasi esclusivamente placebo credendoli onnipotenti, la farmacologia contemporanea vede il quasi falso operare il successo di ieri e cerca di cogliere nel vero attuale il possibile intervento del falso.
Al declino del rimedio assoluto corrisponde l’esistenza indiscutibile della dinamica curativa, di un processo – che già Dagognet diceva complesso – nel corso del quale la sperimentazione è chiamata a cogliere quel che non si conosce a priori, gli impercettibili apparentemente trascurabili, a interpretare risposte equivoche, segnali di non immediata lettura, che talora si manifesteranno nel tempo. Nulla qui è di totale chiarezza né infallibile; soltanto il divenire umano del rimedio rivelerà il suo essere, ma la razionalità della terapia è progressiva, anche nel senso che la dinamica della farmacologia procede verso la riduzione degli imprevisti. Il farmaco ha valore inizialmente di ipotesi passata al vaglio di tutti i test possibili, di controlli e verifiche, ma resta una congettura che va in cerca di confutazioni, nell’attesa di operare una legittima universalizzazione. Ed è proprio la difficoltà di predeterminare l’efficacia del rimedio a favorire l’invenzione di metodologie nuove, ad arricchire la materia medica.