L’incanto del lotto 49
A settembre saranno dieci gli anni trascorsi dall’ultimo romanzo di Thomas Pynchon, La cresta dell’onda, che è stato il nono titolo di una sorta di collana di denuncia e riflessione sull’America come anche sulla condizione umana. L’ottantaseienne autore di Long Island ci ha abituati alle lunghe attese, ma non ai cambi di sistema, se – al di là dei mutamenti di rotta annunciati puntualmente dalla critica a ogni libro – anche Vineland, del 1990, uscito diciassette anni dopo L’arcobaleno della gravità e considerato, forse perché posto in mezzo alla sua attività letteraria, uno spartiacque tra narrativa postmoderna e tradizionale, non reitera che lo stesso modello invariato delle fabulae complicate ed esorbitanti di digressioni, dei personaggi con nomi da cartoons, degli intrecci traboccanti di analessi, qui con minore attenzione magari per l’entropia apocalittica, il grande totem di Pynchon, ma con immutato spirito paranoico presente anch’esso come un rumore di fondo in ogni romanzo. Spirito che per lo scrittore è proprio dell’uomo contemporaneo, esonerato com’è dal rendere conto delle sue decisioni, giacché la volontà è determinata dalla congerie del caos probabilistico che muove le azioni umane in linea con le teorie della fisica quantistica, adottate da Pynchon al pari di un criterio di condotta comportamentale e sociale oltre che quale fonte di ispirazione.
Lontano come Salinger dalla ribalta, scrittore appartato ed elusivo caro ai lettori millennials e generazione Zeta per la sua vena narrativa capace di coniugare noir, science fiction, fumetto e trame cospirative entro un geyser che esalta pastiche, nonsense, iperboli e divagazioni, chissà che l’autore ritenuto caposcuola del postmoderno non sia impegnato in un decimo romanzo: non fosse che per soddisfare la sua ossessione per i numeri rotondi, la simmetria, la combinazione tra calendario e diario. Un romanzo of course gigantesco, tentacolare, straripante di personaggi tutti privi di una personalità e di un carattere, marionette nelle mani di complottisti, grandi vecchi, potenti di Stato ed eccentrici tycoon come figurano nei titoli dell’intero suo catalogo.
Come John Fante, anche Thomas Pynchon è in Italia un autore di culto (prova ne siano la scelta di Sandro Veronesi di inaugurare la sua “Americana” per il Corriere della sera proprio con Vineland e la decisione della Einaudi di ristampare dopo diciotto anni L’incanto del lotto 49) e lo è in forza del disposto tra realtà e fantasia cui egli ama indulgere fino a toccare punte di visionario surrealismo, quale fu la sua più viva passione da studente. Nella celebre Introduzione alla raccolta dei suoi cinque racconti Un lungo apprendistato che è del 1984, dove l’autore quasi cinquantenne giudica il suo giovanile tirocinio, in gran parte bocciandolo, spiega la propria primigenia vocazione richiamando l’attrazione verso i surrealisti: “Rimasi affascinato dall’idea di poter combinare all’interno della cornice elementi che di norma non si trovano insieme, creando effetti illogici e sorprendenti. Quel che dovetti apprendere più tardi fu la necessità di modulare tale procedimento con un minimo di cura e di ragione: non è che qualsiasi combinazione di particolari andasse a bersaglio”.
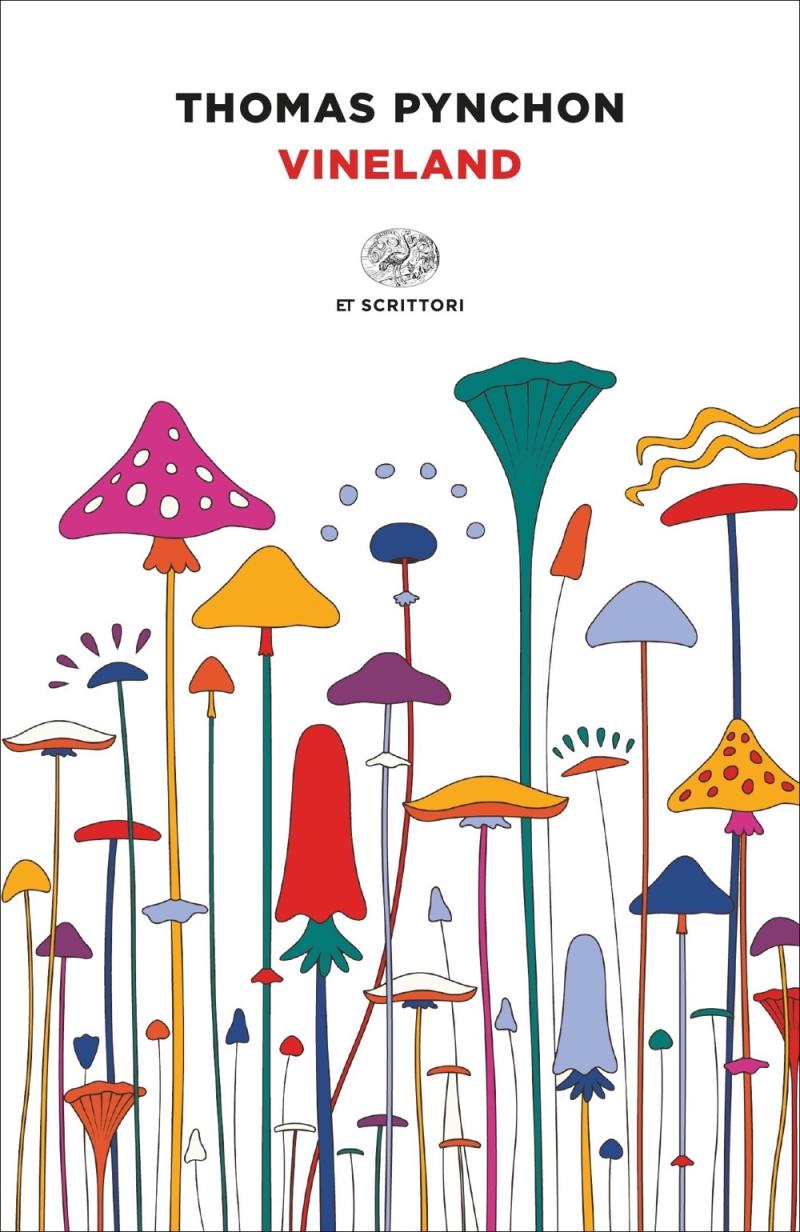
Ma tale propensione all’effetto combinatorio, nel solco di un principio di contaminazione che è il nerbo del postmoderno e spinge verso una visione astratta, deve fare i conti nel giovane Pynchon con l’inclinazione di pari forza al dato più strettamente reale, sicché ammette nella sua Introduzione e in assoluta contraddizione, secondo un concezione molteplice della letteratura che non lo lascerà più: “A un certo punto avevo concluso che la vita personale di un individuo non c’entra niente con l’invenzione letteraria, quando, lo sanno tutti, la verità è esattamente l’opposto. Per di più ero circondato da prove contrarie, anche se deliberai di ignorarle, perché in realtà la narrativa che allora come ora più mi commuove e incontra il mio gusto è proprio quella che prende luce e verità innegabile dal fatto di essere stata trovata e attinta nei livelli più profondi e condivisi della vita reale che viviamo tutti”.
E allora? Pynchon è un antirealista che ama l’illogico e il sorprendente oppure un realista, sia pure psicomachico, portato a cogliere luce e verità scavando nell’animo umano? Come arriva a scalare due côté così antitetici è il segreto della sua cifra quanto a soggetto e a stile. Alla fine, non riuscendo a risolvere la dicotomia, accoglie entrambe le posizioni e ne fa un tout de même originalissimo e personale. I suoi romanzi risentono dei labirinti bibliomantici e cerebrali di Borges come delle atmosfere cospirazioniste di Umberto Eco e dell’ironia beffarda di Woody Allen (che c’è tutto nel poliziotto de L’incanto del lotto 49 quando chiede a Oedipa ostaggio nelle mani di un invasato come si scrive il suo nome per comunicarlo ai giornalisti), non ricercano né il lieto fine né la conclusione chiusa e si tengono sempre su un piano di continua verifica di verità e valori nel proposito di smascherare la menzogna e la falsità. Tale configurazione è figlia di un percorso partito sin da giovane.
Quando Pynchon, agli inizi degli anni Sessanta, si affaccia infatti alla letteratura, il panorama negli States è segnato dal war novel e da scrittori definiti “modernisti”, perlopiù anche accademici, che hanno ereditato la tradizione ottocentesca e superato la temperie dell’hard boiled di Chandler e Hammett. Sono Bellow, Barth, Updike e soprattutto Norman Mailer, l’autore apripista che nel 1948 ha pubblicato The Naked and the Dead su una pattuglia di fanteria in territorio nemico, romanzo visto come un monumento, che costituiva il primo attacco alle derive delle falsità storiche.
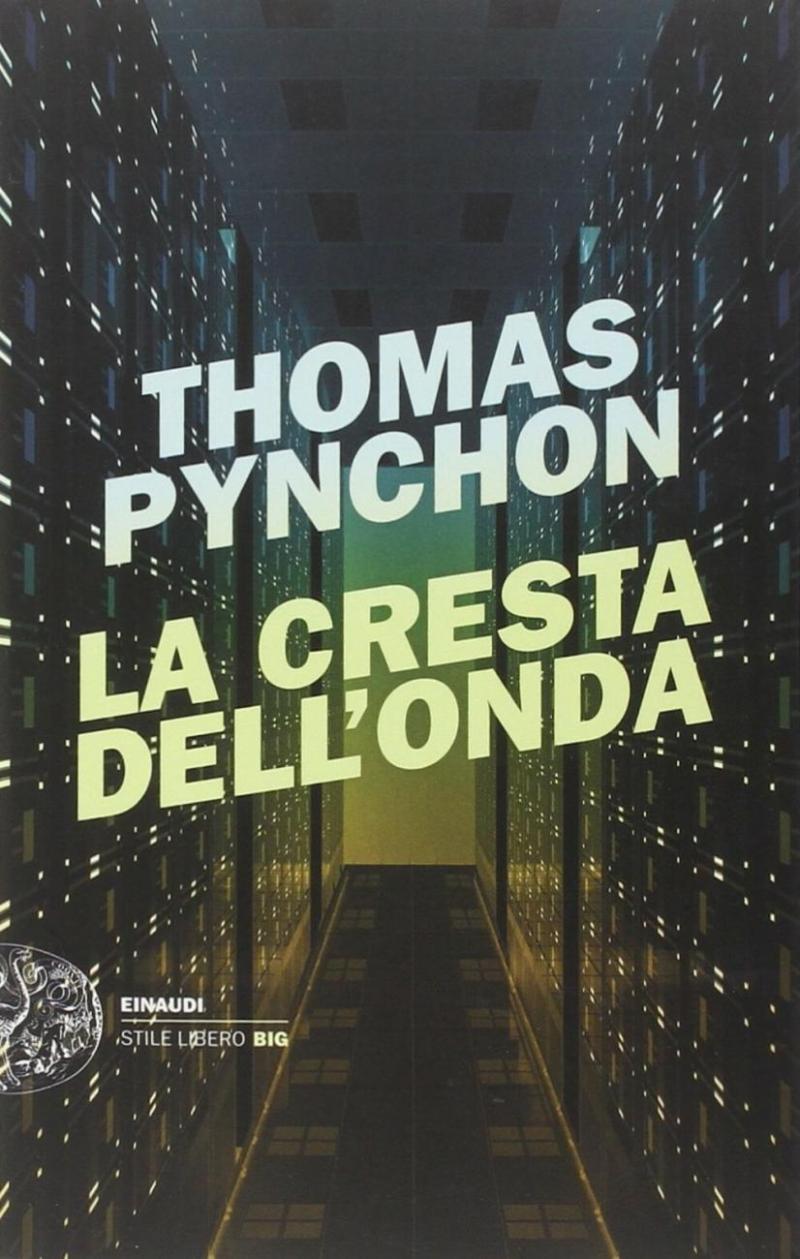
Anche Pynchon ne rimane impressionato, ma a sedurlo sono di più il mondo beat e la musica jazz entro un disegno inteso a rompere le strutture del romanzo tradizionale e modernista. Scriverà nella Introduzione a nome della sua generazione: “Contro l’innegabile forza della tradizione venivamo attratti da suggestioni centrifughe come il saggio di Norman Mailer Il negro bianco, l’ampia disponibilità di dischi jazz e un libro che ancora oggi annovero tra i più grandi romanzi americani: Sulla strada di Jack Kerouac”. Pynchon spiega bene qual è il clima dei giovani scrittori del suo tempo e lo fa ancora nella Introduzione: “Il bop e il rok’n’roll stavano allo swing e al pop postbellico come la nuova scrittura stava alla più consolidata tradizione modernista che ci somministrava l’università”.
Le coordinate sono dunque segnate alla partenza. Pynchon diventa postmoderno, cioè un autore da “territori selvaggi”, perché i postmoderni sono più pronti dei modernisti a sovvertire le regole del romanzo tradizionale e non solo. La lotta è anche contro quegli autori trentisti che hanno fatto del giallo e del mystery il primo piatto del gusto americano, come pure contro quegli scrittori alla Hemingway, alla Faulkner e alla Steinbeck che hanno scelto il vero e il crudo della società e del loro tempo, quando piuttosto la strada del cambiamento, da Burroughs a John Rechy, da Joseph Heller all’ultimo Philip Roth, non può che passare dal noir che offre molte più possibilità di sperimentazione e libertà di manovra nel testo.
In sostanza il postmoderno di Pynchon si caratterizza per la frenetica miscela che fa di reale e antireale nella prospettiva di una progressiva derelizione che risponde a una cosmica entropia del mondo e si consuma in un gurgite apocalittico dove trovano posto la guerra, la ricerca scientifica, la coscienza collettiva votata alla paranoia, le congiure cospirative, l’insignificanza degli individui. Pynchon non ha uno sguardo avveniristico e futurista alla Asimov, non immagina mondi ultraterreni neppure nel suo colossale e fantasioso L’arcobaleno della gravità, ma è al passato che si rivolge revolvendo in esso cambiamenti tanto più incisivi quanto più vede venire meno la fiducia popolare nella verificabilità e nei lieti fini. Il suo è un atteggiamento counterfactual, ovvero inteso a fare controstoria e fact-checking, anche rivalutando i mezzi espressivi e il linguaggio.
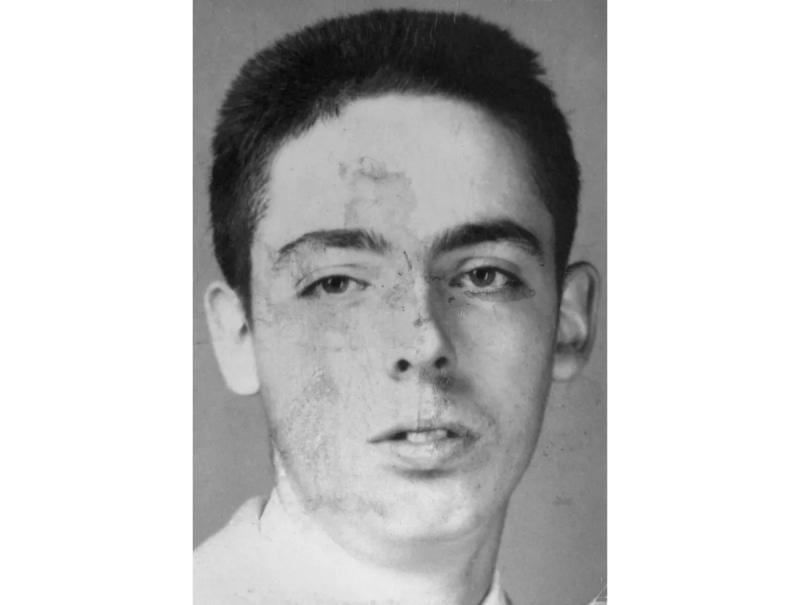
Nel romanzo appena ripubblicato, L’incanto del lotto 49 (che Pynchon considerava però un racconto, e del quale scrisse nella Introduzione di aver dimenticato quanto aveva imparato fino ad allora, perché il personaggio non è fisso e definito ma diventa tale da ricordare un film, in continuo mutamento, “anima nel suo scorrere”: progetto in verità mancato), tale veste è precisata in quella che chiama, quando riporta la trama di un dramma medievale, “renitenza rituale” (nell’originale ritual reluctance), che sarebbe l’ingerenza di un’ambiguità nelle parole pronunciate: “Diventa chiaro – si legge nel romanzo – che certe cose non verranno dette ad alta voce; certi eventi non saranno mostrati sul palcoscenico; per quanto sia difficile immaginare di quali cose mai possa trattarsi”. Il non detto, il detto ambiguo, in altre parole la reticenza più ipocrita, costituisce allora per Pynchon il banco di prova sul quale misurare un tempo e una società chiamati a non mentire e a tenere integri i valori condivisi.
E non a caso il romanzo uscito nel 1966 fa della Parola una propria chiave di volta, costituendosi come febbrile ricerca da parte della protagonista Oedipa Maas (versione femminile dell’enigmatico eroe greco) del significato di un nome, “Tristero”, che rimanda simultaneamente a un complotto secolare e a un mondo sommerso che vanta un proprio sistema di servizio postale utilizzato per scambiare informazioni false, nato nel Duecento tra Milano e Bergamo. Italia ed Europa sono alquanto ricorrenti nell’opera di Pynchon, per via del tema prevalente del romanzo di guerra come documento del recente conflitto mondiale, e lo è anche la mafia. Anzi, Cosa nostra, come si legge nell’originale. Un personaggio ad un certo punto esclama in tono faceto: “I have relatives in Sicily” e lo fa “in comic broken English”. Il traduttore italiano Massimo Bocchiola ha scelto invece di tradire totalmente l’originale traducendo così il passo: “Hopparènti in Siggilia – disse Di Presso con un comico accento siculo”.
Lo stereotipo del siciliano mafioso e grottesco che Pynchon non ha scomodato è stato rilanciato dunque da Bocchiola distorcendo del tutto il testo e dando un accento siculo a quello che per l’autore era inglese. Per fortuna non è stato mutato “Cosa nostra” in “mafia”, permettendo così di apprezzare come nel 1965 (anno di stesura del romanzo), solo due anni dopo l’istituzione in Italia della Commissione antimafia e a quattro da Il giorno della civetta di Sciascia, il primo romanzo italiano di argomento mafioso, negli USA circolasse già un’idea ben chiara e consolidata dell’onorata società. Dice infatti Metzger che “Cosa nostra non dorme mai. Veglia. E non conviene farsi vedere ad aiutare quelli che l’organizzazione non desidera siano aiutati”. Anche il newyorkese Pynchon veglia eccome, dacché all’età di ventotto anni ha un quadro molto preciso del fenomeno mafioso di origine siciliana quando in Italia la parola mafia è ancora impronunciabile (Sciascia infatti non la scrive) e davvero poco si sa di Cosa nostra anche come termine.
Il romanzo è sovraffollato di personaggi in un carosello nel quale la sola Oedipa rimane sempre in scena, ma anche lei muore sulla pagina per un difetto che Pynchon si riconosce da giovane e che non ha risolto: quello di partire da un concetto, un’astrazione, un’idea per poi dedurne un intreccio e i personaggi. Che sono quasi sempre interpreti di sé stessi, recensioni di figure che valgono per il loro ruolo e che non appaiono mai nella loro consistenza sia fisica che spirituale.
Oedipa Maas, nominata da un ex fidanzato esecutrice testamentaria del suo enorme patrimonio, è un personaggio paradigmatico che torna nell’ultimo romanzo del 2013, dopo quarantasette anni: in La cresta dell’onda la ritroviamo in Maxine Tarnow, una investigatrice incaricata di indagare sui conti di una società informatica e risucchiata nel vortice di malaffari, misteri e garbugli tra fatture false e spese ingiustificate. Le trame dei romanzi di Pynchon non sono riassumibili in alcun modo, perché simili a un grande fiume nel quale si gettano decine di affluenti anche importanti. Oggi che il postmoderno è un’esperienza passata insieme con il novecentismo, dopo il ritorno ai canoni del realismo razionalistico, Thomas Pynchon rimane in America testimone di una stagione spumeggiante e creativa presto avviata verso il tramonto, cerimoniere funebre dal quale attendersi l’ultimo acuto di voce remota o il perdurare del silenzio entro un’entropia.









