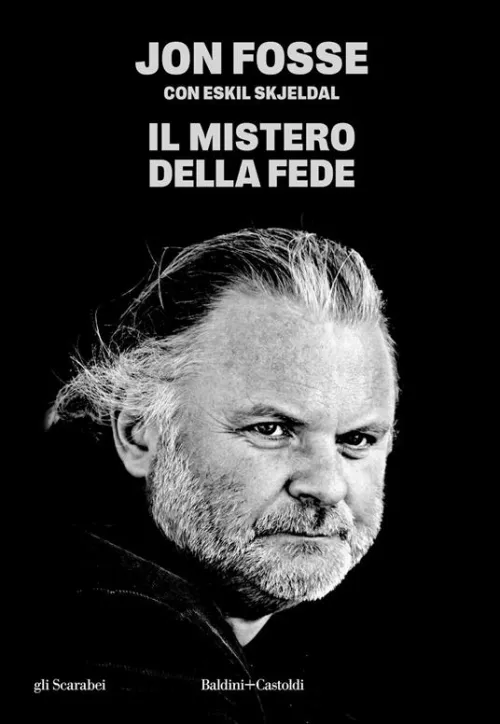Jon Fosse: l’ossessione per la luce divina
Più che all’indicibile, come nel 2023 recitava la motivazione del Nobel, la prosa narrativa di Jon Fosse dà voce all’ineffabile, quanto al principale elemento che la pervade, il trascendentale e meglio ancora l’immanente. “La letteratura potente dice, o mostra, l’ineffabile” dichiarava lo stesso Fosse nel libro-intervista del 2014, uscito in Italia nel 2024 da Baldini+Castoldi, Il mistero della fede. E “ineffabiliter”, secondo Sant’Agostino, si esprime Dio, con il quale lo scrittore norvegese alimenta un serrato dialogo cominciato già prima del 2012 – anno della sua conversione dal luteranesimo al cattolicesimo, arrivata pochi mesi dopo aver ottenuto per meriti letterari una dimora proprietà del re, che però è obbligato per legge a osservare la fede protestante. “Forse una dimensione spirituale c’è sempre stata in me fin dal primo romanzo che ho scritto a vent’anni” conferma infatti l’autore nello stesso volume.
Se è così, altro non è che il coronamento di un lungo evangelium laico il suo capolavoro, Settologia (uscito con La nave di Teseo in tre volumi, divisi in sette parti, donde il titolo: L’altro nome, 2021, Io è un altro, 2023, e Un nuovo nome, 2024), acuta riflessione teologica e sentitissima orazione mistica, quasi un epicedio in suffragio dell’uomo e di sé stesso, ma anche originale speculazione filosofica, monumentale opera letteraria concepita per bilanciare come scrittore la sua preponderante produzione drammaturgica, e minuzioso baedeker della Norvegia occidentale.
Monumentale il romanzo lo è davvero per le sue quasi novecento pagine e l’esuberanza degli spunti. E sebbene abbia detto di non amare i testi lunghi (“capolavori mastodontici come l’Ulisse che pretendono di essere considerati al pari di una bibbia”), Fosse ha creato proprio un mastodonte che, scritto nello stile piano, ridondante e evocativo delle Scritture, immagina una sorta di cosmogonia dell’essere umano nella specie dell’artista del nostro tempo, sia pure circoscritta, nel raggio di duecentotrenta chilometri, tra due fiordi, l’Hardangerfjord e il Sognefjord, dentro il quale la regione da Dingja a Øygna a Bergen e da qui a Strandebarm e Aga è meticolosamente, quasi maniacalmente, disegnata: com’è nella maniera tipica di altri scrittori norvegesi contemporanei quali sono – più noti in Italia – Dag Solstad e Karl Ove Knausgård: nel dichiarato retaggio del loro padre nobile che è stato Knut Hamsun e per Fosse di Tarjel Vesaas, come pure nel comune spirito norvegese inteso a tenere strettissimo il legame tra uomo e natura. Un legame che in Fosse si precisa in una smaniosa ricerca di Dio che pure rischia, quanto più insistita, di assumere forme panteiste e fondamentaliste.
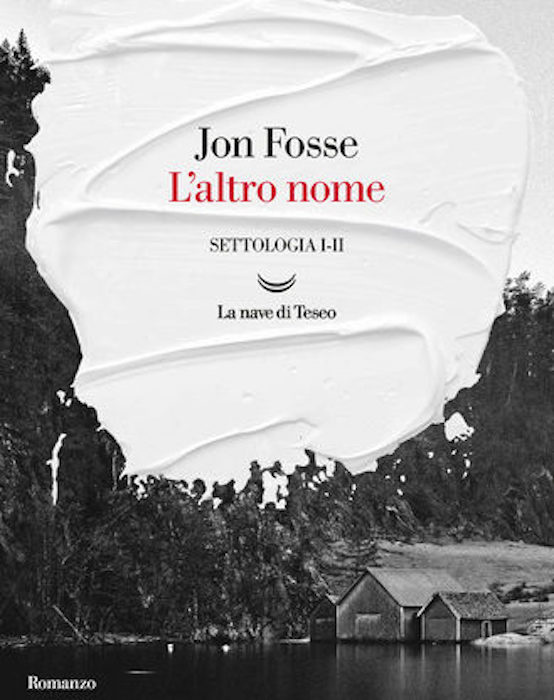
Con la precisazione necessaria che Fosse, nel suo atto di creazione, scrive non nella lingua dominante derivata dal danese, chiamata “Bokmål”, ma nel neonorvegese rurale ereditato dal norreno detto “Nynorsk”, per cui Sognefjord è Sygnefjord, Dingja diventa Dylgja, Bergen lo leggiamo Bjørgvin e Strandebarm, dove Fosse è cresciuto, lo troviamo negli abbreviativi di Stranda e Barmen a indicare due villaggi vicini, ma designando un unico luogo dell’anima: “La mia lingua è il nynorsk, il mio paesaggio è Strandebarm” ha detto nel 2014. “Sarà sempre il mio paesaggio, il mio universo”.
Settologia, venuto dopo, ne è conferma, segno di una coerenza che radica lo scrittore nel suo mondo, tradizionale, protestante e di tipo pietista: dove la sua indole ribelle e anticonvenzionale lo spinge, non ancora ventenne, a farsi cattolico, uscendo dalla “Chiesa di Stato” proprio come Asle, l’alter ego e io narrante del romanzo con il quale è facile identificarlo. È infatti Fosse l’alunno che in classe non vuole leggere ad alta voce per una crisi di panico ed è sempre lui che veste alla maniera hippy e porta i capelli lunghi, che ama la pittura e soprattutto cerca Dio: entro un mistero insondabile sospeso tra luce e buio nel cui parallelo trova posto anche l’arte secondo quanto l’amico Åsleik dice ad Asle circa il valore di un poeta: che è tale se possiede “una qualità propria”, il corrispettivo esatto della teoria di Fosse, convinto qual è che “l’artista non risiede nella somiglianza a qualcun altro ma nella sua unicità”.
Lui lo è fin troppo in ogni suo libro: nello stile compositivo, privo di punteggiatura che non siano solo virgola e punti di domanda ed esclamazione; nelle figure retoriche ricche di polisindeti, anafore, antifrasi, proposizioni paratattiche; nel linguaggio minimale e quasi sciatto, come parlato, costipato di ripetizioni non solo di parole ma anche di costrutti sintattici, scene, dialoghi, che si fa però ragione di una ricorsività voluta, ricercata, così da assumere, nel tono salmodiante, il senso di una preghiera reiterata nei tre modelli più introspettivi che le forme letterarie moderne offrono: l’indiretto libero, il monologo interiore e il flusso di coscienza, combinati a volte fra loro in un crescendo vertiginoso che diventa visionario e onirico, fino al concettualismo, al cerebralismo, all’astrazione e al nonsenso.
Ma c’è di più. Voltando le spalle ad Aristotele e alla sua Poetica, Fosse premia l’irrilevanza, indugia lungamente su circostanze prolisse del tutto insignificanti ai fini dello sviluppo narrativo al quale preferisce di gran lunga il campo descrittivo, e così facendo ottiene di svuotare quasi del tutto la fabula in nome di un’urgenza più avvertita: la “religio della luce” sulla quale soprattutto chiede riflessione e concentrazione. Il romanzo (che egli ama però chiamare “prosa” qualificandola come “lenta”) non conta come racconto di fatti ma come raccordo di sensibilità e spiritualità attorno al punto cardinale sul quale poggia l’intera sua esperienza di uomo e di scrittore. La luce appunto e più precisamente l’ossimorico “buio luminoso”.
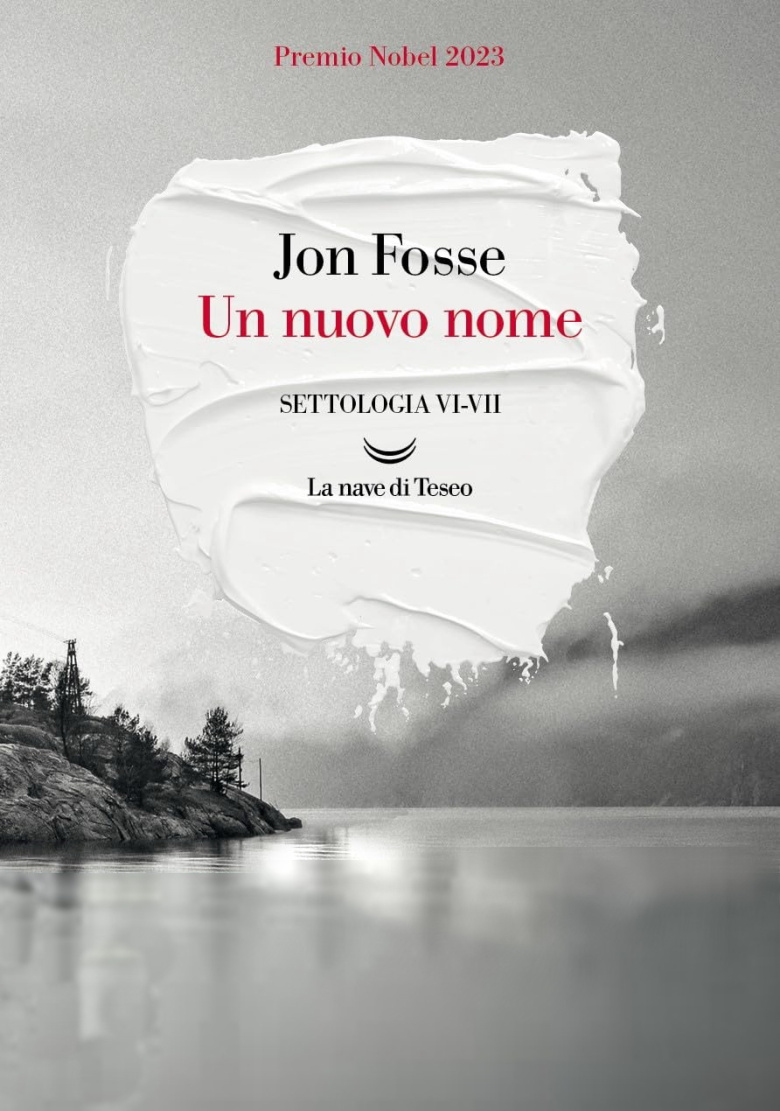
L’espressione fu coniata da un critico teatrale svedese, Leif Zern, autore del libro Quel buio luminoso (Titivillus, 2012 e Cue Press 2023) sulla drammaturgia di Fosse, il quale ha però precisato che il concetto lo ha tratto piuttosto dal mistico tedesco Meister Eckhart, da lui eletto a primo mentore perché il più vicino al credo quacchero dal quale il suo percorso fideistico, poi superato, era partito: un credo provvisto degli elementi posti alla base della sua vicenda anche letteraria, ovvero l’immagine interiore e il silenzio come preghiera. Su questi due capisaldi Fosse ha eretto tutta la sua teoresi religiosa, che tuttavia non si comprenderebbe senza il rimando a un episodio cruciale vissuto all’età di sette anni, quando in un incidente si procura la lesione di un’arteria e teme di morire dissanguato. Durante il soccorso in ospedale, guardando la casa che sta lasciando forse per sempre, la vede circonfusa in “una luce dorata paragonabile a una specie di luccichio quasi invisibile”.
Il luccichio, che richiama la “scintilla divina” quacchera, appare già nel 1995 in Melancholia (biografia in due volumi del pittore norvegese Lars Hertervig), dove l’io narrante (la sola voce di Fosse), andando in casa di quaccheri a Stakland, rivela di sentirsi colmare “da una luce fresca così scintillante, così pesante e leggera al tempo stesso, così avvolgente che mai prima ho visto una cosa del genere”. È lo stesso scintillio che compare nel 2000 in Mattino e sera (La nave di Teseo, 2019), apologo sulla morte da accostare, a chiudere un lungo arco temporale, all’ultimo racconto pubblicato nel 2023, Un bagliore (La nave di Teseo, 2024): lì un vecchio pescatore non sa di essere morto e, muovendosi tra quanto gli sembra pesante e pure leggero, al pari di come sente il suo corpo, “vede che ogni cosa riluce, dal cielo laggiù, da ogni parete, da ogni sasso, da ogni barca tutto scintilla verso di lui”; qui un pensionato si perde in un bosco finché vede avvicinarsi “una sagoma bianca, splendente, così luminosamente bianca”. Un bagliore nel quale riconosce il proprio angelo custode. Fosse non lo ha negato nel suo libro-intervista del 2014: “Sono sicuro che quell’esperienza all’età di sette anni è stata determinante per la mia carriera di scrittore e per il modo in cui vivo”. Tanto gli è stata in realtà preziosa da farla rivivere fedelmente anche ad Asle, l’io narrante di Settologia. Opera che testimonia infatti sia la carriera che la vita dell’autore.
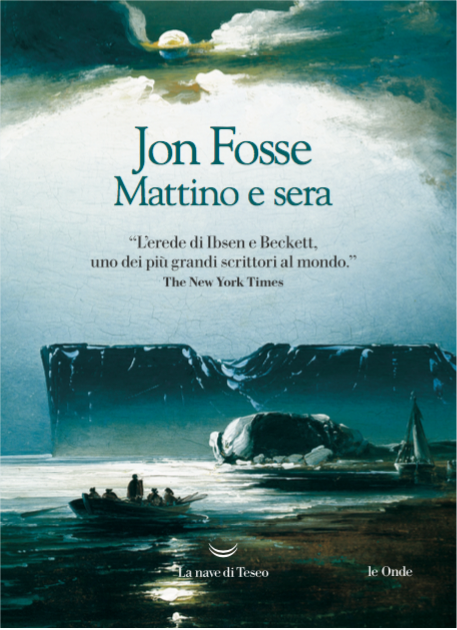
Suo antecedente, toponomastico e onomastico, è Insonni del 2007 (pubblicato da Fandango nel 2011 e non più ristampato), favola cristologica dove due ragazzi, Asle e Alida, lei in procinto di partorire, girovagano nottetempo a Bjørgvin in cerca di un alloggio che non trovano. Bjørgvin è il teatro principale della Settologia, figurando in essa anche un Asle (uno dei tre del romanzo) e una Alida in qualità però di fratelli, ed è perdippiù la città maggiormente frequentata da Fosse da ragazzo.
Asle (il narratore che sembra dettare in un registratore portatile – al punto da fare apparire il testo una mera trascrizione – quanto vive al presente e quanto gli sovviene di rimemorare in lunghissime e frequentissime digressioni nelle quali la prima persona narrante lascia rocambolescamente il posto alla terza persona onnisciente) è un pittore vicino alla pensione rimasto vedovo e rintanato nel piccolo villaggio di Dylgja. Ed è appunto uno dei tre personaggi con lo stesso nome, tutti tali da far credere a una stessa persona còlta in età diverse, perché fisicamente somiglianti e con gli stessi trascorsi. Senonché uno degli Asle muore di delirium tremens e si scopre che il terzo, chiamato “Omonimo”, è lui stesso da giovane, quello che l’altro Asle, l’io narrante anch’egli ragazzo, incontra a Stranda. Il gioco di Doppelänger, che si costituisce non come molteplicità dell’io quanto in guisa di rivisitazione di esso, si complica con le figure di due donne identiche che si chiamano Guro, che hanno avuto un violinista alcolizzato per compagno, ma sono una la sorella del vicino di casa Åsleik e l’altra l’amica del secondo Asle. Il quale potrebbe essere proprio l’io narrante, a dare ascolto al tassista che crede di riconoscerlo nell’ubriacone più volte portato a casa.
In un’atmosfera che echeggia Edward Hopper, fatta di pub con poca gente, vie cittadine deserte, luci notturne, come anche il David Lynch degli scambi di personalità tra realtà e sogno, Fosse lascia la trama irrelata, rarefatta, inconsistente. Non c’è narrazione in Settologia ma solo descrizione, per modo che è la metafora a prevalere sulla metonimia, perché i fatti non si accumulano ma si avvicendano in un geyser a volte impazzito di passato e presente. E proprio metaforico vuole essere lo spirito di un’opera che assume l’arte come prova della presenza di Dio. Vediamo meglio di cosa parliamo.
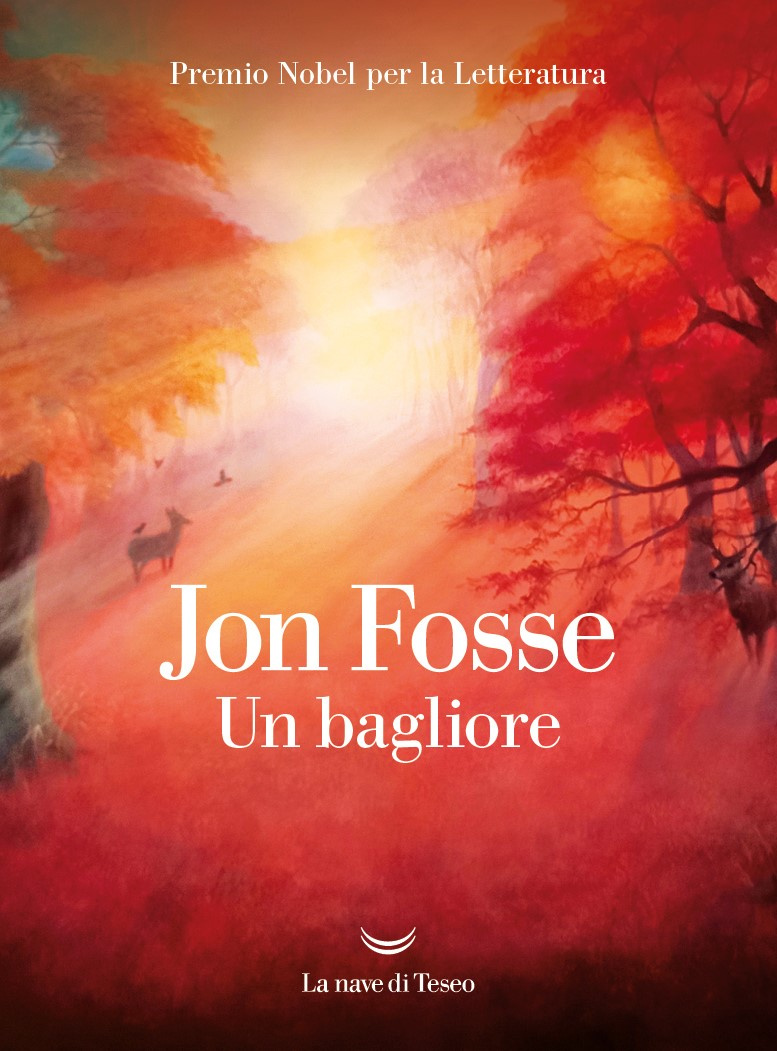
Asle è un pittore che da ragazzo dipinge a pagamento vedute paesaggistiche finché, dopo l’improvvisa morte della sorella, sceglie di realizzare soltanto quanto gli suggeriscono le “visioni improvvise” che gli si fissano nella mente “sotto forma di immagini” di cui non riesce a liberarsi se non dipingendole. Quelle immagini sono il portato dell’“immagine interiore”, di natura divina e di origine quacchera, che porta sempre dentro di sé. “È quell’immagine interiore che cerco sempre di dipingere” dice Asle. Un’immagine che può diventare fonte di luce se riesce a penetrare dentro sé stesso “il più profondamente possibile per poi uscire ed entrare nel dipinto”. In Melancholia il padre ha detto a Lars: “La luce più forte è quella che hai dentro di te” e in L’altro nome Asle dice che tutti i suoi quadri nascono da quella immagine: “Questa mia immagine interiore non la si può dipingere, non la si può dire, posso solo dipingere avvicinandomi o allontanandomi sempre più e tanto più mi avvicino ad essa quando dipingo, tanto più dipingo bene e il quadro emana luce”.
Notando qui in taglio come la visione di Asle sia straordinariamente uguale a quella di Armand V. di Dag Solstad circa il romanzo invisibile da portare alla luce ma inestraibile, conformemente a una Weltanschauung comune a entrambi gli autori e non solo a loro, si tratta di una luce invisibile a tutti fuorché ad Asle: una luce personale da trasferire nel dipinto che viene dall’animo turbato, dai tormenti interiori, ed è quindi prova di sofferenza, ma che è anche motivo di quiete intima, di serenità. Da un lato perciò Asle può dire in L’altro nome che un buon quadro deve avere in sé “qualcosa di brutto per potere splendere come si deve, deve avere in sé elementi di buio” e da un altro che “questa quiete vuota costituisce il mio pregare più autentico, sì, quando Dio è più vicino che mai, perché è nel silenzio e nella quiete che si può sentire Dio ed è nell’invisibile che può essere visto”. Ed ecco Eckhart e quindi il “buio luminoso”. Fosse, che sognava di fare il pittore, come anche il violinista (figura ricorrente nella sua opera: non solo nella Settologia ma anche in Insonni, Mattino e sera e per ultimo in La piccola violinista, Iperborea 2024), è chiarissimo quando fa dire ad Asle: “Credo che questi momenti quieti e silenziosi si trasformino nei miei dipinti in luce, in luce che si palesa nel buio, diventa un buio luminoso”.
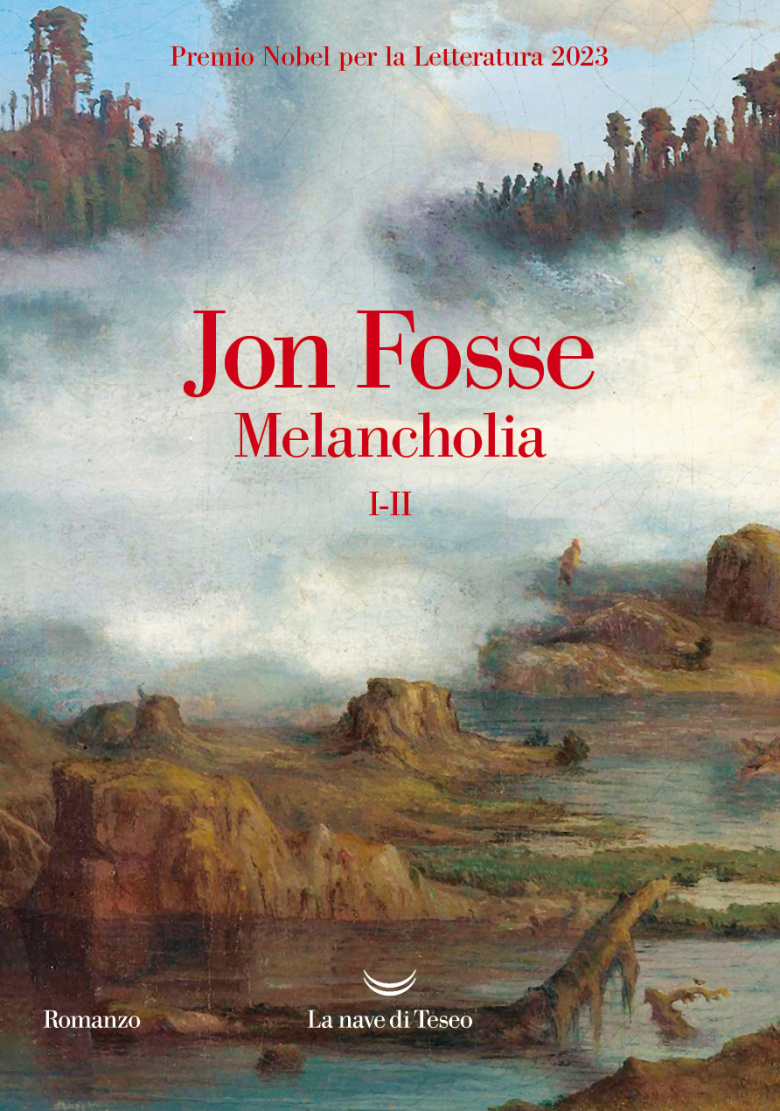
Di qui Fosse arriva ad implicare Dio: “Il buio luminoso che mi sforzo sempre di dipingere si può vedere nell’oscurità. (…) Dio vive nel buio, sì Dio è il buio e questo buio, il buio di Dio, sì questo nulla, sì splende, sì è dal buio di Dio che arriva la luce, la luce invisibile”. Dio, che “si mostra nel tempo e nello spazio come un buio luminoso”, in Io è un altro diventa un’immanenza costante che permea arte e vita: “I miei dipinti sono al servizio del regno di Dio, penso, e lo pensavo prima di convertirmi, e deve essere questo il motivo per cui ho sempre avvertito la presenza di Dio. (…) Il quadro deve venire da sé, come un evento, come un dono, sì, un buon quadro è un dono, una specie di preghiera, è al contempo un dono e una preghiera di gratitudine”.
Ed è nel secondo tomo che Fosse rivela la natura della propria “immagine interiore”: “Non appena muore, un essere umano viene mondato della colpa, ciò che lo separava da Dio è scomparso perché è di nuovo presso Dio, sì, è questa l’immagine più profonda che ho dentro di me, quella a cui tutte le altre che ho cercato di dipingere si sforzano di somigliare, questa immagine interiore che è una specie di anima e una specie di corpo in uno, sì che è il mio spirito e quello che chiamo spirito ritorna a Dio e diventa parte di Dio”.

Il corollario di questa ardita costruzione dottrinale di sapore gnostico arriva con Un nuovo nome: “Ciò che realmente è l’immagine non è né materia né anima, ma entrambe allo stesso tempo e insieme costituiscono ciò che per me è lo spirito, e forse è per questo che i dipinti che considero riusciti hanno qualcosa a che fare con quello che i cristiani chiamano lo Spirito Santo, perché tutta l’arte degna di questo nome possiede questo spirito, che si tratti di un bel quadro, una bella poesia, una bella musica”.
Precisando dunque che i suoi quadri sono “preghiera, confessione e penitenza” e che “tutta l’arte può essere vista così”, Fosse tenta mercé Asle una nuova “scolastica” che spieghi la fede attraverso l’arte e viceversa. Missione da non affidare però alla letteratura perché troppo gravosa e certamente non mass-cult. Guardando a James Joyce per la forma e a Thomas Mann per la sostanza, entrambi studiati e amati, Jon Fosse ha voluto una summa filosofico-teologica più che un magnus opus letterario, giudicando solo il quale rilevano anzichenò incongruenze, implausibilità, contraddizioni e non pochi svarioni: Asle che prima abita al sesto piano che poi diventa il quinto; Bjørgvin che in Un nuovo nome diventa Bergen, Guro che tiene da parte il guinzaglio del cane e Asle dimentica di andare a riprenderlo né lei glielo ricorda più; il gallerista Bayer chiamato “vecchio” quando tratta, quarant’anni prima, i quadri del giovanissimo Asle; ancora Asle che dice ad Ales, la moglie morta, di non conoscere nessuno con il suo stesso nome, quando all’Hotel Stranda ha già incontrato sedicenne “Omonimo”, cioè l’altro Asle; il quale non è in ospedale “da settimane” ma solo da quattro giorni; e sempre Asle che dice di aver visto i giovani innamorati “ieri” quando è mercoledì e non martedì. La sensazione è che Fosse non sia riuscito appieno a controllare tutto il materiale raccolto, fatto peraltro di generi anche molto eterogenei. Impegnato a cercare ossessivamente la sua luce, ha finito per essere abbagliato e uscire fuori strada.
Leggi anche:
Oliviero Ponte di Pino | Nobel a Jon Fosse. Custodire il mistero