
Speciale
Macchie e altre analogie
Un giorno del 1998, una signora di Pontedera, si svegliò presto come ogni mattina. Dopo aver fatto quello che soleva fare, uscì di casa per andare a comprare il pane. Stava attraversando il piccolo giardino della sua casa quando qualcosa nel suo campo visivo, seppur in zona periferica, la colpì.
Voltò lo sguardo verso il muro della casa, non più ridipinto da tanti anni, e vi notò una macchia di cui non si era mai accorta. Era grande, di un colore più scuro del color panna del muro: probabilmente era una macchia di umidità, pensò.
Aveva una forma compatta, ma dai contorni frastagliati. La signora si avvicinò per guardarla meglio e, con sua grande sorpresa, si accorse che quell'immagine sembrava proprio il volto del Cristo: poteva vederne la barba, la corona di spine, gli occhi dolenti. Le parve un miracolo!
Quella notte, evidentemente, Cristo era sceso sulla terra e aveva scelto lei, proprio lei, tra miliardi di umani, per manifestarsi. Il cuore le esplodeva di gioia. Chiamò le vicine e, in breve la notizia fece il giro della piccola cittadina operaia, e poi ne superò i confini, finendo sulle scrivanie dei giornalisti.
Si narra in quelle terre toscane che dopo qualche giorno dovettero intervenire i Carabinieri perché la signora chiedeva un obolo per poter vedere la macchia sacra.

Un giorno del 1920, Francis Picabia, estroverso dandy e artista geniale, prefigurò Pollock, lasciando gocciolare della vernice nera su una tela; lo schizzo esplose in tante gocce, creando una macchia coronata. Lo chiamò "La Sainte Vierge". Quel nome, così dispettoso, trasformò l’opera in una delle più blasfeme e potenti di tutto il Novecento. A vederla oggi non sembra più così originale, ma, al tempo, Kandinsky aveva definito l'astrattismo soltanto sette anni prima, mentre Jackson Pollock non aveva ancora iniziato a bere e, in quel periodo, si sedeva ad un banco della Primary School di Cody, in Wyoming.

Un giorno del 1965, Roger Caillois decise di raccontare il suo amore per le pietre che aveva accumulato in collezione; avevano disegni e forme modellate dal tempo e dalla chimica, visioni fantastiche create dall'orogenesi milioni di anni fa. Gli piaceva starsene seduto ad ammirarle. La varietà della texture, la moltitudine di sfumature, i cambiamenti di colore dovuti alla luce, lo affascinavano e, come dei dispositivi visivi di distrazione, le pietre lo tenevano a sé, unico spettatore rapito dalla loro malìa.
Quanti uomini le avevano già guardate, si chiedeva? E che ne era stato degli ominidi: anche loro avevano subito il fascino di queste pietre vanitose?
Un giorno del 1810, una ricca signora di Hull lanciava una tazza di porcellana a terra, dopo aver bevuto il suo tè, e ne leggeva i fondi, osservando attentamente l'apparente casualità con cui le foglie si disponevano. A ben guardare sembravano suggerire forme conosciute che andavano individuate, così da poterne estrapolare i messaggi nascosti. Era in quel periodo molto in voga l'arte della tasseografia, che si basava sulla consultazione del volume "Reading tea leaves", pubblicato nel secolo precedente.

Una sera del 2004, Tom Waits, ospite al David Letterman Show per presentare il suo nuovo album, fece vedere il disegno di un cavallo fatto da un cavallo mordendo il legno della porta della propria stalla. Waits disse che casualmente lo aveva visto e gli era sembrato subito la rappresentazione di un cavallo che salta; poi, all'incredulo Letterman mostrò le foto di quella forma, così incredibilmente simile a quella di un cavallo. Secondo lui aveva addirittura uno stile da anfora greca, anche dovuto al colore rosso argilla che aveva preso il legno dopo essere stato morso. L'impressione era che quel "dannato" cavallo fosse un genio, un artista, probabilmente, inconsapevole. Oppure svelava qualcosa sul nostro processo di elaborazione delle immagini e del come le guardiamo?

Un giorno del 1540, Leonardo Da Vinci se ne stava seduto sul suo sgabello, con il pennino in mano, la mente persa in un gioco che faceva sin da bambino: guardava l'intonaco irregolare del muro del suo laboratorio e lasciava che la sua immaginazione fornisse soluzioni sensate a ciò che vedeva, dando un nome alle forme che comparivano.
Nel Trattato della Pittura consigliava i lettori così: "si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie, de' muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni mirabilissime". Poi dà una sua soluzione già neuroestetica a ciò che ci accade guardando le macchie: "nelle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni”.
Un giorno del 1992, la Nasa diffuse delle foto del suolo di Marte. Ray Bradbury non commentò pubblicamente, ma qualcuno vide, celato tra le rocce, il volto di una divinità scolpita, un monumento gigantesco creato evidentemente da una civiltà marziana ormai scomparsa. Ci volle qualche anno perché l'ente spaziale statunitense potesse fornire altre immagini di quello stesso luogo che spiegavano come l'effetto fosse dovuto a delle ombre casuali e che, quindi, il volto apparisse per un evidente caso di pareidolia.

Avevano usato quella parola anche i carabinieri che, dopo qualche giorno dalla sua scoperta, visitarono la signora di Pontedera per intimarla di fermare il diffondersi della notizia e perché non era legale chiedere dei soldi per poter vedere quella “falsa” sindone. Lei a sentirla pronunciare si era spaventata, disse di non aver fatto male a nessuno e che non era certo una persona deviata.
I nostri occhi sono come cani randagi disperati e affamati che rovistano tra la montagna di informazioni visibili per trovare un senso, una coerenza, un'analogia a tutto ciò che vediamo. Il gioco del riconoscere, del "cosa sembra" ovvero dell'analogia, è il preferito dalla nostra mente: i nostri occhi possono rassicurarci e dirci che tutto va bene, che tutto è conosciuto, che tutto è coerente, tutto sensato.
In uno scarabocchio, come in una macchia, facciamo fatica a trovare una coerenza figurativa: spesso il "cosa sembra" è un gioco che non funziona, perché le linee sanno sempre di roveto, di cespuglio, di filo di ferro intrecciato, di gomitolo che ha perduto la forma, di chaparral aperto dal vento. Sembra, lo scarabocchio, alieno al visibile.
L'unica rispondenza è compararlo con qualcosa che sia fatto da un filo o da una linea.
In una macchia troviamo più facilmente un senso, basta aggiungere pochi elementi.
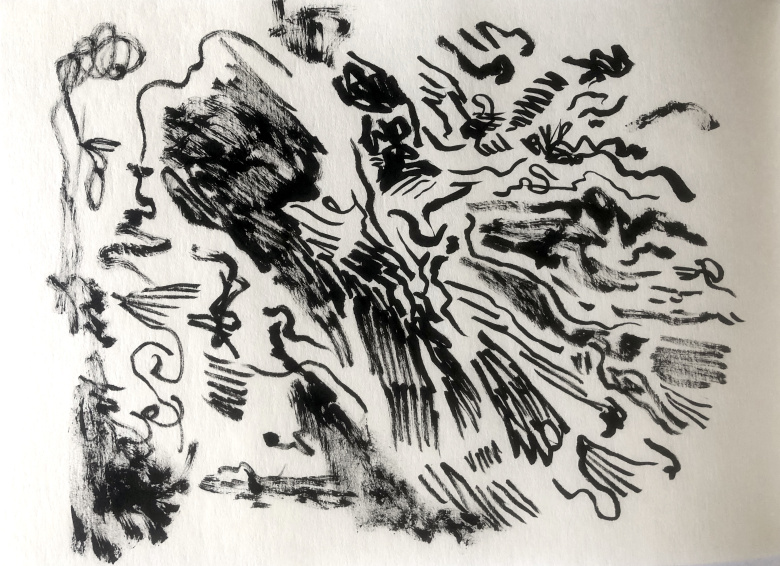
Lo sapeva bene lo psichiatra svizzero Hermann Rorschach, quando nel suo studio, sul finire della Grande Guerra, con l'inchiostro andava a realizzare delle macchie informi che suggerissero significati: ne selezionò dieci e ci costruì intorno un sistema di indicazioni, una categorizzazione complicata che poteva dare risposte certe sulla natura dell'inconscio di un individuo. Un'astrazione ingannevole poteva diventare una sinfonia di significati diversi, dai quali capire i pensieri più nascosti di chi li guardava, mentre cercavano, rapiti, di dare a quelle macchie un significato.
Quando ci troviamo di fronte a scarabocchi e macchie è difficile dar loro un significato e meno che mai un nome, sempre che non si abbia la sfrontatezza di Picabia.
Scarabocchi e macchie sono gli apolidi dell'arte, quelli che nessuno vuole, nemmeno i bambini. Non piacciono a nessuno, a parte a qualche adulto che tiene corsi oppure organizza festival e che, dopotutto, crede che si possa dare un nome a tutte le macchie e a tutti gli scarabocchi del mondo. Perché, lo impariamo presto, già da bambini, che è quando le cose hanno un nome che diventano importanti.
Eppure, come ci confermano questi e tanti altri esempi, l'informità di macchie e scarabocchi attira la nostra attenzione: ci stimolano a inventare forme e formulare significati, esplorando l'ignoto.
Le opere d'arte generalmente riunite dentro l'etichetta di "espressionismo astratto" vengono spesso accomunate a macchie da molte persone, non soltanto dagli analfabeti artistici, ma anche da pregiati critici e studiosi saldamente legati al bello naturale e al figurativo.
Semir Zeki, studioso di neurobiologia e portatore di idee innovative nella neuroestetica, ha aperto la strada a una rivalutazione sul piano cognitivo, oltre che estetico, di tutta l'arte astratta, affermando come per lo spettatore l'incapacità iniziale di individuare un significato, di riconoscere una forma, di trovare appigli visuali, permetta di avere un'esperienza cognitiva molto ricca, facendolo diventare in qualche modo creatore egli stesso, dando un nuovo senso a ciò che sta vedendo.
Nel carteggio tra l'artista Barnett Newman, alfiere e teorico dell'espressionismo astratto americano, e lo storico dell'arte Erwin Panofsky, critico feroce dell'astrattismo, pubblicato nel libello Il sublime astratto da Johan & Levy (2023), questa tensione è ben espressa, evidenziando come Newman volesse non tanto superare o distruggere l'idea kantiana del bello, ma aprirla a nuove possibilità, togliendola dalla gabbia figurativa, e mostrando come l'esperienza del trascendente potesse avvenire anche nella contemplazione di un'opera senza figure riconoscibili. Gli studi dei neuroscienziati, sessant'anni dopo, avrebbero confermato questa sua idea, affermando che l'elaborazione delle opere astratte coinvolge reti di connettività cerebrale diverse e più distribuite rispetto ai dipinti figurativi; l'ultima ricerca di questo tipo è apparsa proprio quest'anno (2024) su Applied Sciences ed è stata compiuta in una università ungherese.
Macchie e scarabocchi ci pongono di fronte al dilemma dell'inconosciuto, ma non sono inconoscibili: possiamo addentrarci nelle loro nebulose astratte cercando significati oppure semplicemente contemplandole. Creare macchie e scarabocchi ci può quindi rendere doppiamente creatori: mentre dipingiamo o disegniamo ci sentiamo creatori di qualcosa di originale che, seppure simile ad altre creazioni di questo tipo, avrà delle sue peculiarità, per quanto microscopiche, che lo renderanno unico; quando poi guardiamo le nostre opere diventiamo creatori di nuovi significati, come se ciò che abbiamo creato con le nostre mani fosse un portale d'accesso ad un'altra dimensione; anzi, dovremmo abbandonare la nostra umana tendenza alla pareidolia, accettando finalmente una realtà in cui il riconoscimento non è necessario e lasciarsi andare al fluttuare del nulla da dove tutto nascerà.
Non c'è bravura, non c'è errore, non c'è tecnica: una macchia o uno scarabocchio sono incidenti fortuiti del reale, casuali testimonianze delle infinite possibilità della vita, nuvole di vapore nell'aria: tutti possono crearle e poi saltarci dentro.
Anche adesso.
Bibliografia possibile:
Breve storia delle macchie sui muri, Adolfo Tura (Johan & Levi) la cui lettura, mesi fa, ha stimolato questo articolo.
Macchie di inchiostro. Storia di Hermann Rorschach e del suo test, Damion Searls (Il Saggiatore)
La scrittura delle pietre, Roger Caillois (Abscondita)
Il sublime astratto, Pietro Conte (Johan & Levi)
La visione dall'interno. Arte e cervello, Semir Zeki (Bollati Boringhieri)
“La Nazione”, cronaca di Pontedera
Leggi anche:
Iolanda Stocchi |Scarabocchi: tutto ha volto
Roberto Papetti | Scarabocchi: Sole e gibigianne
Alessandro Bonaccorsi | Perché disegnare volti
Iolanda Stocchi | Scarabocchi: tutto ha volto
Giovanna Durì | Pastine, sassi, bottoni e foto sbagliate
In copertina, Barnett Newman. Vir Heroicus Sublimis. 1950-51.









