
La strada per lo sviluppo economico / Quando Marcello de Cecco telefonava
Marcello de Cecco è morto un anno fa, il 3 marzo del 2016. Quando chiamava al telefono lo riconoscevi subito. Mischiava abruzzese e altri eloqui centro–meridionali, con una prevalenza del napoletano, in una parlata inconfondibile, come di una pentola di fagioli che borbotti sul fuoco. Era un po’ come incontrare don Ciccio Ingravallo, il protagonista di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Solo che de Cecco non veniva dalla collina molisana, ma da Lanciano, e ne andava fierissimo.
La telefonata iniziava con una domanda precisa – quanto crescono i depositi e i prestiti bancari? come va il risparmio degli italiani? – ma proseguiva in mille direzioni. Si capiva subito che a Marcello, per fortuna, non interessava molto ricevere le nostre risposte. Era un grande affabulatore, uno da “one man show”. Passava dalla riluttanza della Germania ad assumere un ruolo di responsabilità in Europa alla critica della perenne immaturità delle classi dirigenti italiane; dalla politica economica degli Stati Uniti alla necessità di lanciare in Italia un piano per la costruzione di case popolari; dalle privatizzazioni al comportamento “a gregge” degli agenti economici; dalle preoccupazioni per le sorti della grande impresa in Italia a ricordi delle chiacchierate con Sir John Richard Hicks, premio Nobel per l’economia nel 1972.
Come Alberto Arbasino, Marcello de Cecco era un grande pettegolo.
Ma, come il secondo Albertone nazionale, da un ricordo personale di un personaggio, ora benevolo ora tranchant, de Cecco partiva per un ritratto di una facoltà universitaria, di un’impresa, di una banca, dell’Italia, dell’Europa. Insomma, del mondo. Si dovrebbero raccogliere questi pezzi, impresa ahimè impossibile perché quasi tutti lasciati alla tradizione orale. Nascerebbe un volume che rivaleggerebbe con il recente Ritratti e immagini. Forniamo un solo esempio. Quando Sergio Marchionne fu chiamato a dirigere la Fiat, ed emerse alle cronache come manager canadese, de Cecco urlò “Ma che canadese e canadese, Marchionne è nato a Chieti!”.
Marcello era chiaro nella scrittura breve – si vedano ad esempio i suoi pezzi per La Repubblica – mentre era giudicato meno efficace negli interventi orali, in conferenze o seminari. Il punto era che il suo eloquio era un po’ come il “grammelot” di Dario Fo. Invece che alle ascendenze lombardo–provenzali, bisognava abituarsi al sincretismo di abruzzese e napoletano, al passaggio continuo dal dialetto all’italiano e all’inglese e, soprattutto, al non rispetto (anzi, all’insulto) del principio aristotelico dell’unità di spazio-tempo-azione. Come in un romanzo di Thomas Pynchon, l’ascoltatore doveva essere pronto a seguire de Cecco nei suoi salti, da Montagu Norman alla critica dell’austerità fiscale in Europa, dalla Cassa Depositi e Prestiti alla legge bancaria italiana del 1936, da Bonaldo Stringher alla politica monetaria della BCE, dalla Grande Depressione degli anni Trenta del Novecento alla crisi del sistema di Bretton Woods negli anni Settanta del secolo scorso. I più giovani ne uscivano disorientati.
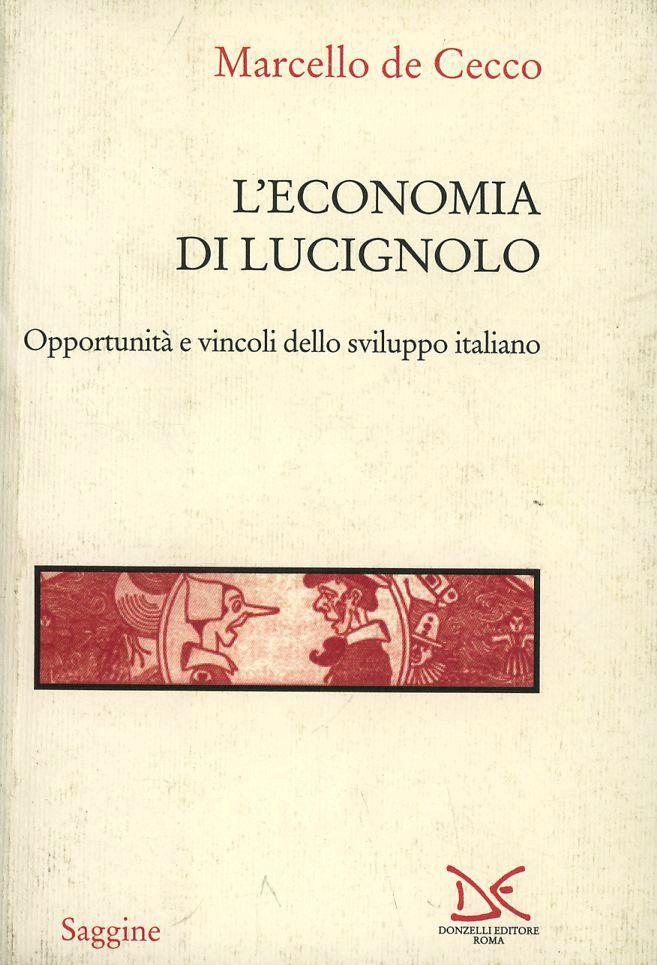
Lo stesso stile torrenziale caratterizza Moneta e impero, il libro più importante di de Cecco, di cui Alfredo Gigliobianco ha curato, in maniera impeccabile, una nuova edizione per Donzelli. Il tema centrale del volume è la critica del Gold Standard, il sistema monetario aureo. Un paese adotta un sistema monetario aureo quando l’oro è usato come moneta e quando monete metalliche e banconote sono convertibili in oro. Il Gold Standard internazionale è stato il sistema monetario che ha dominato gran parte dei paesi del mondo dal 1890 al 1914.
De Cecco compie un’opera di demitizzazione. Gran parte degli economisti ha infatti considerato il Gold Standard come un’età dell’oro, un’Arcadia, un sistema naturale basato sul libero interagire dei mercati, senza nessun ruolo per l’intervento pubblico; de Cecco smonta il mito, mostrando che il Gold Standard non ha mai funzionato come descritto. Il gold standard internazionale è stato un prodotto dell’impero britannico, un sistema fondato sulla struttura delle relazioni economiche e politiche all’interno dell’impero.
Intorno al 1890 le merci prodotte dagli inglesi diventarono meno competitive rispetto ai prodotti americani e tedeschi. L’Inghilterra esportava le proprie merci in India, costringendo gli indiani a comprarle, anche se costavano più dei prodotti americani o tedeschi. L’India era costretta ad acquistare le merci inglesi ed esportava verso il resto del mondo. La sua bilancia commerciale era in attivo e gli inglesi, che controllavano gran parte delle banche indiane, dirottavano questo surplus verso Londra. La capitale prestava a sua volta questi fondi a tutto il mondo, confermando il suo ruolo di prima piazza finanziaria internazionale. Avendo perso il predominio nelle esportazioni mondiali, gli inglesi diventarono esportatori non più di merci ma di capitali.
La tesi di de Cecco ha un valore generale. Spesso ciò che gli economisti e gli storici giudicano un prodotto naturale di un mercato concorrenziale, un risultato automatico dei comportamenti individuali, è in realtà il frutto di scelte degli Stati, di decisioni di politica economica, in contesti dominati da monopoli e oligopoli. Il Gold Standard era nella realtà uno standard basato sulla sterlina, una costruzione dello Stato inglese. L’Inghilterra decantava le virtù del libero commercio, ma il “free trade” non doveva affermarsi all’interno dei confini dell’impero.
I sette capitoli di Moneta e impero non sono divisi in paragrafi o sezioni; non contengono introduzioni o conclusioni. Capitoli che arrivano talvolta a una lunghezza di 50 pagine sono scritti come flussi di coscienza alla Virginia Woolf o alla James Joyce (ma anche come la prima parte di Certi romanzi, nell’edizione Einaudi del 1974). Uno dei meriti dell’introduzione di Gigliobianco è sintetizzare il messaggio principale di ogni capitolo di Moneta e impero, le pagine indispensabili del volume e le parti interessanti solo per gli addetti ai lavori. Gigliobianco presenta inoltre una traduzione nuova, chiarendo i nessi tra la prima edizione italiana (1971), la prima edizione inglese (1974), la nuova edizione italiana del 1979 – di qualità assai discutibile – e la seconda versione inglese (1984). Un attento esame filologico aiuta a capire i nessi tra le diverse edizioni e la costruzione del libro.
La convinzione di de Cecco era che ogni paese dovesse trovare la sua strada per lo sviluppo economico. Era una visione vicina a quella del trio Nitti – Beneduce – Menichella. L’Italia è più povera di Inghilterra, Francia e Germania. L’obiettivo prioritario della politica economica deve essere quello di colmare questo distacco. Ma l’Italia è un paese povero di materie prime e con una classe borghese fiacca. Per raggiungere l’obiettivo si deve seguire una strada nazionale, fondata su un intervento pubblico dall’alto, dal centro, fondato sulla compresenza di grandi imprese e grandi banche, sia pubbliche sia private. Lo Stato deve dirigere il processo di industrializzazione, ma non deve interferire con il lavoro di banche e imprese, dalle quali i partiti politici devono tenersi assolutamente alla lontana.
Secondo de Cecco questo modello di economia mista, concepito in risposta alla Grande Depressione, aveva funzionato bene fino al miracolo economico. Il merito era da lui attribuito a una generazione di quadri tecnici e manageriali formatisi nella Grande Guerra, di formazione giolittiana, risorgimentale e nazionalista, rimasti alla guida delle imprese e delle banche fino agli anni Cinquanta. Il modello di economia mista era poi entrato in crisi, per mutamenti del contesto internazionale e, soprattutto, per la sostituzione progressiva dei vecchi amministratori di banche e imprese, spesso imposta da motivi anagrafici, con un personale organicamente fedele ai partiti politici di governo. Il vecchio centralismo finanziario e industriale, nel quale l’IRI aveva avuto un ruolo essenziale, era stato sostituito da una molteplicità di centri di potere, soprattutto di origine locale, dove i partiti avevano occupato le posizioni più importanti.

Negli anni Sessanta l’Italia aveva così perso la grande occasione di sviluppo. Da allora sono seguiti rattoppi, compromessi, soluzioni ad hoc, in un rapporto sempre complicato con l’Europa, ma il sentiero della crescita si è interrotto. È scomparsa la grande impresa, sia pubblica sia privata. Si è entrati nel mondo della “piccola impresa” e della “piccola banca”, che de Cecco aborriva (anche se forse negli ultimi anni aveva stemperato il suo giudizio negativo). C’era, un’ennesima volta, un contatto inconsapevole con Arbasino (mai fermarsi su qualcosa di provinciale e localistico se non per irridere e denigrare). Questa visione dell’economia italiana raggiunge la sintesi migliore nelle 15 pagine di “Splendore e crisi del sistema Beneduce: note sulla struttura finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni venti agli anni sessanta”, il saggio pubblicato nella Storia del capitalismo italiano curata da Fabrizio Barca nel 1997 per Donzelli.
de Cecco ha scritto oltre 200 articoli; ha redatto o curato una trentina di volumi, da solo o con altri studiosi. Questi lavori sono rintracciabili in libreria o in rete. Non è così per il suo primo libro, i Saggi di politica monetaria, pubblicati da Giuffrè nel 1968, e oggi disponibili solo in biblioteca. Il volume contiene un saggio sul sistema di gold exchange internazionale (l’abbozzo dei lavori successivi), una stima econometrica della domanda di moneta (una rarità assoluta, dato lo scetticismo di de Cecco verso l’econometria), e un contributo sulla stabilizzazione italiana del 1947. Ma il saggio più importante è quello sugli sviluppi della struttura finanziaria del dopoguerra. A meno di trenta anni d’età, de Cecco denunciava la politica di autorizzazione degli sportelli che la Banca d’Italia aveva perseguito negli anni Cinquanta, accusandola di aver penalizzato le grandi banche, e di aver favorito i gruppi locali che amministravano casse di risparmio e banche popolari. I più cattivi sostengono che il giovane de Cecco avesse come suggeritore uno dei più grandi banchieri italiani, Raffaele Mattioli, Amministratore Delegato e poi Presidente della Banca Commerciale Italiana (Comit) dal 1933 al 1972, nato, non a caso, a Vasto: la penalizzazione delle grandi banche sottolineata da de Cecco era stata soprattutto la punizione della Comit. Comunque la si pensi, l’articolo resta una delle prime sintesi, efficacissima, dell’evoluzione del sistema bancario e finanziario italiano nei primi venti anni del secondo dopoguerra. Speriamo che un editore ristampi dunque i “Saggi di politica monetaria”.
Nel 1973-1975 la radio italiana presentò “Le interviste impossibili”, nelle quali, per fare pochi esempi, Italo Calvino intervistava l’uomo di Neanderthal, Umberto Eco Beatrice Portinari, Guido Ceronetti Attila, Giorgio Manganelli Charles Dickens, Andrea Camilleri Federico II di Svevia e così via. Abbiamo anche noi, con l’aiuto di amici, rivolto delle domande a Marcello de Cecco.
D. Professore, che cosa pensa della Brexit?
Gli inglesi hanno sempre pensato a curare i propri interessi e continueranno a fare sempre così. Solo che oggi non sono ancora consapevoli di non poter più contare su un impero….
D. Molti osservatori stranieri continuano a invitare l’Italia a fare le riforme. Qual è il suo giudizio?
Le riforme vanno fatte ma da sempre studiosi di altri paesi si sono occupati dell’Italia, suggerendo le scelte di politica economica. Si possono ricordare Adam Smith, Werner Sombart, Louis Bonnefon Craponne, Albert Hirschman, Vera Lutz e tanti altri. Ma l’Italia resterà sempre un Sonderweg, un’eccezione, un caso speciale. Questo in realtà è vero per tutti i paesi: ogni paese segue un proprio sviluppo, una propria traiettoria. Ci sono convergenze, ma è illusorio pensare che tutte le differenze nazionali possano sparire.
D. Come valuta l’attuale situazione della Germania?
I tedeschi continuano a insistere sul rispetto delle regole, e poi gli capita il caso Volksvagen. Non rispettano da quattro anni il limite del 6 per cento, stabilito dalla Commissione europea, per il surplus delle partite correnti. Chiedono alla BCE una politica monetaria improntata alle condizioni della Germania, mentre sappiamo che la politica monetaria non può che guardare a tutta l’area dell’euro. Hanno contribuito al ritardo con il quale la BCE ha lanciato il Quantitative Easing, facendoci correre dei rischi deflazionistici. Non hanno letto The Debt Deflation Theory of Great Depressions, scritto nel 1933 da Irving Fisher, che si insegna da sempre in tutte le università italiane. Non si ricordano che Hitler è salito al potere, proprio nel 1933, in una fase deflazionistica, non per colpa dell’inflazione. Come ha scritto il prof. Peter Bofinger, componente del German Council of Economic Experts, gli economisti tedeschi usano in prevalenza delle categorie interpretative pre-keynesiane. Che dire d’altro?
D. Su cosa sta lavorando ora?
Sto cercando di stimare l’intensità del razionamento degli sportelli che la Comit subì negli anni Cinquanta. A proposito, non è che potete darmi una mano a ricostruire i numeri precisi?









