Speciale
Reinventare la democrazia
In questo inizio di nuovo secolo, anche la democrazia, nella sua configurazione classica, liberale e parlamentare-rappresentativa, è in crisi. E non solo in Paesi dove si è insediata più di recente (basti pensare alla Federazione Russa), ma anche nei Paesi cosiddetti occidentali e nell’Unione europea, da almeno un decennio, manifesta segni evidenti di fragilità e di malessere. Quello più vistoso, sicuramente oggetto di maggiore attenzione, è il crescente astensionismo elettorale.
Se, oggi, le democrazie sono in crisi, è perché ancora stentano a ripensarsi e a reinventarsi di fronte alla sfida della complessità. Ovvero, la sfida posta dalla complessità delle dinamiche interne alla società postindustriale e dalla complessità dei problemi globali di un mondo sempre più interconnesso e interdipendente. Anzi, una vera e propria “ribellione contro la complessità”, come ebbe a definirla una volta Peter Sloterdijk, ha prodotto negli ultimi decenni le tentazioni semplificatrici che oggi, rintuzzandosi l’una con l’altra, minacciano seriamente le nostre democrazie, conducendole sulla soglia di involuzioni o di destrutturazioni pericolose. La tentazione populista, che vorrebbe consegnarci alla volontà immediata del popolo (di fatto, a quella dei “demagoghi” che saprebbero interpretarla o incarnarla). La tentazione tecnocratica o epistocratica, che vorrebbe consegnarci agli esperti o ai burocrati, minimizzando l’intrusione “incompetente” del popolo. Ma, anche quella sovranista, che arriva a miscelare populismo, neonazionalismo e autoritarismo benevolo, puntando a indebolire le “autorità indipendenti” e il check and balance dei poteri dello Stato. In questa “gara” di ricette semplificate, si demonizza l’avversario, si assumono toni roboanti, combattivi e vittimistici, allo stesso tempo, si predilige l’iperbole. E, così facendo, i governi democratici aumentano di fatto l’impotenza e la miopia dinanzi ai problemi complessi e alle sfide globali, che richiederebbero una visione a lungo termine e più strategica e che solleciterebbero a pensare in termini inediti agli obblighi verso le future generazioni. Da qui, la sfiducia strisciante verso le istituzioni e la classe politica delle democrazie rappresentative, che non è solo strumentalizzata all’interno degli stessi paesi democratici, ma anche dalla propaganda interna ai regimi autocratici che, nel mondo, contestano esplicitamente il valore universale delle democrazie pluraliste e liberali.
Il pendolo perverso tra il “mercato” delle promesse elettorali e il ritiro disincantato dall’agorà sembra condannare all’entropia o a derive pericolose le democrazie mature moderne, la cui crisi appare anche più profonda, se decifrata sullo sfondo della crisi della modernità e delle sue idee fondanti: la fede nel progresso e la fiducia nel futuro. Al suo stato nascente, infatti, la democrazia moderna è stata fondata sulla speranza di un mondo migliore. “Democrazia” non era solo l’accesso del “popolo” al governo (cioè l’inclusione politica crescente di età e fasce sociali), ma anche il diritto di tutti ad accedere al mondo moderno, che è quello dell’istruzione, della scienza, delle tecniche, del benessere, identificato con il futuro. Partiti e attori sociali organizzati, oggi non a caso anch’essi in crisi, si presentavano come agenti del progresso, in competizione per contendersi il controllo della direzione della locomotiva della storia e per poterne così accelerare l’approdo alla stazione finale, ovvero la piena realizzazione del progresso e una società armoniosa e felice. Ora, due secoli di modernizzazione ci hanno fatto approdare in un tempo di policrisi che sembra preludere a un’età di catastrofi più che di progresso e minacciare addirittura il futuro della specie umana sul pianeta.
Anche il destino della democrazia, allora, in questo scenario, è segnato?
Assolutamente no. Non solo perché la democrazia, grazie ai principi del pluralismo, del dibattito, della partecipazione attiva, della valorizzazione del dissenso, è il sistema più adeguato in assoluto a governare la complessità, le transizioni e a “digerire” le crisi. Non solo perché essa fornisce gli abiti mentali, gli strumenti e le procedure per attuare l’equilibrio e il confronto permanente di punti di vista diversi e di saperi diversi necessari a gestire ambienti sociali complessi. Bensì, anche perché la complessità del nostro tempo rappresenta una grande opportunità di sviluppo e di rinnovamento per la democrazia stessa. Le democrazie, nate storicamente nel perimetro degli Stati nazionali, hanno l’occasione di diventare realtà più complesse e aperte prendendo coscienza del contesto di interdipendenza globale, in cui si svolge ormai la vita delle collettività, e integrandosi in una costellazione postnazionale di spazi globali di cooperazione da contrapporre allo pseudo-multilateralismo degli “spazi imperiali”.
E abbandonare la credenza nel progresso come una necessità storica, la credenza in un progresso ineluttabile e garantito, dettate dallo scientismo di fine Ottocento, senza che ciò si traduca nell’abbandonare il lavoro permanente per il progresso come compito, non dovrebbe riuscire difficile a un regime come quello democratico, che, sorgendo sulle ceneri dell’ancien régime, ha inaugurato una forma di società nella quale si trova sotto scacco la credenza in una soluzione dei problemi ultimi della vita sociale, la credenza in un ordine giusto e stabile, conforme alla natura o regolato da potenze soprannaturali. Di conseguenza, la fine delle “illusioni” ideologiche otto-novecentesche sul migliore dei mondi possibili non dovrebbe inibire ma riattivare, attraverso l’esercizio immaginativo, dialogico e concorrente sui futuri auspicabili, la speranza in un mondo migliore. Oggi, il progresso diventa ancora più prezioso, da quando abbiamo scoperto che non obbedisce a nessuna necessità oggettiva, che non dispone di nessuna garanzia storica.
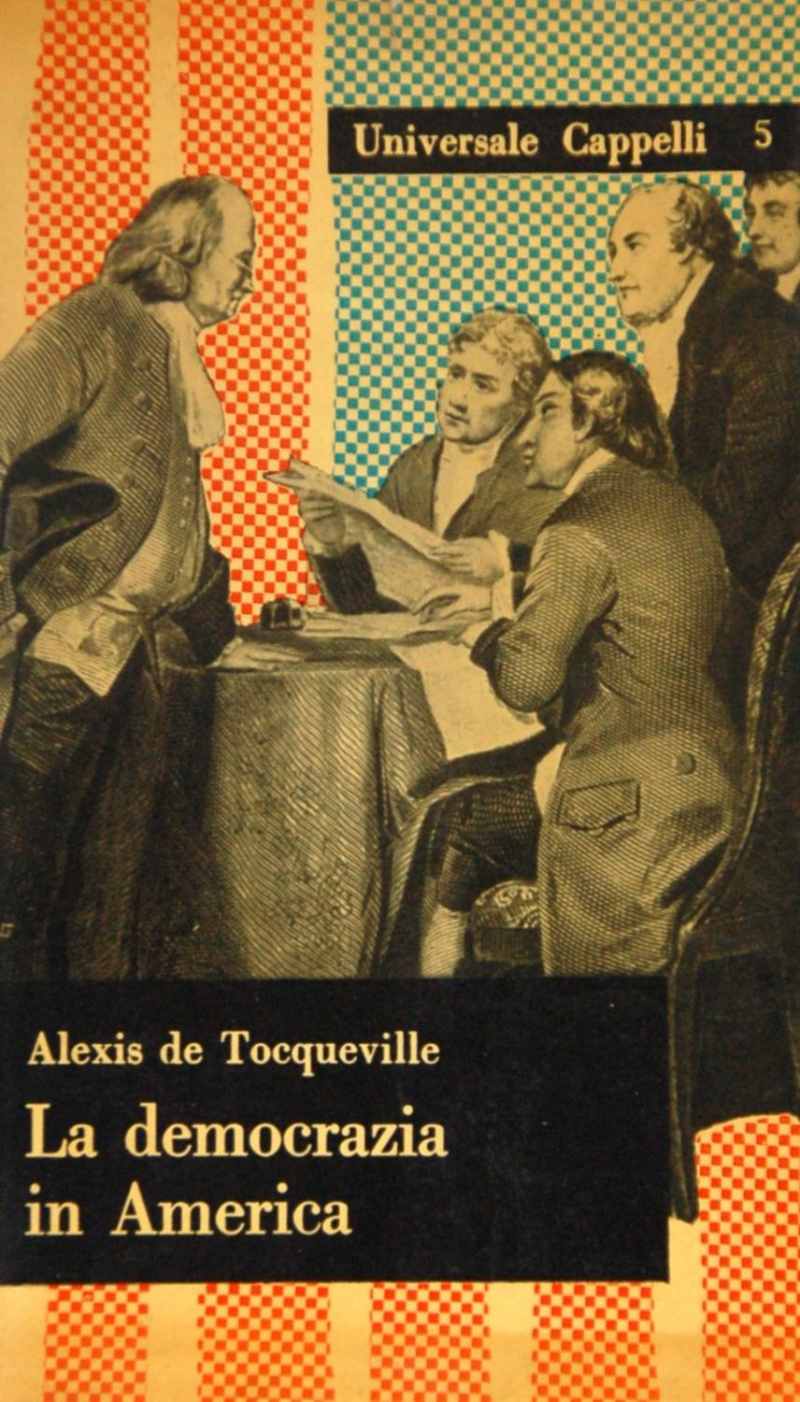
Per compiere questi salti e superare l’impasse attuale, occorre però passare dalla paura, che rende miopi, alla virtù del coraggio, giacché, come insegnava Montesquieu, sulla prima si fonda il dispotismo, mentre sulla seconda la repubblica. Noi diremmo, ancora meglio, la democrazia.
Innanzitutto, il coraggio di reinventarsi, di riprendere la vocazione alla sperimentazione. In quali direzioni? Si possono individuare almeno tre piste, per avviare una trasformazione che vada oltre i dispositivi istituzionali che le democrazie ereditano dal XIX secolo.
La prima riguarda la necessità di integrare la preoccupazione per le implicazioni a lungo termine delle decisioni, e più in generale di integrare la questione della sostenibilità come garanzia di un futuro vivibile per le generazioni a venire, nell’agenda politica e governativa, laddove il meccanismo della ricerca elettorale del consenso tende a schiacciare sul “presente” e sugli interessi immediati l’orizzonte politico delle democrazie. A imporlo sono le diagnosi allarmanti sul cambiamento climatico e il degrado ambientale, ma anche le crescenti controversie socio-tecniche generate dalla incertezza legata alle conseguenze degli sviluppi delle biotecnologie e alle applicazioni delle tecnologie della convergenza, che renderanno tanto più urgente quanto più problematico tracciare la frontiera tra ciò che compete al parere degli esperti, alla discussione pubblica e al potere politico. Le vie praticabili possono andare dalla “costituzionalizzazione” di principi ecologici alla previsione di una “Accademia del futuro” composta da scienziati, filosofi, esperti, rappresentanti di associazioni, capace di incidere sul controllo dell’ordine del giorno degli organi decisionali alla formalizzazione di “gruppi di discussione”, fino alla possibilità più complessa di una revisione del bicameralismo in funzione di una seconda Camera di rappresentanti delle generazioni a venire e dei loro interessi e a tutela dei “diritti” della natura. Il vantaggio di questi nuovi dispositivi sarebbe di rivitalizzare la partecipazione al dibattito pubblico e la responsabilizzazione collettiva nell’esplorazione di alternative e mondi possibili, di elevare le “competenze” attese di un cittadino e il ruolo di un’educazione alla cittadinanza, di allargare la coscienza civica a problemi globali, che rinviano a spazi di solidarietà più ampi di quelli locali o nazionali e alla condivisione di un destino comune come specie umana, e non solo come individui o membri di una società.
La seconda pista concerne la mutazione recente delle democrazie contemporanee, nella loro “costituzione materiale”, da un modello rappresentativo-parlamentare a un modello presidenziale-governativo, ben diagnosticato da Pierre Rosanvallon. Il nodo della “legittimità” democratica, e quindi della fiducia nell’efficacia ed efficienza delle istituzioni democratiche, non passa più tanto e solo attraverso il rapporto elettori-parlamentari o rappresentati-rappresentanti, ma attraverso quello governanti-governati. Questo comporterebbe allora il passaggio da una “democrazia dell’autorizzazione”, in cui il cittadino “sovrano per un giorno” (il giorno delle elezioni) si limita ad autorizzare e accordare il permesso di governare, a una “democrazia dell’esercizio”, nella quale i cittadini possono essere coinvolti in un ampliamento dell’esercizio della funzione di controllo del governo e dei poteri pubblici con compiti di rilevanza governativa, già svolta dalle assemblee parlamentari, e più in generale nella funzione di valutazione e stimolo alla responsiveness degli organi di governo e allo sviluppo della qualità di funzionamento delle istituzioni democratiche. Queste vie per approfondire la democrazia non servono solo ad ampliare e riarticolare la “sovranità popolare” (ovvero quello che pensatori come Jürgen Habermas e John Rawls chiamano l’esercizio libero della razionalità pubblica), ma anche per agevolare un necessario cambiamento di stile nel governo di società altamente complesse come le nostre, caratterizzate da contingenza, contraddizioni, rischio, incertezza: dal governo che ‘comanda’ al governo che ‘apprende’, per decidere e agire. La grande sfida attuale della politica è precisamente rendere l’incertezza riflessiva.
Una terza pista per sperimentare un “progresso” democratico riguarda il fatto che la questione dell’inefficacia e dell’inadeguatezza sempre più evidenti dello Stato-nazione di fronte a problemi mondializzati o transfrontalieri (le migrazioni, le pandemie, gli incidenti nucleari, il surriscaldamento climatico…) stride con la percezione radicata del livello locale o nazionale come livello “ottimale” per l’esercizio della sovranità dei cittadini e per la garanzia di sicurezza, libertà e stato di diritto. Per superare questo iato, perché non percorrere, accanto al processo “delegativo” mirato a rafforzare il sistema di governance mondiale, anche il processo inverso? Perché non “rimaterializzare” la governance mondiale, riservando nei parlamenti nazionali una quota, minoritaria ma attiva e non meramente simbolica, di rappresentanti degli “interessi cosmopoliti”, con i quali bisogna mediare l’interesse nazionale, circoscrivendone prerogative di iniziativa e di voto?
Questi cantieri di riforma delle democrazie contemporanee solo apparentemente riguardano la democrazia come “regime”, perché investono sempre sulla scommessa fondamentale della democrazia: il processo di “individuazione”. Vale a dire, il divenire soggetti, il forgiare la nostra individualità, attraverso la costruzione di una preoccupazione per il mondo, per gli altri, per lo stato di diritto, cioè attraverso la costruzione di un mondo comune, per dirla con Hannah Arendt. E, nelle società contemporanee, più complesse, liquide ed eterogenee, questa costruzione può e deve essere mobilitata o canalizzata non solo dai partiti tradizionali, ma da una molteplicità di movimenti e organizzazioni, perché la variabile fondamentale per descrivere le poste collettive di oggi non è tanto l’interesse del gruppo professionale o di classe, ma le “prove della vita” (dalla discriminazione razziale o di genere allo sfruttamento sul lavoro, ai rischi di disastro ambientale…) che si affrontano e che minacciano la conservazione della dignità individuale. Nel XXI secolo, viene così a cadere quello che potremmo definire il “dogma di Kelsen”: la democrazia moderna o è una democrazia dei partiti o non è.
In conclusione, la sfida della complessità, la sfida dell’incertezza, la sfida di un futuro aperto sono depositate nell’“inconscio” delle democrazie moderne. I nostri tempi ci chiedono di renderle consapevoli, per continuare l’invenzione perpetua della democrazia, per continuare l’avventura della libertà e dell’“individuazione”, della conoscenza attraverso il dubbio. L’alternativa ancora oggi sono forme di autocrazie e di “dispotismo” moderno che cercano di rendersi attraenti con la promessa di “benessere”, di coesione sociale e di sviluppo financo sostenibile, ma presentando come fittizie e controproducenti le “libertà democratiche” dell’Occidente. Quindi, esse ripropongono il fantasma della soluzione politica “ottimale”, dal congedo della quale l’esperimento democratico non a caso prese avvio in Europa alla fine del Settecento. E proprio osservando i primi risultati di quell’esperimento, nel continente americano, qualcuno scrisse: “Non c’è niente di più fecondo di meravigliosi risultati dell’arte di essere libero: ma non c’è niente di più duro del tirocinio alla libertà. Non è la stessa cosa per il dispotismo. Il dispotismo si presenta sovente come il riparatore di tutti i mali sofferti; è il sostegno del buon diritto, la difesa degli oppressi e il fondatore dell’ordine. I popoli si addormentano in seno alla prosperità momentanea che esso fa nascere; e quando si risvegliano sono miserabili”. Questo monito di Alexis de Tocqueville, enunciato nel celeberrimo La democrazia in America del 1835, andrebbe forse scolpito anche nella coscienza dei democratici del XXI secolo, secolo in cui la Storia non è finita.









