Sulla nostra specie / Terrestri tra arte, musica e illusioni
Sono un terrestre che per ragioni evolutive ancora in parte non spiegate ha una distinzione: pensare il pensiero e non solo pensare; farsi domande; parlarsi; dubitare e immaginare anche quello che ancora non c’è o non ci sarà mai; dire di no; darsi persino la morte per scelta. Non so quanti degli altri terrestri facciano le stesse cose e uno dei tanti miei limiti è non poter sentire cosa significhi essere contemporaneamente uno degli altri esseri terrestri viventi, di ogni specie o misura. Anche se riesco a immaginare di esserlo e posso illudermi di diventare gli altri, non solo umani, fantasticando persino di sentirmi quasi un pulcino o un ghepardo. Mi sento vicino alla fine del mondo, di quel mondo che a lungo ho creduto essere stato fatto per me e di cui ritenevo di essere il padrone. Per questo mi sono messo a leggere – perché anche questa è una distinzione spesso ossessiva a cui mi consegno – un libro che, tra gli altri, ha un effetto: di spiazzamento.
Mi porta continuamente a guardarmi da fuori e dalla fine di un mondo, per poi ricondurmi alle mie nevrosi e alle mie effettive possibilità. Quell’effetto è forse dovuto al bricolage tra due delle esperienze più vertiginose e travolgenti che a quei terrestri come me capiti di vivere: l’arte e la scienza. Non un’arte qualsiasi, ma quella del narrare, nella sua versione tra le più impegnative e graffianti, come l’ironia. Che bella portata onomatopeica ha la parola ironia: graffia solo a dirla. Non una scienza qualsiasi, ma quel grappolo transdisciplinare di percorsi di ricerca che cercano di rispondere alla domanda: cosa significa essere umani, cioè appartenenti a una recente, pervasiva e provvisoria specie di terrestri, magari studiando gli altri esseri per cercare di capire un po’ meglio noi stessi. Proprio quel sostantivo, umani, che poi diventa aggettivo qualificativo e sostanza prima della nostra presunzione, dando vita all’autoreferenziale e narcisistico umanesimo, o peggio, neo-umanesimo, è in fondo oggetto del libro che sto leggendo, e causa prima del nostro scontento.
Questo libro, insomma, è di quelli che non si riescono a lasciare prima di finire di leggerli e non si vorrebbe averlo finito quando si arriva all’ultima pagina. Soprattutto perché è uno specchio per vedersi, come terrestri, e non sempre è un bel vedere. L’hanno scritto uno scrittore e uno scienziato, Massimiliano Parente e Giorgio Vallortigara, e si chiama Lettere dalla fine del mondo [La nave di Teseo, Milano 2021]. L’hanno scritto? In realtà si sono scritti e ci hanno condiviso il loro carteggio epistolare. Con lettere tutto sommato brevi, essenziali, fulminanti in non pochi casi. Ma il filo conduttore è una raffinata ironia e, si sa, Vladimir Jankélévitch ci ha lasciato detto che si può vivere senza ironia e senza amore, ma mica tanto bene!
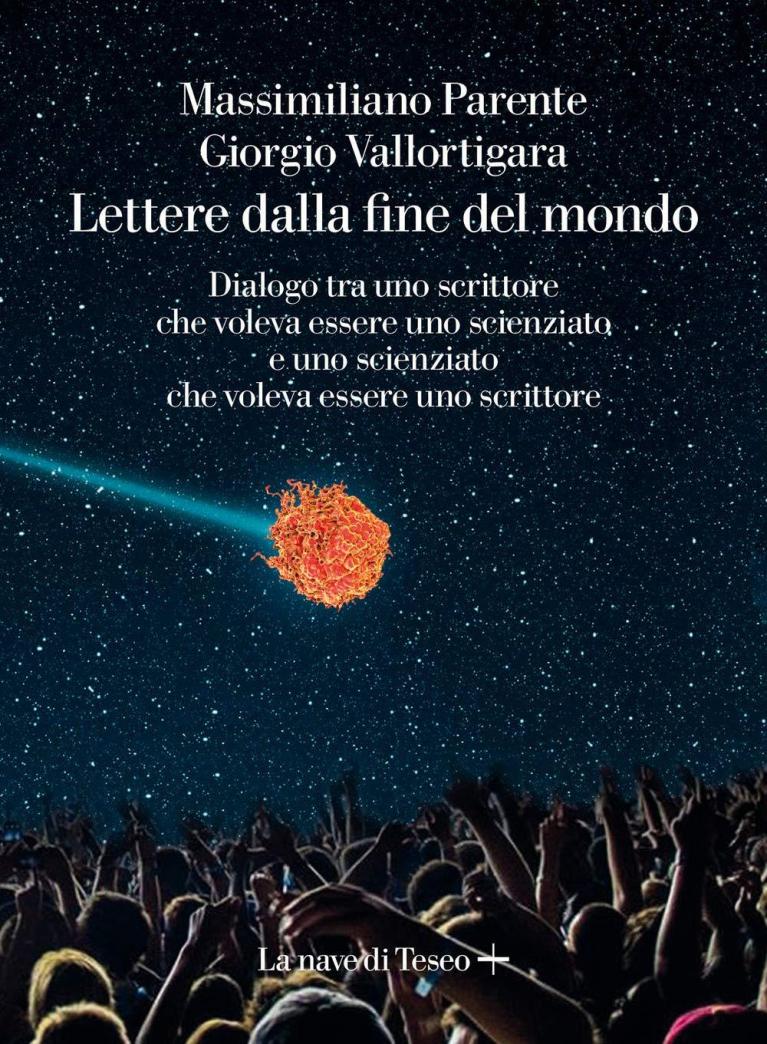
I salti e le sorprese non mancano, in ogni pagina. A pagina 27 però un terrestre come me, alla ricerca di spiegazioni sulla fine di un mondo e sulle ragioni per cui un altro mondo stenta a nascere, come se l’evoluzione da cui veniamo avesse subito un blocco, trova una pista per provare almeno a districarsi: “Il punto d’incontro, secondo me, sta lì,” scrive Giorgio Vallortigara al suo interlocutore, “nello iato tra la descrizione fisica del mondo e la nostra esperienza nel mondo, che è poi la base per edificare la conoscenza…”. Ispirato da uno dei più bei dialoghi della letteratura, scritto da Daniele Del Giudice in Atlante Occidentale, Vallortigara evidenzia contemporaneamente le ragioni della nostra inquietudine e quelle della nostra meraviglia. Il coinvolgimento nella nostra esperienza che ci esalta e ci acceca e il distacco di cui pure siamo in parte capaci, ponendoci fuori dall’habit, almeno provvisoriamente, per cercare di spiegare, capire, comprendere qualcosa di più del mondo e di noi stessi.
Guarda un po’, però, che tipo di avventure fa un terrestre addentrandosi tra le righe di questo libro! In modo inatteso, a proporsi con l’ottimismo della volontà e un tono più che positivo, positivista, provate a dire chi è dei due? Lo scrittore o lo scienziato?
“Mai come oggi serve un nuovo illuminismo”. Scrive apodittico Massimiliano Parente in una sua lettera. “Voi scienziati avete un grande potere, e come dice lo zio Ben a Spiderman: ‘Un grande potere implica una grande responsabilità’. E la responsabilità, adesso, è costruire un nuovo umanesimo. Moderno, disperato, ma finalmente umano” [p. 24].
Ma come?! Ancora un umanesimo? E per giunta “nuovo”? con tutto lo sforzo che servirebbe per deporre centralità e cercare di sentirsi finalmente terrestri tra i terrestri? Ancora un illuminismo che richiama, visti i disastri, un’illusione?
Da terrestre disorientato provo a capire. Forse significa che solo la specie che non solo sa ma sa di sapere può assumersi la responsabilità di salvarsi e salvare gli altri esseri viventi e l’ambiente da cui dipende. Quanto questa fiducia sia ben riposta lo vedremo nel resto del libro. Intanto le premesse non sono delle migliori se, come lo stesso Parente riconosce, siamo ancora lì a far iniziare il tempo in date convenzionali del tutto arbitrarie. A mitigare è ancora una volta Vallortigara, che dice che sono le convenzioni una via a cui consegnare i nostri tentativi di comprendere qualcosa di più di noi stessi.
Nel gioco delle parti tocca a Parente il compito di portare al grado zero le questioni, e ci riesce a tal punto da togliere il respiro: nessuna concessione, a parte la tentazione del nuovo umanesimo, per degli esseri che volessero provare ad ergersi almeno un poco e costruire aspettative e edificazioni di qualche tipo. Con una poetica irriverenza verso ogni, diciamo così, speranza, fornisce a Vallortigara la possibilità di documentare quel poco che sappiamo dalla scienza, con maestria e fine eleganza, anche narrativa, mostrando che, scrittore, il neuroscienziato Vallortigara non solo voleva diventarlo, ma di fatto lo è.
Io, terrestre, assisto al confronto e mi faccio domande, la prima delle quali è, ovviamente: se le cose stanno così, perché tutto questo?
Perché siamo fatti per farci domande. Sì, ma perché siamo fatti così. E qualcosa in me si ribella alla risposta: siamo fatti così perché siamo fatti così.
Sono un terrestre che per via evolutiva è giunto a farsi domande. Ogni risposta, per l’obsolescenza a cui è destinata anche ogni teoria scientifica, può risultare vana, ma rimane il fatto che ci facciamo domande. E Parente se ne fa più di quante se ne faccia un suo simile meno inquieto. Per tutto il libro, un terrestre come me non riesce a capire da che parte stia. Proprio in questo forse sta il suo contributo fuori dall’ordinario: mentre, infatti, auspica un nuovo illuminismo e un nuovo umanesimo, pratica subito il monito di Stephen Spender: si deve cercare sempre ma non bisogna crederci mai. E Vallortigara a seguirlo, pacato e rigoroso, lui da Rovereto e Parente inquieto pure epistolarmente, da ogni angolo del pianeta, alla ricerca di luoghi artificiali per cercare di placare la propria inquietudine, come quando racconta di preferire la Venezia kitsch di Las Vegas a quella malinconica e reale.
L’immagine di noi terrestri che emerge dal libro richiede una rivisitazione di non poche convinzioni erronee di cui è pieno il senso comune. Alla fine, il margine dato alla nostra specie si riduce di molto, ma c’è un gusto non secondario a ricevere un ritratto più realistico di noi stessi. Sono tante le cose che non sappiamo neppure di sapere, perché appartengono a quel genere di intuizioni implicite che deriva dalla nostra biologia evolutiva. Come sembra che sia per il dualismo. Scopriamo, verrebbe da concludere finalmente, che non c’è alcun fine e potremmo trarne una dolorosa ferita narcisistica, ma devo dire che a me invece, questo aiuta a sentirmi terrestre tra i terrestri e mi fa sentire responsabile di usare bene quello che sono e il tempo che ho a disposizione. Mi aiuta, inoltre, a cercare di smettere di appartenere a quella che Parente chiama “l’unica specie animale che deve ripetere in continuazione quanto è bella la vita” [p. 48]. Non perché la vita non sia bella, e neppure perché è anche brutta, ma perché è quella che è, e questo mi aiuta a cercare di viverla criticando le credenze che tentano anche me, ma riconoscendo, come suggerisce Vallortigara, “che esse sono le sorgenti di tutto ciò che è specificamente umano e che mi sta profondamente a cuore: attività come l’arte o la musica o la scrittura” [p. 58].
Ci vuol ben altro, però, per affrontare la forza corrosiva di ogni illusione della posizione di Massimiliano Parente. La sua replica, che si appoggia a Proust e a Beckett, rimanendo nel suo campo di esponente dell’arte della narrazione, non si fa certo attendere: “Dopo Proust c’è Samuel Beckett (il quale non a caso si laureò con una tesi su Proust), che pur non appoggiandosi alla scienza arriva al silenzio, all’impossibilità della rappresentazione, tanto narrativa quanto teatrale. In lui, alla fine, restano solo bocche parlanti, corpi incastrati, mutilati, tentativi abortiti di vita” [p. 64]. Uno spiraglio a noi terrestri tra terrestri, animali tra animali, come entrambi gli autori riconosceranno più avanti nel libro, Parente sembrerebbe concederlo, quando scrive: “Bisogna pensare più in grande, bisogna andare oltre, bisogna superare i limiti del nostro ottimismo vitalistico, questo mi sono sempre detto” [p. 65]. Ecco che fa capolino una distinzione di un terrestre della specie homo sapiens: la disposizione specie specifica a tendere all’oltre e a non coincidere con se stessi. Ci ho provato e mi sembra di sentire la reazione ancora una volta azzerante di Massimiliano Parente, vediamo. Semmai chiederò aiuto a Giorgio Vallortigara!
Mi viene in aiuto una terrestre, per cercare di inserirmi nel serrato dialogo.
Maria Grazia Portera, collocandosi a un punto di confluenza transdisciplinare, ha fatto non pochi passi importanti per cercare di comprendere l’esperienza estetica e l’estetico, come ancora si propone di fare in questo suo ultimo libro: La bellezza è un’abitudine. Come si sviluppa l’estetico, Carocci, Roma 2020. Le domande e gli approfondimenti che si pone Portera possono aiutarci a capire alcuni aspetti di noi terrestri umani che vanno dritti all’interno del confronto dialogico tra Parente e Vallortigara. L’autrice si domanda, infatti, se la bellezza sia un'abitudine; se veniamo al mondo già dotati di competenza estetica, cioè di quella peculiare capacità di sentire il bello e di apprezzare esteticamente oggetti ed eventi o, piuttosto, siamo noi stessi a dotarci, con il nostro sviluppo individuale in un contesto sociale, di quell’abito. Maria Grazia Portera combina i contributi di molte discipline concentrandosi sul fenomeno estetico e cerca di mettere a fuoco quello che lei stessa chiama il tempo lungo dell’aisthesis: quell’esperienza che si sviluppa nella vita individuale tra vincoli biologici e routines specifiche della nicchia evolutiva nella quale noi terrestri umani siamo inseriti.
Indagando la complessa famiglia di concetti che fa capo a quello di "abito" (habit, hexis, ethos, habitude, coutume), mostra come, da un lato, l'essere umano – anche per ragioni biologiche – non possa prescindere dall'acquisizione di habits in grado di dare forma al suo esperire (soprattutto estetico); dall'altro lato, come la contemporaneità iperestetizzata sembri oggi esigere, anziché una paziente formazione di abiti, l'adozione di labili, incostanti e volubili "belle" abitudini. Attraverso un'esplorazione appassionante che muove dal pensiero aristotelico per spingersi sino alle scienze cognitive e alle neuroscienze contemporanee, Portera sottolinea il valore della condivisione d'esperienza, dell'educazione estetica sin dall'infanzia, della curiosità e dell'"apertura alle cose" come vie possibili per la coltivazione della hexis aisthetikè.

Fino a qui, considerando il modo in cui Maria Grazia Portera procede, forse non siamo riusciti a contrastare le capacità critiche particolarmente impegnative di Massimiliano Parente. Allora conviene per un momento approfondire la tesi fondamentale proposta dall’autrice. L'estetico secondo Portera, o attitudine estetica o capacità estetica, intesa come un abito, o hexis, si sviluppa nel tempo lungo dell'ontogenesi al confine tra intenzionalità e a-intenzionalità, a partire da building blocks largamente non specie-specifici. Non ce l’abbiamo, infatti, alla nascita (l'estetico è epigenetico, ma ciò non significa che sia solo una costruzione culturale); lo cominciamo a sviluppare quando abituiamo l'emozione, base di tutte le esperienze estetiche, cioè quando la incanaliamo, la mettiamo in forma nell’espressività dell’interplay con l'elemento cognitivo.
C'è una lunga schiera di artisti e pensatori che ha classicamente inteso le esperienze estetiche e le arti come spinte propulsive per la rottura di routine, convenzioni e abitudini consolidate. È tuttavia vero che tale procedere propulsivo non si esplica se non come transitoria sostituzione di nuovi abiti o abitudini ai vecchi; siamo quindi di fronte a una dimensione doppia dell'estetico: come abito attivo, sempre esposto però alla passività o all'incantamento e all'abitudine.
Sarà pur vero allora, come sostiene Massimiliano Parente, che siamo nell’impossibilità della rappresentazione, ma è proprio la rappresentazione ad essere ampiamente messa in discussione da una concezione dell’esperienza estetica che ponga attenzione all’embodiment di quella esperienza. La considerazione della creatività umana e dell’esperienza estetica prendono il congedo, verrebbe da dire finalmente, dalla rappresentazione e dal mentalismo, ma anche dai generici tentativi di ricondurre l’attitudine estetica all’azione di una sola area cerebrale, o di una sinergia definita di poche aree, nonché dall’idea che alcuni tratti degli oggetti siano invariabilmente connessi al piacere estetico. “Quel che emerge oggi”, scrive Portera, “è l’importante ruolo del contesto nello sviluppo dell’attitudine estetica e la sfida delle differenze individuali, intese anzitutto come quel complesso di fattori biologici (genetici, neurofisiologici, epigenetici), culturali e sociali che ciascuno di noi è e che influenza il modo in cui esploriamo esteticamente il mondo” [p. 145n]. Ecco una via che può aiutare a percorrere la difficile strada della comprensione di noi stessi, che cerca di combinare contemporaneamente l'unicità irripetibile di ogni vita con l'appartenenza a tutto il sistema vivente.
Come sostiene Vallortigara nel libro epistolare con Parente: “La scelta è obbligata, ovviamente dobbiamo viverle le nostre vite”. E prosegue: “Penso che studiando, sperimentando e cercando di comprendere il mondo modifico me stesso, e in questo modo conto di arrivare a un'intuizione che, seppure non comunicabile in termini oggettivi (cioè intersoggettivi), possa essere soddisfacente per il me stesso “trasmutato”, filosofale”. La composizione della nostra esperienza con l'analisi scientifica dei fenomeni, anziché essere considerata una mortificazione della ricchezza e della bellezza che noi possiamo essere, può concederci una consapevolezza più complessa e ricca di noi. Non è sostenibile che la spiegazione scientifica spoetizzi il mondo, gli tolga l'incanto. Giorgio Vallortigara, infatti, si chiede: ma davvero lo sguardo scientifico distrugge la bellezza delle cose? E aggiunge: “non capita di smettere di trovare incantevole un arcobaleno ai fisici per il fatto di conoscerne il meccanismo ottico, le gocce in sospensione che funzionano come prismi dando luogo a uno spettro quasi continuo della luce che viene riflessa e rifratta, o ai neurobiologi per il fatto di conoscerne il meccanismo percettologico, con l'attivazione dei recettori che rispondono alle diverse lunghezze d'onda nei coni retinici e i vari processi di opponenza nelle diverse stazioni del sistema visivo fino alle aree della corteccia come V4. Forse dovremmo fare uno sforzo maggiore assieme agli artisti e agli scrittori per convogliare quest’idea che ricostruire la profonda ragion d'essere delle cose non le svilisce, anzi ne accentua la bellezza” [p. 144].
A questo punto un terrestre come me avrebbe potuto pensare a una risoluzione in termini di chiarezza del serrato confronto, della disputa, nel senso più nobile del termine. E invece no. “…il mio scopo era arrivare a distruggere ogni forma di illusione…”, dichiara Parente [p. 150], parlando della propria opera letteraria. E si ricomincia. È proprio l'illusione a riaprire il gioco. Illudersi infatti non riguarda soltanto ritenere vero qualcosa che vero non è, ma riguarda, come ci suggerisce l'etimologia, stare in un gioco o giocare dentro una situazione che combina contemporaneamente la complessità delle esperienze e la ricerca della spiegazione scientifica dei fenomeni. Se c'è un contributo di particolare rilevanza che la ricerca scientifica e la creatività artistica e letteraria possono fornirci, consiste probabilmente nell’abitare la tensione tra queste due dimensioni della nostra vita. Giorgio Vallortigara confida, ricorrendo a Borges, la propria personale congettura riguardo a ciò che assomiglia di più all'esperienza della bellezza, e cita il grande argentino: “La musica, gli stati di felicità, la mitologia, i volti scolpiti dal tempo, certi crepuscoli e certi luoghi, vogliono dirci qualcosa, o qualcosa dissero che non avremmo dovuto perdere, o stanno per dire qualcosa; quest’imminenza di una rivelazione, che non si produce, è, forse, il fatto estetico” [p.159]. L’atto di creazione risulta perciò essere eminentemente immaginifico e analogico: “È come se il linguaggio (ordinario o logico-matematico che sia) mettesse in ordine il pensiero, ma senza esserne il generatore primigenio”, sostiene Vallortigara.
Avrà alla fine il coraggio, con tutta la sua pazienza, Giorgio Vallortigara, di raccogliere la sfida di Massimiliano Parente, “di non lasciare ai posteri l’ennesima favola sulla vita”? [p. 275]. E bisogna riconoscere che ce la fa, e consegna a Parente e a noi un aiuto non piccolo a riconoscere la nostra natura di terrestri: “…creduloni si nasce e pure io e te, come diceva quel principe napoletano, modestamente, lo nacquimo”.









