Tre volte Italo Svevo
Letizia Svevo Fonda Savio preferiva raccontare quell’episodio in italiano. Forse per non mettere in difficoltà i giornalisti “regnicoli” che venivano a intervistarla. Gli inviati, insomma, che arrivavano da un mondo tanto amato, eppure lontanissimo: il Regno d’Italia. Visto che Trieste, fino al 1918, era stata sottomessa volontariamente, con un atto di dedizione datato 30 settembre 1382, all’Impero asburgico. La Defonta, come la chiamavano i triestini con ironia e un pizzico di nostalgia, dopo la morte di Franz Joseph e l’inevitabile crollo del regno austroungarico.
In realtà, Letizia avrebbe fatto meglio a spiegarlo in triestino, quel buffo episodio. Visto che era proprio il dialetto la lingua madre di suo papà, il signor Ettore Schmitz. Diventato uno scrittore famoso pochi anni prima di morire con il nome d’arte di Italo Svevo, in omaggio alla cultura tedesca e alla lingua italiana, che avrebbe voluto maneggiare molto meglio. Anche perché gran parte degli studi li aveva fatti nel collegio di Segnitz-am-Main in Baviera. Dove suo padre Francesco lo aveva iscritto, insieme ai fratelli Adolfo e Elio, sperando che un giorno potessero diventare buoni commercianti padroneggiando le lingue straniere.
Quello che raccontava Letizia racchiudeva in sé molti aspetti del carattere di Ettore Schmitz. Da tre giorni, lo scrittore aveva smesso di fumare, per rispettare una delle infinite promesse fatte a se stesso. “Mi sento già un altro uomo”, si era precipitato a confidare alla figlia e a suo marito, Antonio Fonda Savio. “E quell’altro uomo – aveva aggiunto subito – ha una gran voglia di fumare”.
Ecco, appunto: il fumo, le sigarette, sono state per tutta la vita il suo sommo piacere e un continuo tormento. Che Italo Svevo sapeva esorcizzare con l’inconscio desiderio di sdrammatizzare il lato oscuro della vita. Con quella verve di giocoliere, di inventore di witz, di intrattenitore dei familiari e degli amici, sempre pronto ad architettare irresistibili scherzi e battute di spirito. Una messinscena che mascherava, in realtà, il suo interno arrovellarsi. L’ansia che nemmeno il bromuro e altri rimedi chimici riuscivano a tenere a freno. La sua lotta infinita, insomma, contro le “rane moleste” che gracidavano pensieri tenebrosi dentro la testa.
“Oggi compio 28 anni – scriveva nel 1889 –. Il malcontento mio di me e degli altri non potrebbe essere maggiore. Noto questa mia impressione perché forse di qui a qualche anno potrò darmi una volta di più dell’imbecille trovandomi anche peggio, o potrò consolarmi ritrovandomi migliorato”.
Una lotta con il fumo durata tutta la vita, quella di Schmitz-Svevo. Capace di regalargli momenti bellissimi, ma anche coincidenze tragiche. Basti pensare che la madre Allegra Moravia smise di vivere alle quattro di pomeriggio del 4 ottobre 1895. Proprio mentre suo figlio Ettore “si proponeva di fumare l’ultima sigaretta, che purtroppo non fu mai l’ultima”.
In quell’occasione, Schmitz rischiò di veder svanire perfino il suo nascente amore per la cugina Livia Veneziani, diventata in seguito la moglie amatissima, la “ca(p)ra bionda” di cui era molto geloso. Con lei, infatti, aveva fatto una scommessa. Se avesse rinunciato per sempre al fumo, infatti, Livia gli avrebbe dato il primo, casto bacio. Ma pochi minuti dopo Ettore era già lì, con l’ennesimo “spagnoleto”, come lo chiamano a Trieste, acceso tra le dita.
Vana è stata la continua ricerca di un modo per liberarsi dal fumo. Tanto da convincere Italo Svevo a tentare i giuramenti più astrusi, pur di vincolarsi a una promessa che avrebbe infranto di lì a poco. Lo racconta Riccardo Cepach, da quasi vent’anni responsabile dei Musei dedicati da Trieste a Svevo e Joyce, nel suo sfizioso, documentatissimo libro Ultima sigaretta. Italo Svevo e il buon proposito, pubblicato dalla casa editrice Acquario (pagg. 157, euro 15). Un saggio puntuale e pieno di informazioni, che non rinuncia mai a concedersi una verve narrativa frizzante e capace di rendere meno distante un’icona della storia della letteratura come il signor Ettore Schmitz.
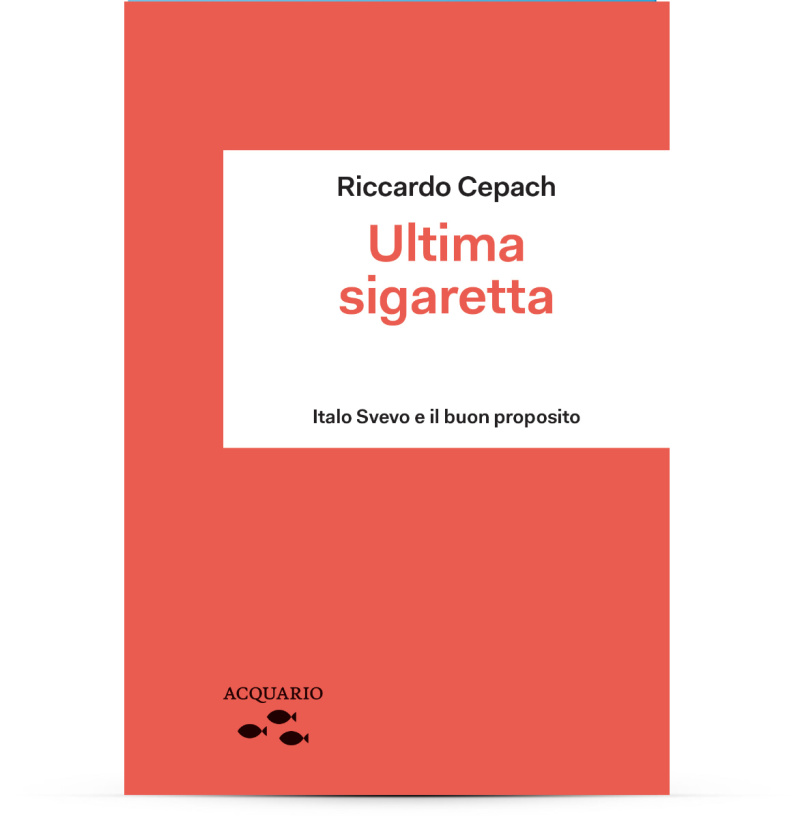
In una delle tante carte custodite dal Museo di Trieste c’è una “formola di giuramento”, scritta a mano da Svevo, in cui si legge: “Oggi domenica 21 marzo 1897 ore 12 ant. Ettore Schmitz dopo aver esaurito tutte le formole di giuramento giurò solennemente sul coperchio del cesso di non fumare più amen!”. Del resto, Svevo era quello che aveva riempito di graffiti le pareti di un suo alloggio da studente con la scritta U.S. accompagnata da molte date tracciate con colori diversi. Salvo, poi, doversi affrettare a far tappezzare la stanza a sue spese per coprire quel puzzle di promesse infrante.
Giuramenti solenni, deboli rassicurazioni più a se stesso che agli altri. E poi lettere alla moglie Livia, cartoline, biglietti al fratello Elio, al cognato Bruno, ad altri parenti e amici. Tutti contrappuntati dal medesimo pensiero: liberarsi dalla U.S. Che, come spiegava Svevo stesso, niente aveva a che fare con gli United States. Perché la reiterata promessa di fumare l’ultima sigaretta scandiva i tempi di un gioco fatale, di una magnifica ossessione, impossibile da vincere.
In fondo, la velleitaria rinuncia al fumo rappresentava per Ettore Schmitz una sorta di diga costruita per tenere a bada il tempo. Una sorta di incantesimo, insomma, che riuscisse a pacificare il passato proiettandolo verso un futuro contrappuntato di buoni propositi. Mentre il presente poteva scorrere rettilineo, esorcizzando il pensiero della Morte.
Fino a quando, infatti, fossero esistite “formole di giuramento” da ripetere all’infinito, senza mai onorarle, si poteva credere che i buoni propositi conservassero intatta la loro vaghissima possibilità di realizzarsi. Sfuggendo al vizio assurdo della letteratura, al troppo libero e sfrenato dispiegarsi della creatività, del sogno, alla tentazione di scrivere. Solo così Schmitz poteva vagheggiare di diventare finalmente un vero, affidabile borghese. Un venditore di vernici sottomarine, un industriale credibile e rispettato. Non lo scrittore fallito con la testa piena di pericolose fantasticherie.
Al caos dell’esistenza, insomma, Ettore Schmitz poteva opporre questo suo “meccanismo circolare”, come lo chiama Cepach, “in cui la causa viene scambiata con l’effetto, rendendo la trappola del fumo inesorabile”. E se mai le tormentose “rane” avessero cercato di smantellare quel suo pensiero reiterato, lui poteva sempre aggrapparsi all’aiuto dell’amato Arthur Schopenhauer. Là dove il filosofo tedesco diceva, da gran fumatore, che “tutti i piaceri non sono altro che la cessazione di un dolore”.
Non è a caso se James Joyce, il 30 gennaio del 1924, scrivendo da Parigi all’amico Svevo, ancora ignorato dai critici e dai lettori, annotava a proposito di La coscienza di Zeno, che gli era appena arrivata in omaggio da Trieste: “Per ora due cose mi interessano. Il tema: non avrei mai pensato che il fumare potesse dominare una persona in quel modo. Secondo: il trattamento del tempo nel romanzo”. L’autore dell’Ulisse, che già aveva apprezzato Una vita, ma soprattutto ammirato quel gran congegno a orologeria sull’impossibilità di amare che è Senilità, annotava ancora che l’opera terza “è di gran lunga il Suo miglior libro”.
Parole che non scriveva tanto per tacitare un collega frustrato e deluso dalla letteratura, al punto da promettere che mai più avrebbe scritto perché non valeva la pena alimentare quella “ridicola e dannosa cosa”. Al contrario, Joyce era davvero convinto che Svevo fosse un grande innovatore del romanzo. Anche se batteva strade narrative diversissime dalle sue. E aveva una famiglia borghese alle spalle, una moglie e una figlia devote della religione cattolica, una suocera come Olga Moravia Veneziani che pensava soltanto “a seminare caldaie nel mondo” per produrre la segretissima vernice destinata a proteggere gli scafi delle navi. E accumulare molti più soldi di quelli che, in realtà, spendeva.
Eppure, in quel borghese stregato di Ettore Schmitz, il professor Zois, come lo chiamavano a Trieste, aveva trovato un amico vero. Perfettamente corrispondente alla teoria di Giordano Bruno sulla coincidenza dei contrari. Lo dimostra Enrico Terrinoni, ordinario di Letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia, traduttore degli ultimi libri di Finnegans Wake insieme a Fabio Pedone e dell’Ulisse, nel suo prezioso, godibilissimo saggio biografico La vita dell’altro. Svevo, Joyce: un’amicizia geniale (Bompiani, pagg. 245, euro 20).
In rotta di collisione con la natia Irlanda e con la religione cattolica l’uno, l’altro costretto a guadagnarsi da vivere facendo lavori non amati, la Banca Union prima, la fabbrica Veneziani poi, perché il mondo della letteratura gli aveva sbattuto la porta in faccia. Eppure, entrambi animati, fin dall’adolescenza, da una bruciante voglia di scrivere. Capaci di rompere gli schemi del romanzo classico e di “letteraturizzare” la vita, si incontrarono per caso. La versione ufficiale dice che Svevo aveva bisogno di un’insegnante di inglese. E Joyce, approdato alla Berlitz School di Trieste, era di gran lunga il più bravo.
Ma di sicuro, racconta Terrinoni, si fiutarono, si avvicinarono ben prima di quel 1907, data d’inizio delle loro lezioni. Del resto, come poteva non diventare amico di Schmitz uno come Joyce, che amava perdutamente Nora, di cognome Barnacle. Visto che i “barnacles” in inglese sono i cirripedi, ostinati crostacei che si attaccano allo scafo delle navi. E che solo la magica vernice prodotto dalla Veneziani, di cui il signor Ettore era uno dei punti di forza, riusciva a mettere in fuga.

Joyce era un dublinese esule volontario, Svevo “esule e outsider per natura e per cultura”, come lo definisce Terrinoni, ebreo ma battezzato, legato al mondo tedesco eppure italianissimo irredento. Nonostante i poco più di vent’anni di differenza, insieme diedero vita a quello che la fisica quantistica definisce un “entanglement”. Ovvero, un legame di natura fondamentale tra particelle, anche quando si trovano a distanze molto grandi, che permette all’una di influenzare le proprietà dell’altra.
È indubbio, dice Terrinoni, che Leopold Bloom sia costruito pensando a Svevo. E che Anna Livia Plurabella sia un evidente omaggio a Livia Veneziani, alla sua splendida massa di capelli biondi dai riflessi ramati. Tanto che Svevo, invitato a Parigi dall’amico irlandese, vorrà fargli omaggio del ritratto della moglie dipinto dall’amico Umberto Veruda. Nonostante la sua devastante gelosia, che lo portava a sospettare della fedeltà della moglie con ossessiva puntualità. Soprattutto quando andava a “passare le acque” alle terme di Salsomaggiore: “Sento una pressione alla testa – le scriveva –. Che mi cresca qualcosa lassù?”.
Ma è anche vero, come rivela Terrinoni, che nella stessa Coscienza vi sono tracce evidenti del professorino irlandese. Soprattutto quando vengono descritte lunghe chiacchierate con un personaggio senza nome, che altri non è se non lo stesso James con cui Schmitz si intratteneva molto volentieri, anche al di là del perimetro angusto delle lezioni d’inglese. E dell’amata-odiata letteratura.
Accanto ai dati evidenti dell’amicizia, scrive Terrinoni, ci sono poi “coincidentiæ”, a cui dedica l’intero capitolo finale. “Le loro vite, come i loro libri – spiega –, sono infatti abitate anche da numeri, cifre, date, orari, che le colorano di misteriosi echi”. Come il 13, il “numero della morte” per Leopold Bloom; basterebbe ricordare che Schmitz si spense, dopo un incidente automobilistico, il 13 settembre 1928 e Joyce il 13 gennaio 1941.
E, ancora, non bisogna scordare che Svevo scrisse nella primavera del 1928, pochi mesi prima di morire: “E ora che cosa sono io? Non colui che visse ma colui che descrissi”. Paradosso che lo stesso Cepach è andato a scandagliare in un’altra raccolta di saggi: La funzione S. E altri esperimenti di critica sveviana (Franco Cesati Editore, pagg. 174, euro 20). In cui attraverso le multiformi e molteplici mutazioni di Ettore Schmitz-Italo Svevo (senza scordare il suo terzo incomodo Zeno Cosini), che lo portavano a farsi coinvolgere dalle “più audaci e aggiornate avventure del pensiero contemporaneo, ma curioso anche delle teorie pseudoscientifiche e para filosofiche in voga”, si esplorano i tanti volti di un uomo che Bobi Bazlen inchiodava al suo apodittico giudizio: “Non aveva che genio. Per il resto era stupido, egoista, opportunista, calcolatore e senza tatto”. E che, al contrario, il critico d’arte e di costume Gillo Dorfles ricordava come una persona deliziosa: “Un uomo alla mano, cordiale, spiritoso e autoironico”.
Cepach, però, non cade mai nella trappola di trasformare lo scrittore triestino in un artista fin troppo colto e aggiornato, oppure di liquidarlo come un dilettante geniale capace di orecchiare qua e là le tematiche alla moda per poi riutilizzarle nei libri che andava scrivendo.
Scandagliando gli interessi di Svevo per lo spiritismo e per certe ardite teorie mediche, analizzando la sua ansia di pacifismo e la questione del tempo e della memoria negli scritti, Cepach non può non interrogarsi sul personaggio più sfuggente e misterioso della produzione letteraria sveviana: il fantomatico dottor S., “psico-analista”. Ma se davvero, si chiede il saggista, è stato lui ad alterare il testo elaborato da Zeno dietro suo consiglio, per pubblicarlo a piacimento senza consultarlo, perché poi lo stesso Cosini non si è vendicato al momento di iniziare a scrivere il quarto romanzo? Perché non ha rimesso a posto i conti con la storia nel “Vecchione” o “Vegliardo”, rimasto purtroppo incompleto, e di cui sopravvivono soltanto pochi, frammentati capitoli?
Forse perché, scrive Cepach, “la Funzione S. è necessaria per mostrare che la lotta delle idee e delle opinioni è più vera dell’affermarsi di un’unica prospettiva, perché non esiste nessun punto di vista che non sia orientato, parziale, personale”.
E allora, per capire davvero Ettore Schmitz, l’ebreo e il cattolico, il socialista e il liberale irredentista forse massone, lo scrittore e l’industriale, bisogna fermarsi a ricordare le sue parole in punto di morte. Dette, con un sorriso sulle labbra, alla figlia Letizia. Questa volta, sì, nell’amato dialetto triestino. “No pianzer, Letizia, no xe niente morir”. Una frase che dice quanto, per lui, fosse stato molto più difficile vivere.
Lo conferma il fatto che, a pochi istanti dalla morte, il dottor Aurelio Finzi, che era anche nipote di Svevo, gli negò il piacere di fumare una sigaretta nell’ospedale di Motta di Livenza. E Schmitz, con un sorriso rassegnato, mormorò: “Peccato, sarebbe stata davvero l’ultima”.









