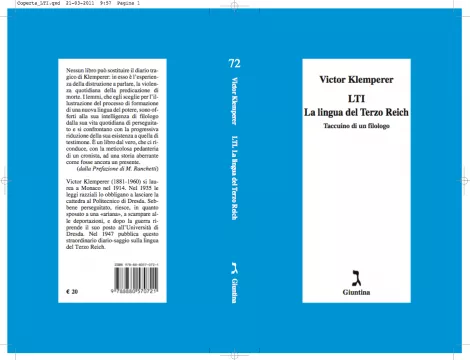Victor Klemperer. Cronache di una vita e di una lingua
Pubblichiamo qui due riflessioni di Roberto Gilodi e Michele Ranchetti sugli scritti di Victor Klemperer.
“Sistemando il pacco del manoscritto, mi tormentavo ancora una volta chiedendomi se mai riuscirò a utilizzare tutto ciò che ho accumulato. Ma non posso pensare a queste cose se non voglio sprofondare nell’assoluto non essere”.
È il 20 gennaio 1945 quando il filologo e francesista Victor Klemperer (1881-1960) chiude le annotazioni della giornata con queste parole.
Ormai le sorti della guerra sembrano segnate, gli eserciti alleati hanno avviato l’offensiva finale e stanno per invadere la Germania. Ma quanto tempo dovrà ancora passare prima della resa? E quando nel febbraio del 1945 i nazisti decidono di deportare anche le coppie miste, Victor e sua moglie Eva (lui ebreo assimilato e convertito al protestantesimo, lei ‘ariana’), si chiedono se da ultimo la macchina dello sterminio inghiottirà anche loro.
La vicenda di Klemperer, allievo di Vossler e collega di Auerbach e di Curtius, è emblematica di un’intellettualità ebraica per la quale l’’integrazione’ ha significato, fin dai tempi di Moses Mendelssohn, l’adesione convinta ai valori della Aufklärung e della tradizione umanistica europea. Con l’avvento del nazionalsocialismo e con la progressiva erosione delle basi di legittimazione culturale del pensiero laico-illuminista, Klemperer inizia un’analisi sistematica dei cambiamenti in atto a partire dal terreno che gli è più familiare, la lingua. S’interroga su come l’ideologia del Terzo Reich produca nuove parole e trasformi il significato di quelle esistenti, su come razzismo, antisemitismo, nazionalismo, culto delle origini, incidano, spesso inavvertitamente, sugli usi linguistici quotidiani. Da questo studio minuzioso, condotto a partire dal 1933, nasce Lingua Tertii Imperii, il volume che vedrà la luce nel 1947 (La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, Giuntina, Firenze 1998). Intanto, parallelamente a questi studi sul linguaggio, Klemperer annota indefessamente nei suoi diari i fatti minuti della sua vita, con l’intento di predisporre una sorta di immenso archivio della memoria in grado di raccontare la vicenda di quella catastrofe morale collettiva a partire dalla dimensione del quotidiano.
Dei Tagebücher, usciti in Germania nel dopoguerra, i lettori italiani conoscono Testimoniare fino all’ultimo: diari 1933-1945, apparso da Mondadori nel 2000, da cui rimanevano esclusi i sei mesi successivi al ritorno dei Klemperer a Dresda.
Il libro ora pubblicato da Scheiwiller, con una bella prefazione di Antonio Moresco, E così tutto vacilla. Diario del 1945 colma questa lacuna.
In queste pagine il quotidiano incrocia di continuo la grande storia e la lotta per la sopravvivenza segue passo a passo la catastrofe nazionale in un estremo tentativo di arginare il nulla, il “non essere”, la distruzione del senso, che accompagna la distruzione materiale e con essa l’impossibilità della memoria.
La vera e propria ossessione di Klemperer è annotare il dettaglio, restituire la dissonanza confusa delle voci, approntare liste di oggetti, misurare gli spazi, le ore, i minuti, con il rigore di un cartografo, con la precisione di un archivista e con l’acribia del filologo, a cui sta a cuore l’integrità materiale del testo, consapevole che solo su di essa può fondarsi un’interpretazione attendibile.
La sua sfida sarà allora raccontare il maggior numero di cose, senza farsi condizionare da un ordine espositivo o da una gerarchia d’importanza degli eventi. Quasi si trattasse di un’estrema missione etica dinanzi alla quale le risorse tecniche della narrazione, le retoriche dell’espressione e della comunicazione si rivelano armi spuntate o peggio dissimulazioni del vero.
La forza straordinaria di questo libro infatti non risiede nella coerenza di un disegno esplicativo o nella potenza dei ragionamenti e delle analisi ma nella capacità di accumulare dati sensoriali, una miriade di fotogrammi, di registrazioni dirette, una sorta di puzzle visivo e sonoro da cui si evincono i contorni di una vicenda nota, osservata tuttavia da una prospettiva inedita.
La memoria di Klemperer è minimalista, vive di frammenti, di brevi intermittenze di senso, di brandelli di narrazioni, di impressioni nette ma non necessariamente coerenti. La sua missione è salvifica non narrativa.
In questa immersione nel quotidiano, nell’osservazione di gesti, parole, sguardi, nell’ascolto dei rumori, nella percezione tattile degli oggetti, negli odori delle osterie appare una dimensione del popolo in guerra, che non era mai stata raccontata con tale mescolanza di understatement e partecipazione. Mai il testimone si era avvicinato così tanto alla materialità della vita, mai lo sguardo si era fatto così radente e prossimo all’oggetto osservato. Come se per esorcizzare la grande catastrofe nichilista, il professore di linguistica ebreo avesse deciso di salvare dalla distruzione e dall’oblio le entità minime della vita.
Ogni tanto, da questo accumulo percettivo, balena una riflessione, una breve traccia di ragionamento, un accenno di sistemazione, ma poi l’ansia di ‘salvare’ benjaminianamente i fenomeni dallo sguardo di Medusa del concetto riprende il sopravvento e sono di nuovo le cose a parlare il loro linguaggio contraddittorio e con esse gli attori minimi, l’ordinary people, di questo grande dramma senza regia, senza una ratio che ne riscatti l’immensa banalità.
Cultore convinto dell’antiretorica e della sobrietà intellettuale, il professore di Dresda sembra quasi proibirsi il gesto della critica che tutto delimita e fissa in superiori unità di senso.
Viene naturale pensare a Primo Levi, autore anch’egli di una battaglia contro le retoriche della colpa e della disperazione, e viene spontaneo il confronto fra i due testimoni. Ebbene, quando Levi si fa scienziato del male assoluto è sorretto ancora dalla certezza che se c’è memoria ci può essere ragione e quindi conoscenza. In Klemperer il male è talmente fluido e ubiquo da non essere afferrabile dal gesto potente e insieme impotente della ragione. La sua missione primaria è l’accumulo, la costituzione di un grande magazzino di sensazioni, che attendono il giorno in cui dalle retrovie dei saperi uscirà l’umile artigiano in grado di disporre l’insieme caotico in un ordine finalmente intelligibile. Una sorta di filologo della catastrofe, la cui preoccupazione sarà stabilire un testo attendibile, che altri un giorno si incaricheranno di interpretare.
E tutto questo apre interrogativi interessanti. Anzitutto suggerisce un modello di lettura della storia che si carica di tutta la parzialità e fallibilità della visione diretta e dall’interno degli accadimenti: la ‘prospettiva’ è annullata dalla parzialità e dalla contraddizione dei mille volti della realtà. Ma l’assenza di unità prospettica, se rende ardua la sintesi concettuale, consente tuttavia un formidabile incremento di esperienza. Visti da vicino, i tedeschi sono tutto e il contrario di tutto: rassegnati alla sconfitta, pronti al riscatto, delusi del regime, orgogliosamente nazionalisti, risolutamente antinazisti. Nei giorni drammatici e interminabili della dissoluzione finale Klemperer legge la genesi della grande ubriacatura collettiva, capisce come si sia radicata la forza del regime e quanto sia ora doloroso il disincanto.
Se “la critica - come diceva Benjamin - è una questione di giusta distanza”, se essa “è a suo agio in un mondo dove ciò che conta sono prospettive e visioni d’insieme” allora la storia dal basso, la storia annotata nelle cadenze del quotidiano appare come il suo contraltare che ne vanifica la pretesa di verità.
L’autore di questo diario, scritto sotto le bombe di Dresda, su giacigli di fortuna, nelle brevi pause dei lunghi trasferimenti a piedi, ha saputo unire con rara abilità percezione e memoria e da questo strano impasto ha tratto fuori un’immagine della “caduta degli dei”, che forse nessuna critica storica era riuscita a fornire con tanta lucida evidenza.
Roberto Gilodi
Nello scritto introduttivo al Curriculum vitae, uno dei due progetti che il filologo tedesco Victor Klemperer durante la stesura del suo diario si proponeva di condurre a termine (l’altro è questo volume sulla lingua del Terzo Reich) figura forse la sola eccezione alla sua abituale reticenza, quasi un’ostilità, a riassumere e ad iscrivere il senso del suo lavoro e della sua esistenza in una prospettiva diversa da quella della testimonianza. Scrive infatti che, da piccolo, usava ritagliare i soldatini di carta dai grandi fogli che gli regalava sua madre e metterli, tutti insieme, in una scatola, senza ordine alcuno di gradi, appartenenze, eserciti, epoche. Il giovane ebreo, era nato nel 1881, figlio di rabbino, e scriveva nel 1938, si immaginava la possibilità (fantasia e incubo insieme, presagio e speranza), l’idea e la rappresentazione, di una battaglia universale dove, evidentemente, non avrebbe avuto più senso ormai prevedere campi avversi e diritti, giustizie contrapposte, vincitori e vinti, strategie di vittoria e di distruzione. Come è nota costante in Klemperer, tuttavia, la profezia apocalittica e risolutrice non è pensata e scritta con caratteri di fuoco, è semplicemente riferita con il linguaggio burocratico e pedante dell’insegnante scrupoloso e non geniale. In tal modo, anche se talvolta il riferimento ai soldatini di carta riappare nelle pagine introduttive al Curriculum, rimasto interrotto, e nel diario, la metafora di una battaglia universale senza strategia, che avrebbe potuto reggere il senso di un’esistenza colpita a morte dalla persecuzione, viene lasciata cadere, così come ogni altro possibile significato metastorico, in favore della necessità, questa divenuta sempre più assoluta, di lasciare una testimonianza: “Io devo lasciare testimonianza sino all’ultimo”.
Anche gli altri propositi di scrittura, nel corso della stesura del diario, come la prosecuzione dei suoi lavori eruditi, subiscono la stessa sorte: rimane solo il diario, lo straordinario diario che Klemperer comincia a redigere da giovanissimo, quasi al tempo dei soldatini di carta, e che lo accompagnerà sino alla morte, come un insieme di fatti minuti, non scelti per la loro rilevanza strategica, ma solo per la loro occorrenza, entro una vita singolare ma non eccezionale, di borghese ebreo, incerto sulla propria vocazione, ma certamente estraneo a qualsiasi ‘trascendimento’ di essa, poco incline ai riti e ai caratteri di una particolare professione di fede (si farà protestante per qualche tempo, per poi ritornare a riconoscersi ebreo), scrupoloso nel suo lavoro di filologo, sufficientemente curioso di culture e di uomini (ma il suo ritratto di Croce nel Curriculum non è certo esemplare). In realtà è proprio il carattere di questo eccezionale documento a costituire quasi un unicum nella letteratura diaristica di questo secolo: Klemperer infatti non redige un’autobiografia, anche se parla di sé, non si interroga sui propri sentimenti, non costruisce un itinerario di perfezione o di esperienza, non si propone di conoscere se stesso e il mondo, non sembra mosso da alcuna esigenza, da alcuna interrogazione particolare, su di sé, sul senso della vita: scrive di sé, dei suoi incontri, di ciò che gli capita per una necessità di offrire testimonianza al di fuori di qualsiasi valore che egli possa attribuire a sé o alle cose che vede o che fa lui stesso. Solo che su questa vita, così minuziosamente descritta, gradualmente e con scarsa consapevolezza, con modesta naturale partecipazione affettiva, altrettanto gradualmente e minuziosamente come la banalità della vita quotidiana, si inserisce per non più lasciarla la persecuzione da parte del movimento prima e poi del partito e del potere nazista.
È un processo di erosione al quale Klemperer offre una resistenza non passiva, ma paziente, minuziosa, in vista della sopravvivenza individuale, di sé e della moglie ariana cui deve la propria salvezza relativa: non molto di più, ed è di questo che tratta il diario quotidiano in cui le riflessioni sono scarsissime, quasi che esse fossero un residuo non più disponibile di tempi diversi in cui la letteratura, l’esercizio delle professioni liberali, il gusto del vivere erano ancora possibili. La mancanza di una prospettiva, di una ragione per cui la persecuzione avvenga, l’assenza di una ribellione alla tragedia nel nome di una tragica provvidenza distruttiva, il rifiuto sotteso di ogni credenza ad un destino, danno alla testimonianza un carattere di assolutezza e di necessità: ogni particolare non deve essere trascurato, ogni angheria, la più miserabile come il più efferato esempio di terrore e di morte: tutto è sullo stesso piano, tutto viene trascritto nel diario, dalla riduzione della razione di tabacco al nome della cugina che si impicca: la tragedia è fatta solo di particolari.
Tuttavia, su questo minuzioso terrore, a partire da metà degli anni trenta, si profila un progetto, che corrisponde anche, in certa misura, alla sua professione di filologo. Klemperer si accorge che, fra le tante forme della crescita del potere nazista, una rappresenta per lui in particolare la forma per eccellenza della distruzione del senso della libertà e dell’esistenza naturale: la distruzione della lingua o, meglio, l’occupazione della lingua da parte di Hitler e dei suoi scherani. Gradualmente, ma con un processo che sembra naturale, e inarrestabile, la lingua tedesca subisce come una conversione alla ideologia tedesca. Anche questo è un processo minuzioso e non dichiarato: è una conquista lenta che si esercita mediante le parole e non le armi. Le espressioni vengono distorte dal loro significato originario, costrette ad assumere un valore e una violenza diversa. Klemperer procede da filologo, le annota, le confronta fra loro, ne compone una sorta di vocabolario o di glossario e si immagina, forse riprendendo l’antica metafora della battaglia universale, di disporre le nuove parole come soldati del fronte nazista, in lotta con l’universo delle lingue liberali.
Il progetto cresce ogni giorno, e, nel diario, si connette con la descrizione delle vicende quotidiane, e si confonde quasi con esse: non riesce ad isolarsi, a divenire una ricerca erudita. Per questo, Klemperer non si avvale di altre fonti, oltre alla esperienza del linguaggio di ogni giorno e della propaganda hitleriana. Neppure fa intervenire altri autori che, prima di lui, avevano interrogato la lingua e certamente da lui conosciuti: Hamann o Humboldt sono assenti dalle sue note. Inoltre, e forse in misura che può sorprendere, per un filologo di professione, non si pone, anche qui, come nella narrazione della tragedia, domande che possano far intravedere una o più ragioni, una teoria della distruzione della lingua: Klempererer si limita ad annotare, con un rancore che sa inerme, i fatti, il procedere dell’orda contro la lingua che è o era la sua, la lingua di un liberale tedesco ebreo della metà del ventesimo secolo. Ed è giusto forse riconoscere che Klemperer, anche se non sembra prenderne atto, gradualmente si identifica con la propria lingua: è lui, ad essere attaccato, travolto, deportato altrove dal suo linguaggio, costretto ad espressioni non sue per poter comunicare con gli altri. Troverà, per questo, una straordinaria espressione di Rosenzweig che premetterà, come epigrafe, alla edizione della sua Lingua Tertii Imperii, che uscirà, a guerra finita, lui vivente, unico risultato pubblico del suo diario: La lingua è più del sangue. Avrebbe potuto ricordare altre sentenze della tradizione ebraica: “Morte e vita sono in potere della lingua” dai Proverbi, o “Radice del pensiero è il cuore, da cui spuntano quattro rami, il bene e il male, la vita e la morte, e su di loro domina padrona la lingua” dal Siracide.
Altri, anche prima di Klemperer, in Germania e altrove, si sono occupati della lingua del Terzo Reich: sono ricerche erudite, consapevoli, molto più raffinate e complesse di LTI. Sulla propaganda hitleriana, sulla retorica del consenso di Goebbels, sullo stile dell’orrore, ormai c’è una letteratura vastissima. Nessun libro, tuttavia, può sostituire il diario tragico di Klemperer: in esso è l’esperienza della distruzione a parlare, la violenza quotidiana della predicazione di morte. I lemmi, che egli sceglie per l’illustrazione del processo di formazione di una nuova lingua del potere, sono offerti alla sua intelligenza di filologo dalla sua vita quotidiana di perseguitato e si confrontano con la progressiva riduzione della sua esistenza a quella di un testimone. È un libro dal vero, che ci riconduce, con la meticolosa pedanteria di un cronista, ad una storia aberrante come fosse ancora un presente.
Michele Ranchetti
[Da LTI - la lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo. Prefazione.]
Giuntina ripubblica in questi giorni il testo di Klemperer