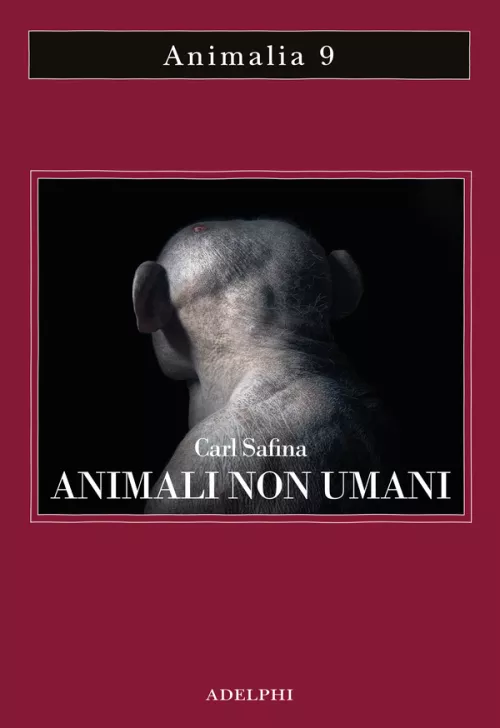Animali non umani
Dopo aver letto Animali non umani di Carl Safina (edito da Adelphi, nella traduzione di Isabella C. Blum), è inevitabile chiedersi se, sul piano conoscitivo, non si sia all’inizio di qualcosa di straordinariamente importante. Domanda che non impedisce di avanzare il dubbio che forse sia ormai troppo tardi. Il libro del biologo americano (di cui Adelphi ha già pubblicato Al di là delle parole, dedicato agli elefanti), sul lettore non specialista ha l’effetto di un terremoto e di un monito.
Safina, letteralmente, ci accompagna in un’esplorazione (con le sue parole: “È come se noi ci fossimo appena svegliati da un lungo viaggio nello spazio e stessimo dando un’occhiata a un nuovo pianeta interessante”), che ci costringe a ripensare al nostro rapporto con gli animali di cui, fino ad epoche recenti, guidati dall’antropocentrismo (che ha origini storico-culturali individuabili nella svolta agro-pastorale del Neolitico, connessa alla domesticazione), ci siamo occupati con disarmante superficialità, determinandone una disastrosa contrazione numerica.
Con il passo del narratore, con l’atteggiamento di chi per apprendere si pone in cammino – ammettendo deviazioni e incontri inopinati – e, ascoltando e guardando, si espone al rischio di sbagliare, l’autore descrive tre dei mondi possibili che stanno accanto al nostro, quello dei capodogli, delle are e degli scimpanzè. Il suo atteggiamento è chiaro: egli cerca di capire in che cosa consista essere capodoglio, ara o scimpanzè. Quali siano gli orizzonti delle loro vite. Soprattutto quale sia la loro cultura, determinata dall’apprendimento e non dall’innatismo.
All’opposto Safina non vuole cadere nell’errore di avvicinarsi agli animali non umani cercando di misurare la distanza che li separa da noi. Loro non stanno prima di noi, in un ipotetico stadio evolutivo che ci precede, ma sono nostri contemporanei. Certamente non sono pochi i libri pubblicati negli ultimi anni che si muovono nella stessa direzione, ma se ne incontrano rari che siano riusciti ad addentrarsi così oltre la linea profonda che ci spinge, nonostante tutto, a considerarci estranei al mondo animale. Safina evidenzia – dopo aver vissuto insieme a chi, sul campo, cerca di capire le altre forme viventi – che ci sono tante e complesse modalità di stare al mondo.
E lo fa affiancando il racconto di ogni incontro alla riflessione su quanto caratterizza la specie analizzata: il senso della famiglia per i capodogli, quello della bellezza per le are e la scelta della pace per gli scimpanzè. Temi che sono sempre stati ritenuti esclusivi dei sapiens e che invece riguardano anche gli “altri animali”. Che, anzi – e questo è snodo decisivo – hanno caratterizzato le loro vite prima delle nostre. In tal senso, la perdita della biodiversità acquisisce un risvolto culturale: l’estinzione di una specie – capodogli, are e scimpanzè hanno subito un tragico tracollo numerico negli ultimi due secoli – è la fine di un patrimonio di conoscenze, non soltanto di una forma vivente senza altro spessore.
Di fatto quindi, quello su cui si muove Safina è un ossimoro. Per avvicinare gli animali non umani dobbiamo allontanarli. Slegandoli da noi, li riposizioniamo come “esseri interessati alla propria vita e che sanno qualcosa su chi sono, dove si trovano, con chi sono e che cosa stanno facendo”. Gli animali possiedono consapevolezza. E questa è l’esito dello sviluppo della mente, attraverso imitazione e insegnamento, in un contesto sociale. Quanto di più sbagliato è stata allora la pratica di allontanare un esemplare dal gruppo (o di farlo nascere in cattività) per studiarlo in laboratorio, inducendo a pensare che “tutto il comportamento, con l’eccezione di quello umano, fosse istintivo, senza nulla di appreso”.
Così si sono radicati pregiudizi, commessi errori imperdonabili, eretti muri di incomprensione. E non abbiamo intuito nulla dei nostri vicini di casa. Gli animali sono rimasti proiezioni del nostro pensiero, generalmente percepiti come meno intelligenti di noi. Capaci al massimo di forme di sensibilità depotenziate, o, tout court, macchine e strumenti di lavoro o, ancora, depositi di materie prime (si pensi all’olio di balena). Per capirli, invece, bisogna rimetterli là dove devono stare: nel loro mondo, a fianco dei compagni di specie. Immergerli nella loro socialità, da cui non possono prescindere. Vederli mentre diventano individui, apprendendo e acquisendo una personalità.
L’ambiente del capodoglio è la famiglia, a base matriarcale. Sono le femmine a guidarla. Sono loro ad allattare i figli anche per cinque anni e poi a lasciar andare i maschi quando ne hanno quindici. Sono loro a curare i figli delle altre femmine quando queste sono a caccia nella profondità del mare. I maschi sono più defilati, senza un vero senso della paternità. Ma la famiglia, che mantiene un contatto permanente tra i suoi membri, non è un nucleo isolato, perché fa parte di clan più larghi, paragonabili a una nazione delle balene.
E dentro a ogni clan si sviluppano abitudini che li differenziano tra loro. Abitudini fatte di pratiche di caccia diverse e di linguaggi diversi (i cosiddetti coda, i dialetti). Così i capodogli riconoscono gli estranei se appartenenti al loro clan. Sanno chi è con loro e chi è lontano da loro. I capodogli quindi non sono, a differenza di quanto saremmo portati a pensare, tutti uguali. Ciascuno possiede uno “spiccato senso del sé” e un patrimonio di tradizioni. Proprio dentro alla famiglia avviene l’altro evento decisivo della loro vita, l’apprendimento.
 I capodogli imparano tutto dalle madri: le tecniche per procurarsi il cibo, i luoghi dove risiedere e quelli dove partorire. La stessa cosa si verifica per le are, che sono pappagalli con la pelle nuda sulla faccia e coloratissimi. Anche se lasciano il nido a tre mesi, i giovani “devono imparare come essere delle are”. Dai genitori, che si dedicano a loro a tempo pieno, apprendono come nutrirsi, a parlare il dialetto dei grandi gruppi in cui vivono, le rotte migratorie. Senza avere il riferimento costituito dai più anziani, “le prospettive di sopravvivenza” sarebbero “minacciate molto seriamente”.
I capodogli imparano tutto dalle madri: le tecniche per procurarsi il cibo, i luoghi dove risiedere e quelli dove partorire. La stessa cosa si verifica per le are, che sono pappagalli con la pelle nuda sulla faccia e coloratissimi. Anche se lasciano il nido a tre mesi, i giovani “devono imparare come essere delle are”. Dai genitori, che si dedicano a loro a tempo pieno, apprendono come nutrirsi, a parlare il dialetto dei grandi gruppi in cui vivono, le rotte migratorie. Senza avere il riferimento costituito dai più anziani, “le prospettive di sopravvivenza” sarebbero “minacciate molto seriamente”.
Fatta eccezione per il controllo del nido, la loro vita sociale è intensa e rilassata. Le are non competono per il cibo e hanno molto tempo libero a disposizione. Sembra che non abbiano mai fretta. Mentre si nutrono di argilla, si ha la sensazione che si comportino come degli esseri umani in un pub: sono lì per mangiare certamente, ma soprattutto per incontrare amici e amiche. Con le femmine fanno qualcosa di molto umano (o noi facciamo qualcosa che hanno fatto loro prima di noi), ovvero le corteggiano improvvisando, senza un rituale prestabilito.
Gli scimpanzè invece vivono in gruppi fluidi e con poche regole: madri e figli piccoli inseparabili, obbligo di appartenenza a un gruppo, importanza del rango tra i maschi. Anche tra loro è la madre ad insegnare tutto ai figli, ma sono le femmine adolescenti a trasferirsi nelle comunità vicine. La vita sociale degli scimpanzè è caratterizzata dalla forte conflittualità tra maschi, il cui pensiero fisso è la gerarchia. I maschi fanno continuamente politica, costruendo relazioni che sono di vitale importanza per loro e per la comunità. Il grooming, la rimozione dei parassiti, è l’azione che serve a ”promuovere fiducia e alleanze”. Il risultato è che tra di loro i maschi adulti sono “stretti sostenitori”, oppure “cospiratori superficiali”.
La comunità è diretta dal maschio alfa, che, quando è al potere, è il padre della maggioranza dei nuovi nati. Nello scimpanzè la gravidanza dura otto mesi. Il parto avviene ogni cinque anni. Le femmine non vanno in menopausa e possono avere figli fino alla quinta e sesta decade di vita. Per i neonati, soprattutto maschi, la vita non è semplice, come dimostra l’alta frequenza di infanticidi che spinge le femmine a sparire col piccolo nei primi tempi dopo la nascita. Del resto è caratteristico delle menti complesse diventare irrazionali. Così i maschi talvolta uccidono le femmine con cui pretendono di avere una relazione (la violenza all’interno del proprio gruppo è una triste esclusiva di scimpanzè e uomini). Ma, anche se può a prima vista apparire soffocante, la struttura sociale gerarchizzata degli scimpanzè aiuta però a tenere il controllo della situazione. A reggerla è il senso di giustizia. “Riconciliazione, perdono: questa è la via per allontanarsi dal baratro. È questo che assicura l’equilibrio, che crea la pace quando è necessaria e la mantiene quando è in pericolo”.
Restituire gli animali non umani alla loro dimensione sociale consente di misurare gli effetti profondi dell’appartenenza a un gruppo (e non solo alla specie) e dell’apprendimento che vi viene impartito. La cultura, l’acquisizione di tecniche, il progresso emotivo determinano una differenziazione tra gli individui. Anche se l’idea prevalente è che la speciazione, ovvero la formazione di nuove specie, dipenda dall’isolamento geografico, secondo Safina l’apprendimento recita un ruolo di primo piano. Imparare vuol dire “attingere alle capacità e alla saggezza collettive lentamente accumulate nel corso dei secoli”, ma anche far ricorso a qualcosa di assolutamente nuovo.
L’innovazione – la spugna di muschio intrisa d’acqua che alcuni scimpanzè costruiscono per combattere la sete dal 2011, l’abitudine di certi capodogli di catturare i pesci presi all’amo – dà luogo alla specializzazione. Perché una novità si radichi è però necessario il riscontro sociale. In altre parole, ci si appropria di una novità, magari superando l’abituale conservatorismo, se questa è sentita necessaria dalla comunità d’appartenenza. Lo dimostrano proprio gli scimpanzè. Tra i tre e i cinque anni gli scimpanzè dell’Africa occidentale osservano la madre frantumare frutti a gusci con una pietra, a dieci anni lo fanno da soli. Gli scimpanzè dell’Africa orientale non usano strumenti per rompere i gusci, ma, se serve, dimostrano di saperlo fare.
Se l’innovazione si diffonde, il risultato è la possibile separazione di gruppi con la conseguente formazione di specie diverse, visto che i cambiamenti culturali sono molto più rapidi di quanto possa fare la mutazione del DNA. Né bisogna dimenticare che la diversità culturale, sul piano evolutivo, rende più probabile la sopravvivenza. Si tratta di una funzione che possiede anche la bellezza. Il canto degli uccelli, il piumaggio multicolore delle are sono qualcosa di straordinariamente bello, che noi percepiamo come probabilmente lo percepiscono gli animali stessi, pur in presenza di apparati sensoriali diversi.
La bellezza, lo aveva spiegato già Darwin, ha a che fare con la selezione sessuale: sono le femmine che, scegliendo, hanno sviluppato la bellezza dei maschi. Ma c’è dell’altro. La convinzione di Safina è che “la vita ha sviluppato il senso del bello per farci sentire bene nel mondo”. La bellezza è dunque “la gratificazione che il nostro cervello ci dispensa per lo sforzo di stare al mondo". Che cosa ha dato impulso alla percezione del bello? Deve esserci un qualche valore in termini di sopravvivenza, ovvero un vantaggio nel compiere la scelta giusta e un costo associato a quella sbagliata.
Gli ormoni e i neurotrasmettitori necessari per percepire la bellezza esistono negli animali da settecento milioni di anni. Percepire il buon sapore del cibo è un sentimento estetico. Percepire il cattivo sapore del cibo serve ad evitare avvelenamenti. La capacità di godere di ciò che aiuta a sopravvivere ha dato impulso alla capacità di preferire tra gustoso e disgustoso. Una volta istituita, la capacità estetica è stata applicata a qualsiasi cosa.