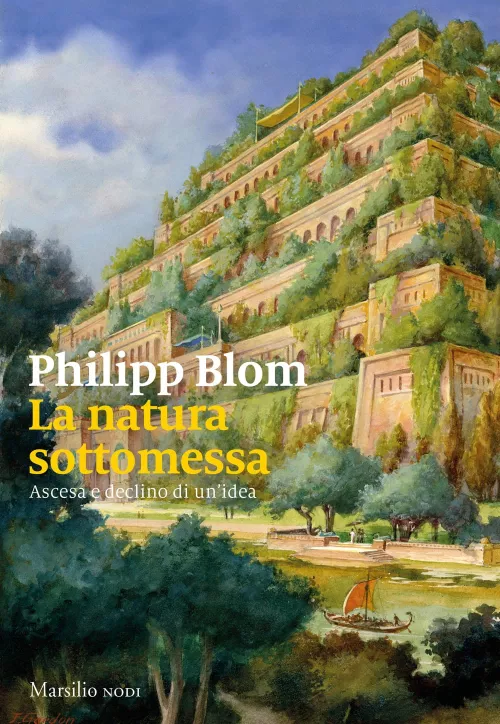Animismo 2.0
All’inizio, come sempre, c’è il sud. All’inizio, come scriveva il filosofo calabrese Bernardino Telesio nel De Rerum Natura Iuxta Propria Principia (1565), c’è una natura che “permane tutta unica e identica, non respinge né odia alcuna natura agente, ma è egualmente propria di tutte e comune a tutte, e di buon grado con tutte ugualmente si unisce e a tutte conviene, e tutte riceve e conserva, divenendo per così dire la loro dimora e la loro sede”. Una natura unica, appunto, che include noialtri umani, così come le piante, le pietre, gli altri animali e tutto il resto. Una natura senza gerarchie, senza padroni né schiavi. Quindi prima c’è il sud, cioè il sole e la terra, cioè la natura da cui, prosegue Telesio, “pur essendo unica e identica, sono costituiti diversissimi enti poiché è disposta e informata da tutte quelle diversissime nature” (La natura secondo i suoi principi, a cura di Roberto Bondì, p. 19).
Tuttavia non è questa idea di natura, così antica ma oggigiorno di nuovo attuale e urgente, quella che guida le nostre azioni e i nostri pensieri. L’unica natura che conosciamo, o che appunto crediamo di conoscere, è quella dell’economia, della tecnologia e della scienza, e quindi la natura sottomessa, come appunto la chiama Philipp Blom nella Natura sottomessa. Ascesa e declino di un’idea (Marsilio). In effetti la figura di Telesio compare nel libro dalla parte dei perdenti, ché la modernità occidentale, quella stessa modernità che è velocemente diventata mondiale, vede nella natura soltanto un oggetto inerte e passivo (un immenso deposito di commodities), cioè una risorsa a disposizione dei progetti umani:
L’assoggettamento della superficie terrestre e la conquista sempre più capillare della stratosfera sono espressione di un unico delirio collettivo, l’idea ormai onnipresente per cui l’uomo (e non a caso dico ‘uomo’, al maschile) sarebbe un che di superiore alla natura, non un aspetto della natura stessa, e quindi avrebbe il diritto, anzi il dovere di soggiogarla. L’uomo così inteso si percepisce come un essere sovraordinato agli animali e alle altre creature viventi, vede la natura come un palcoscenico delle proprie ambizioni, come una riserva di materie prime. E da quella posizione di presunto privilegio parte alla conquista del pianeta intero, per sottometterlo in modo inesorabile alla sua volontà. Un’ambizione che ha qualcosa di faustiano, di folle. Al tempo stesso, la febbre del dominio è talmente diffusa e radicata che risulta difficile chiamarsi fuori, osservare il fenomeno a debita distanza (pp. 16-17).
In realtà, nonostante l’innegabile consapevolezza ecologica del nostro tempo, questa stessa consapevolezza non arriva al punto di mettere in questione l’assunto di base di questa immensa operazione di “assoggettamento”; anche per l’ecologista, in fondo, la natura è in attesa delle nostre scelte. La natura, cioè, non smette mai di essere un oggetto a disposizione del soggetto umano. E così anche l’impegno ecologico, in fondo, non smette d’essere un gesto paternalistico, il gesto di chi è così accorto da preoccuparsi di preservare quella stessa natura che tuttavia non smette un momento di pensare come qualcosa a propria disposizione. Un qualcosa che non possiamo più sfruttare impunemente, qualcosa quindi da proteggere e preservare. Ma appunto, siamo così sicuri della nostra posizione di unici soggetti sul pianeta terra che possiamo permetterci di essere anche ‘padroni’ attenti, comprensivi, disposti addirittura a non esagerare nella nostra pretesa di sfruttare la natura.
Questa posizione eccezionale dell’umano è inscritta nei testi fondamentali della nostra tradizione culturale. Si pensi al terribile compito che, nella Genesi, viene assegnato all’umanità: “Yahweh […] dopo aver creato Adamo ed Eva, assegna loro una missione: Dio li benedisse e Dio disse loro: ‘siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra’” p. 78). Come osserva Blom, “la formula ebraica messa in bocca al Creatore è (wekibšuha), alla lettera ‘e voi dovrete sottometterla’. Nel manuale di ebraico biblico dell’orientalista tedesco Wilhelm Gesenius il verbo (kabaš), che nel testo figura alla forma imperativa, è definito come ‘schiacciare, sforzare’, con esempi come ‘calpestare sotto i piedi, ridurre in schiavitù, soggiogare’” (p. 79). La stessa spietata determinazione all’assoggettamento si ritrova nella Vulgata: “Crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam, dove il verbo subicite viene reso di norma con ‘soggiogatela’, un termine che designa la sottomissione o l’asservimento di un avversario o di un animale, cioè di una volontà antagonista ma subordinata” (pp. 79-80).
A questo punto non solo la natura è del tutto a disposizione dell’umano, ma questa sottomissione è necessaria perché giusta, perché proprio così vuole il Signore. È difficile sottostimare la duratura efficacia di questo monito all’assoggettamento. Da questo momento in poi ci sarà un solo attore sulla scena planetaria, l’essere umano che, per volontà divina, ha tutto a sua disposizione. Ma questo significa che la natura, diversamente da come pensava Telesio (e, come congettura Blom, il “dio danzante” delle religioni perdute nelle antichità del paleolitico dove “non esisteva l’idea di una supremazia dell’essere umano sulla natura”, p. 68), non è dotata di una sua intrinseca potenza; la natura diventa ora, e per sempre, l’oggetto passivo che non può che subire – nel male della rapacità dello sfruttamento incontrollato come nel bene delle cure biofile dell’ecologista – le sovrane decisioni umane: “il concetto biblico del dominio era l’equivalente mitologico di una bomba nucleare.
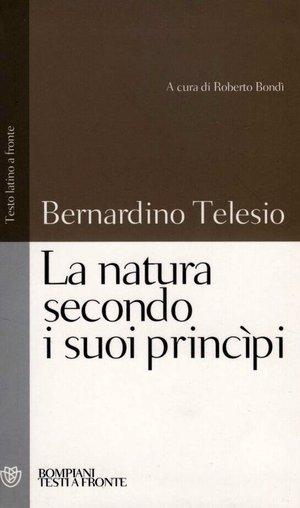
Il mondo naturale non veniva più descritto come una realtà animata, popolata di attori eterogenei con i quali l’uomo doveva patteggiare: la Bibbia conosce un unico Dio, contrapposto a una terra senza vita, a una distesa di polvere, senz’anima, priva di volontà propria, in attesa di essere soggiogata, arata, posseduta, penetrata e fecondata, comprata e venduta. Questo brusco cambio di prospettiva sanciva una clamorosa autoinvestitura: non più schiavo degli dèi, l’uomo stesso diventava signore del mondo” (p. 82).
Lo sfruttamento del mondo, che già si sta estendendo agli altri pianeti del sistema solare, per Blom non fa che sviluppare fino in fondo queste premesse religiose; in questo senso le pretese dell’economia di governare tutto il mondo sarebbero incomprensibili senza questa origine teologica, una teologia demoniaca ma pur sempre teologia. Così, come scrive Blom, “la dottrina della scuola di Chicago, la scienza economica di stampo liberista che nella seconda metà del xx secolo si afferma come il paradigma dominante, specialmente nei paesi occidentali, muoveva dal presupposto che l’agire economico fosse in larga misura indipendente dai sistemi naturali” (p. 267).
A questo devastante dispositivo teologico-economico Blom contrappone, ma senza alcuna illusione che possa ormai scalzarlo, il modo di vedere il mondo che gli antropologi ottocenteschi chiamavano, per disprezzarlo, animismo. Rispetto alla visione dell’unica natura sottomessa per l’animismo esiste una molteplicità di nature, ognuna dotata di una intrinseca potenza di agire e generare: “nessuna delle culture arcaiche […] partiva dal presupposto che il mondo materiale fosse un sostrato inerte, materia passiva, che gli esseri umani fossero l’unica forma di vita superiore, e che perciò potessero agire a loro piacimento, senza consultare le potenze spirituali, senza ingraziarsele con favori, senza sentirsi coinvolti dalla vita visibile e invisibile che li circondava” (p. 82). Con la fine dell’animismo la natura smette di essere naturale, cioè viva e generatrice. È del tutto evidente, ormai, che solo se la natura torna ad essere vivente, e quindi rifiuta di essere il più o meno docile oggetto delle decisioni umane, ci sarà salvezza per la nostra specie (non per la vita sulla terra, che può fare benissimo a meno della nostra presenza). Serve allora un nuovo animismo. Serve, come scrive Blom nelle pagine conclusive del suo libro, una nuova (e per questo antichissima) capacità di stare nel mondo come parte del mondo:
La catastrofe climatica trasforma la percezione del mondo naturale e del rapporto che l’essere umano intrattiene con quel mondo. Come già la pandemia, è un richiamo sgradevole ma perentorio: la lingua dell’Occidente e dei suoi seguaci e imitatori non è più adatta a descrivere la realtà. È un problema che interessa la radice ultima del linguaggio, perché nega la stessa visione del mondo che gli serve da fondamento. In termini concreti: le parole che danno forma al nostro pensiero, i concetti che attendono di essere riempiti con esperienze, sono ancora invischiati a implicazioni teologiche, con tutte le zavorre intellettuali che ne conseguono.
Ogni volta che distinguiamo tra cultura e natura, politiche e riscaldamento globale, economia ed ecologia; ogni volta che ci figuriamo l’«uomo» come sovraordinato alla «terra» e la storia come votata a un traguardo paradisiaco (oppure a un inferno apocalittico); ogni volta che una grande narrazione annidata da qualche parte serve da fondamento e garanzia generale; ogni volta che l’essere umano viene pensato come diverso dagli altri animali, che la virtù sembra coincidere magicamente con il proprio tornaconto e i privilegi appaiono moralmente giustificabili; ogni volta che si pensa e argomenta in questo modo è all’opera un pensiero di matrice teologica. Non perché ci sia di mezzo un discorso religioso o confessionale, ma perché concetti del genere contribuiscono al mantenimento dello statu quo (pp. 320-321).
Liberarci allora dell’economia, che non ha preso il posto della religione, come sostengono gli sprovveduti, perché l’economia è la forma attuale di quell’antico imperativo religioso che assegna agli umani il compito di sottomettere la natura. Il nuovo animismo dev’essere allora finalmente ateo: “l’umanità del xxi secolo si trova espulsa dalla sua patria concettuale (la narrazione incentrata sul soggiogamento della natura) come un tempo Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. […] Questa non è una parabola edificante. Non c’è di mezzo alcun Dio. […]. La nuova cacciata dal paradiso, senza angeli guardiani e senza redenzione, è un’esperienza dolorosa, perché insegna […] che l’essere umano ha un bisogno disperato di angeli e redentori. Nella nuova natura che si profila saremo abbandonati a noi stessi, perché ci mancano i concetti per descriverla, perché non abbiamo ancora capito che la cacciata è anche una liberazione. Ma la vogliamo davvero, questa liberazione?” (p. 323).