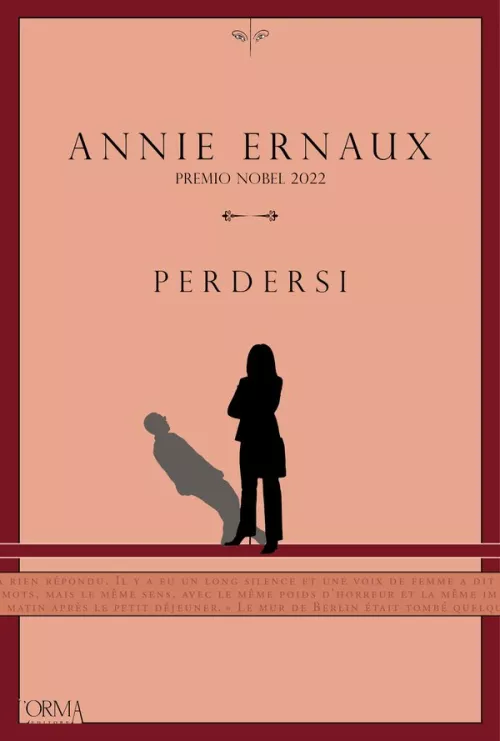Annie Ernaux: il lutto della bellezza
Appena chiudo il libro cerco su internet una foto di Annie Ernaux nel 1988, voglio vedere se era bella. Ce n’è una scattata in casa sua da Louis Monier. Sta in ginocchio davanti alla libreria, le mani poggiate sulle gambe, come si fosse chinata a cercare un libro nello scaffale in basso e il fotografo le avesse detto aspetta, ecco, ferma così. Lo sguardo è intenso, la posa remissiva. Attende il permesso di rialzarsi. Sì, è una bella donna. A vent’anni era bellissima e questa foto conserva l’impronta di come era stata. La pelle è ancora giovane, ma il viso sta scivolando verso forme spigolose, nell’età in cui lottiamo davanti allo specchio – zigomi, guance, angoli della bocca – contro l’evidenza di assomigliare sempre più a nostra madre.

Trovo anche una sua intervista dello stesso anno (qui) per l’uscita del libro Une femme. Poco trucco, voce docile e postura fin troppo modesta. Al minuto 5:08 la giornalista le chiede: “Bon… vous avez des fils. Est-ce que vous souhaiteriez qu’ils vous voient plus comme une mére ou plus comme une femme?”. Ernaux sorride, non ha dubbi: “Ah! Comme una femme.” Clic. Ora mi è chiaro.
Perdersi, di Annie Ernaux – tradotto in italiano da Lorenzo Flabbi per L’Orma nel 2023 e già uscito in Francia nel 2001 per Gallimard col titolo Se perdre – è un libro pericoloso: apre la porta di uno sgabuzzino nero. Si tratta di un diario scritto tra il settembre del 1988 e l’aprile del 1990, in cui l’autrice registra la passione ossessiva per S., un diplomatico sovietico di base a Parigi, attraente, sposato, tredici anni più giovane di lei. La chimica dei corpi: i due si conoscono in un’occasione ufficiale, passano una notte insieme senza la pretesa di rivedersi e invece iniziano una relazione a intermittenza, divorante, più profonda a ogni incontro e più disperata a ogni distacco. L’amante non chiama per giorni, talvolta settimane, si fa vivo quando può e quando ha voglia, giusto prima che lei sia vinta dalla stanchezza dell’attesa. E allora tutto ricomincia, si spera e si piange, e ancora si cade in basso, annullandosi fino al ridicolo: mollare tutto e correre da lui, accettare condizioni modi e tempi dettati dall’altro, dire di sì e amarlo in ogni modo possibile sapendo che di nuovo all’estasi erotica seguirà il vuoto e un’attesa sfibrante. In questo logorio emotivo – riempirsi e svuotarsi, volare e strisciare – la scrittrice si scopre dipendente dalla dialettica tra godimento e dolore. Non lo prevedeva, è accaduto.
Gran parte della narrativa di Annie Ernaux (Il posto, Gli anni, Memoria di ragazza sono solo alcuni esempi) utilizza le categorie della sociologia nel racconto autobiografico, condotto sia in terza che in prima persona. L’esperienza personale è messa in contesto e i ricordi sono spiragli per interpretare le grandi forze sovrastrutturali a cui siamo sottoposti come gruppo, classe, collettività. Una scrittura di ricerca, insomma, con l’ambizione di recuperare la propria realtà dell’epoca vincendo l’effetto distorsivo del tempo.
I diari Journal du dehors (1993) e La vie extérieure (1993-2000) sono definiti dalla stessa autrice journal extime, a indicare, attraverso il prefisso ex-, che si tratta di un diario rivolto verso l’esterno, di un Io transindividuale che non è un’identità psicologica ma un luogo storico. Perdersi si sottrae a questa impostazione, presentandosi invece come un vero e proprio diario intimo (journal intime) in cui la prospettiva è tutta interna, anche in senso fisico: stanze, camere d’hotel, sale da ricevimento, il monolocale del figlio di lei. Tutto si svolge nell’ambientazione claustrofobica della clandestinità, mentre “il mondo esterno è pressoché assente da queste pagine”; figli, lavoro e politica sono solo menzionati di sfuggita.
“Nel trascrivere il testo originale al computer non ho cambiato né tagliato nulla. Le parole che si sono depositate su carta per catturare pensieri, sensazioni in un determinato momento sono per me irreversibili come il tempo stesso”, si legge nell’introduzione. Dichiarazione significativa non tanto riguardo al rapporto tra verità e letteratura (“Dio sa o no se c’è una Dulcinea al mondo, e se è immaginaria o non immaginaria. Queste non sono cose la cui indagine può spiegarsi fino in fondo”, Miguel de Cervantes, Don Chisciotte de la Mancia), quanto alla volontà dell’autrice di evitare censure e ritocchi. L’impressione, in effetti, è di un testo autentico, ricco di slanci, grezzo e un poco trasandato proprio perché in presa diretta. Al più, si percepisce una certa vigilanza nella scelta delle parole, riconducibile però al carattere performativo della scrittura diaristica.
Ne risulta un resoconto onesto, dunque osceno, di un desiderio invincibile, il corpo per il corpo, l’amour fou. Annotazioni dettagliate – orari, indirizzi, gesti, sigarette, calzini – perché nulla vada perso. Un racconto reso efficace dalla mancanza totale di lirismo: solo la concretezza dell’anatomia e del sesso, le parole della realtà e la scrittura “alla Ernaux”, semplice nel senso che danno i tedeschi al termine einfach, cioè senza ornamenti, doppioni, creme e salse aggiunte. La ripetitività delle impressioni riproduce l’ossessione e crea l’effetto disturbante. Verrebbe da scuoterla, non vedi che ti chiama solo per scopare? Ma non possiamo che assistere mentre si autodistrugge.
D’altra parte, la jouissance trascina con sé il suo opposto. Quando scrive “tornando a casa ieri sera, in autostrada, voglia di incidente, di morte”, Ernaux confessa una verità difficile, così come Sant’Agostino dopo il furto delle pere: “Era laida e l'amai, amai la morte, amai il mio annientamento. Non l'oggetto per cui mi annientavo, ma il mio annientamento in sé stesso io amai, anima turpe, che si scardinava dal tuo sostegno per sterminarsi”.
Davvero un libro coraggioso. Mostra i meccanismi di una relazione disfunzionale senza intento istruttivo o impostazione moraleggiante. Non consiglia, né rassicura, non avverte le altre donne sui pericoli della dipendenza emotiva. Eppure fa molto: racconta una delle possibili verità e ci pone di fronte al fantasma, il suo, quindi il nostro. Davanti allo specchio l’autrice è femmina, non femminista. D’altra parte, già nel 2003 in L’écriture comme un couteau, dichiara: “non mi piace comparire nella categoria di “scrittura femminile”. Nella letteratura non c’è una suddivisione dal titolo “scrittura maschile”, vale a dire legata al sesso biologico o al genere maschile. Parlare di scrittura femminile, di fatto, significa de facto fare una differenza sessuale – e soltanto per le donne – una determinante sia per la produzione che per la ricezione: una letteratura delle donne per le donne.”
Ernaux è una scrittrice lucidissima, un’intellettuale, può contare su un vissuto e sulla propria indipendenza economica. Sa bene quanto il legame con S. sia senza parole, squilibrato e destinato al fallimento. Riconosce i difetti dell’amante, lo definisce un parvenu, attirato dalle auto, ammiratore di Stalin, superficiale e perfino un po’ villano; una natura media, un Vronskij dalla calvizie incipiente.
Vede la letterarietà della situazione, non a caso, il 24 febbraio ’88 comincia a rileggere Anna Karenina; il 16 novembre ’89, all’indomani della partenza definitiva di S. per Mosca, annota: “Vivere Anna Karenina è stata la cosa più stupida che potessi fare”.
Nonostante tutto, “io lo amo con tutto il mio vuoto”, perché? Le ragioni sono più d’una. Per Ernaux desiderio, vita e scrittura sono grandezze a somma costante: se amo da scrittrice pensando “mi servirà poi”, pongo una distanza tra me e il vivere a pieno. Se amo nell’istante-adesso, carne e sangue, non ho la forza di scrivere, concentrarmi, lavorare – cioè muoio. Il congegno perverso la tiene al gancio. La donna-artista cerca la verità del corpo, accetta di stare dentro allo struggimento, macerata dalla gelosia, faccia bollente e pianto in fronte, per sentire il potenziale della scrittura, la tensione creativa a produrre un libro che faccia comprendere.
“Vivo in modo diverso per il fatto che scrivo? Sì, credo di sì, anche nel momento del dolore più profondo.” La scrittura è un’attesa desiderante e poi la perdita di ogni prudenza.
Lo svolgimento del diario si addensa attorno alla passione, un piccolo mondo circoscritto, un piétiner sur place. Ogni cosa è ridicola, se paragonata alla morte, afferma Thomas Bernard; anche di fronte al godimento. Lezioni, ricevimenti, incombenze, uscite sono vissuti come insopportabili inutilità, la giornata ordinaria fa orrore. Di S. sappiamo poco, né riusciamo a farci un’idea di cosa provi davvero per lei. Il vero personaggio è l’assenza di S., o, in altri termini, l’idea. E se è noto da sue dichiarazioni come il diario non sia per Annie Ernaux una forma di auto-terapia, tuttavia in questo libro la vediamo indagare il proprio fantasma. Trascrive e analizza i sogni notturni, così come rievoca antichi traumi e riflette sulle passate relazioni nelle quali già intravede una forma di dépense, di dispendio gratuito: “Cambiare così poco. Attendere: a sedici anni (a gennaio, a febbraio, un segno da G. de V.), a diciotto (il peggiore, C.G.), a ventitré, Ph., a Roma.”
Capire il desiderio, sentirlo arrivare sentendo una parola in russo, cercarne gli indizi nel rumore di passi, alimentarlo, descriverlo. “L’unica cosa di cui sono sicura è il suo desiderio di me”; “Io però a questo punto so che ha il mio stesso desiderio”; “mi siedo al suo fianco e non faccio altro che pensare al mio desiderio per lui”; “ma dopo, dov’era il mio desiderio?”; “che fare di tutto questo desiderio?”. Ma ripetendo tante volte di seguito una parola, ecco, essa perde significato e rimane l’impressione che la vita ecceda la possibilità di restituirla sulla pagina, trasgredisca il piano della comunicazione.
In questo libro Annie Ernaux si prende il rischio di un minor consenso rispetto ad altri lavori, e si autorizza a far emergere cose che non si possono dire. Una in particolare, scandalosa: la bellezza è un privilegio crudele e la prospettiva di perderla terribile. A 48 anni una donna si guarda “con disgusto la pelle dell’interno delle braccia, che sta diventando flaccida, avvizzisce”. Avverte su di sé l’infittirsi del tempo, e così la tensione per tenere l’amante a sé è anche lo sforzo di trattenere la bellezza, ovvero la piena realtà del corpo. In altre parole, la battaglia per non perdersi.
Se il desiderio è sempre desiderio del desiderio dell’altro, io dipendo dal suo sguardo, voglio questo sguardo e voglio che lui mi guardi – mi ami – liberamente. E allora l’abluzione e il farsi bella, “il tailleur nero che mi fa un figurino da modella, il pizzo nero, le calze di seta scure, la borsa Charles Jourdan” rappresentano un rituale che ha in sé una disperazione. Ogni nuovo incontro con S. dà il sollievo della conferma: il desiderio persiste e anche la gioia del potere seduttivo. Non solo vanità, ma qualcosa di più profondo rispetto al femminile (all’umano): la bellezza è una vertigine. Non tanto essere l’unica; conta piuttosto essere la preferita: “Venerdì, venerdì… Il pensiero tremendo delle presentazioni con sua moglie. Essere io la più bella, la più scintillante, disperatamente”. In questa prospettiva, Perdersi è quindi la cronaca di un lutto, quello per la propria bellezza e il distacco da S., di un lento disamoramento e, infine, di una nuova accettazione di sé.
Le cose vanno come devono andare. Ventitré anni più tardi, nel 2001, Annie Ernaux sarà una donna di sessantun anni, avrà preso distanza e potrà considerare la pubblicazione di un testo che già allora conteneva qualcosa di “crudo e oscuro, senza salvezza”. Duro e onesto. Perdersi è un buon libro perché fa ciò che fanno i buoni libri: morde e punge anziché rassicurare. Una letteratura contro l’impegno, dunque, come scrive Walter Siti nel suo saggio omonimo: “L’arte è un bastian contrario che spira sempre dal lato sbagliato; è ambivalente, dà ragione a chi ha torto e torto a chi ha ragione; per questo è più longeva della politica e della cronaca a cui pure si ispira”.