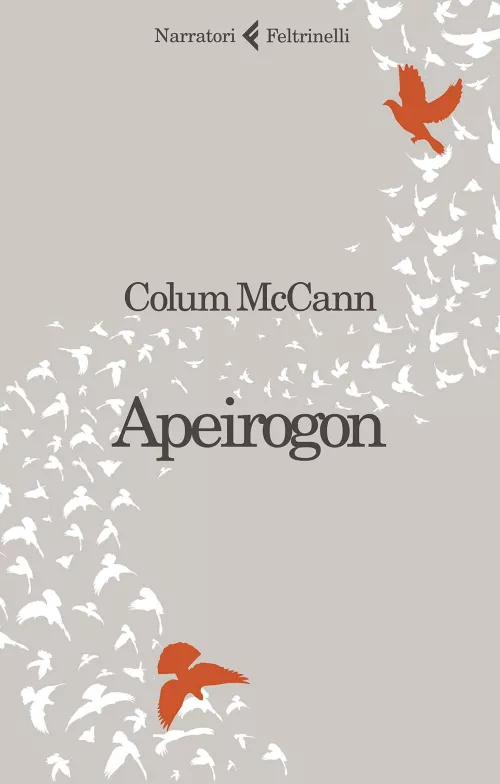Colum McCann / Apeirogon. Il dolore di due padri
Questa è la storia di due padri, uno israeliano e uno palestinese. Hanno visto le loro figlie uccise bambine dalla violenza che strazia quelle terre e invece dell’odio hanno scelto le parole. Insieme raccontano. “Sono Rami Elhanan, il padre di Smadar”. “Sono Bassam Aramim, il padre di Abir”. Da anni, nelle scuole, nei teatri, nelle librerie, per un attimo riconsegnano alla vita quelle ragazzine che mai diventeranno donne. Raccontano, con fatica, con dolore, perché la pace fiorirà solo nel dialogo, nella tolleranza, nella riconciliazione. “Non finirà finché non ci parliamo”.
Questa è una storia vera ed è l’asse attorno a cui ruota, con superba lentezza, il brulicante universo che anima le pagine di Apeirogon, l’ultimo lavoro di Colum McCann, da poco in libreria in italiano (Feltrinelli, 528 pp.). Un libro-mondo che per dire uno dei territori più frequentati dall’immaginario contemporaneo scardina l’impianto tradizionale del romanzo, rimescola i generi e domanda tempo e fiato per compiere un tragitto vertiginoso fatto di schegge e stralci – 1001 secondo la lezione delle Mille e una notte.
L’apeirogon che dà il titolo al libro è un poligono dal numero infinito di lati. E solo l’infinito misura la complessità e le sfaccettature della spirale di violenza che tormenta il Medio Oriente, dove ogni lato ha altre facce e ciascuno la sua. Solo l’infinito contiene la fatica e gli incanti dell’esistenza – la “pura simultaneità di tutte le cose” che, insegna Borges, il linguaggio per sua natura successivo non è in grado cogliere.
Le storie di Smadar e Abir tornano così in spezzoni che si inseguono con il cuore in gola. Le bambine muoiono a dieci anni di distanza. Smadar Elhanan ha 13 anni quando il 4 settembre 1997 tre giovani terroristi si fanno esplodere nel pieno centro di Gerusalemme e la uccidono insieme ad altre quattro persone. Sta andando con le amiche ad acquistare libri per la scuola, ascoltano sul walkman Sinead O’Connor. La violenza dell’esplosione la scaraventa in aria.
“Molli la macchina e stai correndo per le strade, dentro e fuori i negozi, i caffè, le gelaterie, alla ricerca di tua figlia, della tua bambina, della tua Principessa – ma è come svanita. Urli il suo nome. Torni di corsa alla macchina. Guidi come un pazzo. Di ospedale in ospedale, di stazione in stazione di polizia. Ti sporgi dal bancone. Li supplichi, non fai che ripetere il suo nome. [...] E vai avanti così per molte lunghe ore, finché alla fine, a tarda notte, ti ritrovi nell’obitorio insieme a tua moglie”. Così il padre Rami ricorda, in una delle pagine più toccanti, le ore che precedono il ritrovamento.
Abir Aramin ha invece dieci anni quando nel 2007 una guardia di frontiera israeliana diciottenne la colpisce alla testa con una pallottola di gomma dalla feritoia di una jeep. È appena uscita dal negozio dove ha comprato un braccialetto di caramelle, indossa l’uniforme della scuola. La gonna azzurra e la camicetta bianca. L’ambulanza che la trasporta a Gerusalemme, rimane bloccata per ore a un checkpoint lungo il confine. Muore due giorni dopo all’ospedale Hadassah, lo stesso dove anni prima era nata Smadar. “Continuo a sedermi in quell’ambulanza, ogni giorno. In attesa che si muova. Ogni giorno lei viene uccisa e ogni giorno io siedo in quell’ambulanza, implorando che si muova, ti prego muoviti, ti prego ti prego ti prego, perché stai ferma”, ricorda Bassam.
Senza Smadar e Abir, i loro padri non si sarebbero mai incontrati. Rami Elhanan è figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, è stato carrista nella Guerra di Kippur, è un grafico e pubblicitario di successo. I suoi poster per anni tappezzano il paese. La moglie Nurit è una filologa, insegna all’Università ebraica di Gerusalemme, è un’attivista; suo padre è il generale Matti Peled, uno dei simboli del movimento israeliano per la pace. Vivono a Rehavia, il quartiere chic della città: vie silenziose, alberi, balconi fioriti.
Smadar è figlia di questo mondo – l’élite di Israele. È una nuotatrice, una ballerina. Da grande vuole fare il medico. “Smadar. Dal Cantico dei Cantici, Il grappolo della vigna. Il fiore che si schiude”.
Bassam Aramim finisce invece in carcere a 17 anni per aver lanciato una granata contro una jeep dell’esercito israeliano. I pestaggi e le umiliazioni non fanno che rendere più bruciante il suo odio, finché un programma in tivù cattura la sua attenzione. Parla della Shoah, che i suoi aguzzini spesso evocano neanche fosse una giustificazione. L’odio fa posto alla pietà. Impara l’ebraico, si avvicina alle teorie della non violenza e una volta libero vola in Inghilterra dove studia l’Olocausto. Al ritorno si stabilisce con la moglie Salwa e i figli ad Anata, accanto al campo profughi di Shufat. Un microcosmo di polvere, traffico, chiasso, pattuglie.
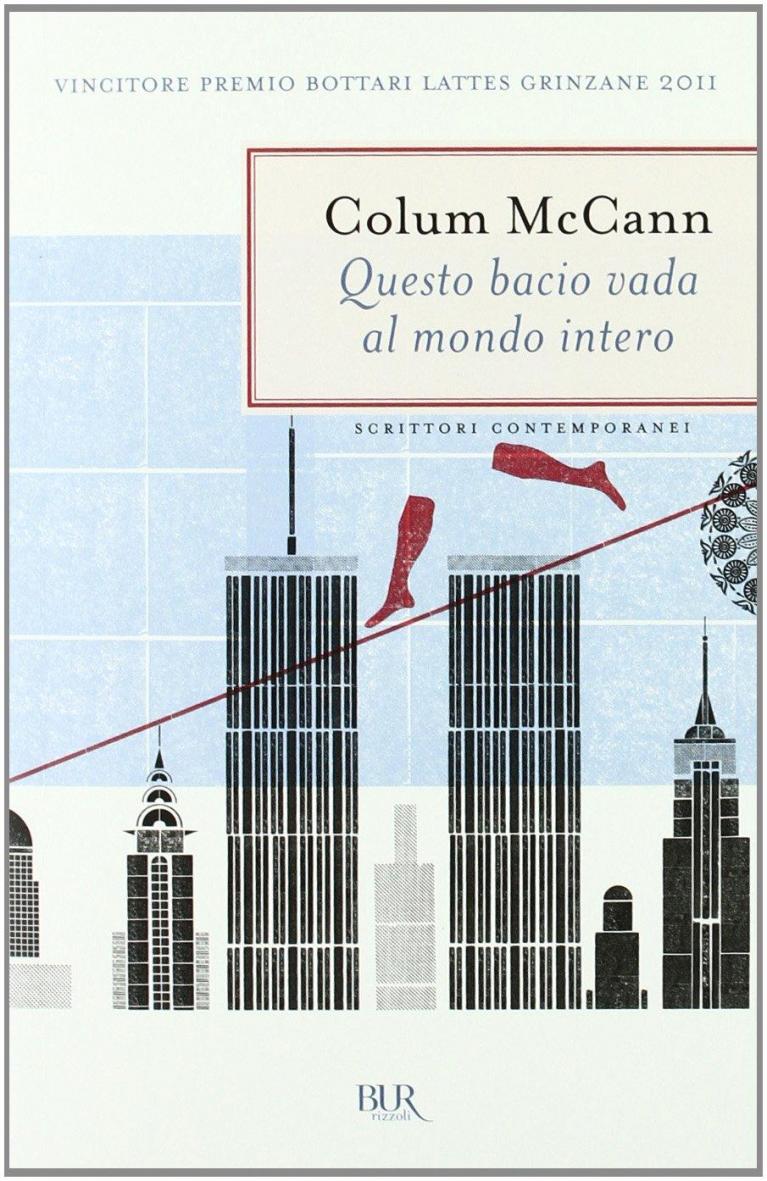
Abir è figlia di questo mondo – da mezzo secolo sotto scacco. Le piacciono gli orsi, sogna di vedere il mare. Da grande vuole fare l’ingegnere. “Abir. Dall’arabo antico. Il profumo del fiore”.
La loro morte è uno schianto in cui Rami e Bassam si ritrovano fratelli. Decidono di usare “la potenza del loro dolore come arma” e con l’associazione Parents Circle Family Forum girano il mondo portando la loro storia. “Sono Rami Elhanan, il padre di Smadar”.“Sono Bassam Aramim, il padre di Abir”. Basta guardarli sul palco, mentre finiscono uno la frase dell’altro, per cogliere la potenza del legame che li unisce – la perdita più impensabile, la più indicibile per ogni genitore. Torna alla mente un altro padre, David Grossman, che alla perdita del figlio Uri in Caduto fuori dal tempo (2018) aveva dedicato versi memorabili.
Colum McCann rifrange quel dolore in un caleidoscopio di altre storie. La spettacolare migrazione che ogni anno porta centinaia di milioni di uccelli in quel cielo (“A volte interi stormi nascondono il sole e stendono colori d’ombra da una parte all’altra di Beit Jala: sui campi, sulle ripide gradinate, sui boschetti di ulivi alla periferia della città”). La fionda del re Davide; Jorge Luis Borges che nei primi anni Settanta visita Gerusalemme dove nei quartieri palestinesi lo trattano con la reverenza dovuta ai narratori ciechi (“disse che non aveva mai visto una città dalla luce così ferocemente limpida”). Lo sgancio della bomba nucleare; Einstein e Freud; le ville abbandonate dai palestinesi; il dirigibile candido che si libra sopra la strada che sale a Gerusalemme; il poeta Mahmoud Darwish.
E, ancora una volta, Philippe Petit. Il funambolo che in Questo bacio vada al mondo intero (2009), il romanzo vincitore del National Book Award, camminava su un filo teso tra le Torri Gemelle, torna nella sua performance del 1973 mentre su un altro filo a Gerusalemme attraversa la valle di Hinnom per far volare una simbolica candida colomba (come va a finire è tutto da leggere).
È il catalogo minuzioso e arbitrario di un pezzo di mondo. Come in certi scavi archeologici sotto la Città vecchia di Gerusalemme, lo spessore della storia si rivela uno strato dopo l’altro – civiltà dopo civiltà, trionfi sulle rovine, acqua, fuoco, devozione. E come in certe composizioni digitali, la realtà allinea minuscole istantanee in una sequenza rapidissima che cambia senza tregua.
Apeirogon è il genere di libro che si ama o si detesta. La critica si è divisa fra chi lo considera un libro destinato a cambiare il mondo; chi lo accusa di oscurità, lentezza e sentenziosità; chi nella costruzione per frammenti ravvisa la morte del romanzo e chi, viceversa, il suo futuro. Il New York Times l’ha distrutto in una recensione e in un’altra l’ha incensato. Quanto a me, l’ho letto un anno fa in inglese e da allora non ha smesso di lavorarmi dentro.
In queste pagine si ritrova – distillata alla massima potenza – la capacità di Colum McCann di annodare trame che sfidano ogni legge di gravità narrativa, il suo intreccio di fatti e fiction e la sua costante oscillazione fra prosa, musica, poesia, giornalismo. L’autore ha paragonato questo libro a una sinfonia, in cui ogni strumento ha la sua voce e la sua funzione. Dopo il primo incontro con Rami e Bassam attraverso la sua organizzazione di storytelling Narrative 4, gli ci sono voluti cinque anni per comporla e non si stenta a credergli.
In questo tour de force le dissonanze non mancano. A tratti le digressioni sono eccessive, certe ripetizioni stonano o si vorrebbe saperne di più di certi personaggi – ad esempio delle madri. E poiché di Medio Oriente si sta parlando c’è, e non potrebbe essere altrimenti, il risvolto politico. In uno sferzante intervento, la scrittrice Susan Abulhawa ha definito il libro un esempio di colonialismo, accusandolo di mettere sullo stesso piano occupati e occupanti e denunciando come mistificante “la retorica del dialogo”. Apeirogon viaggia però su una traiettoria diversa. La sua carica dirompente è in un respiro al tempo stesso particolare e universale. “È un libro sulle divisioni e potrebbe essere ambientato ovunque, in Irlanda, in Siria o negli Stati Uniti”, ha detto Colum McCann.
È una prospettiva che poteva arrivare solo da un outsider, così distante da tenere lo sguardo limpido e così vicino da capire: uno scrittore di Dublino trapiantato a New York, un irlandese che nelle logiche sanguinose del conflitto è cresciuto ma in quello mediorientale non ha posta in gioco. Ed è un profondo atto di fede nella letteratura. Se il linguaggio non coglierà mai la “pura simultaneità delle cose”, sembra dirci Apeirogon, l’ineffabile natura dell’illimitato risuona nelle parole e nelle storie.