L’armata Brancaleone su Facebook / Chi è “io”?
Nei giorni in cui divampava il caso Cambridge Analytica io condividevo post sul caso Cambridge Analytica: mi stupiva un po’ l’indignazione di chi temeva di essere stato derubato della propria privacy, della propria identità. Quando devo spiegare ai ragazzini in classe quali siano i rischi della rete dico sempre che non c’è nulla di segreto in ciò che è elettronico, inventato dai militari per spiare; se invii a un fidanzatino un selfie dalla tua cameretta, se gli invii un frammento della tua privacy, quel frammento non sarà più privato; il fidanzatino lo inoltrerà a quello che pensa sia un suo amico, che lo condividerà con due o tre amici ancora meno intimi (i ragazzini stentano ormai ad avere anche un solo amico intimo, e hanno perlopiù branchi di decine di amici digitali), e dopo qualche settimana le tue tettine saranno sbavate da qualche pedofilo; le studentesse a quel punto inorridiscono, e trasecolano nel sentire che l’unica vera intimità è quando si è in due in uno spazio protetto, con i due smartphone in un’altra stanza e un pochino di delicata penombra. Su Facebook e WhatsApp per gli adulti, su Instagram e WhatsApp per gli under 18, non c’è privacy. Qualche sbarramento nelle Regole rimane, ma il nostro stesso stare al balcone della rete per urlare i fatti nostri, i gusti nostri, i temi nostri ci toglie dalla modestia e ci consegna ai rischi della esibizione narcisistica. Gli ultimi algoritmi di Facebook e Google sono micidiali: dopo 5 likes riceviamo già suggerimenti e post a pagamento. Cosa c’è di privato su un balcone? I metri quadri assegnati a noi come immobile non ci permettono di fare l’amore o parlare ad altissima voce dei fatti nostri esposti a tutti.
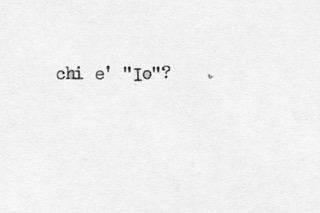
Siamo tutti fuori come un balcone. Certo, dal phishing voglio essere protetto, mi darebbe un grande dispiacere vedere discendere il mio conto corrente piccolino. Ma per il resto, siamo noi che vogliamo far sapere; siamo noi che vogliamo sapere. Navighiamo, ma il mare non è nostrum, è monstrum. Il Re è nudo e noi sudditi che abbiamo reso milionario Zuckerberg siamo nudi.
Quindi non mi sono particolarmente indignato per il traffico di dati che può servire a un partito a inviarmi proposte elettorali per vincere le elezioni. Non voto on line, ma in una cabina che per qualche secondo corrisponde alla cameretta in cui probabilmente resteranno solo a me note le tettine della mia ragazza. Non gliele fotograferò, perché rivederle non avrà senso, per me: io le ho viste e accarezzate. Avrebbe senso per altri. La situazione generale certo fa milionari alcuni e consumatori milioni di altri, ma nel momento in cui trovare contenuti per noi interessanti su Facebook invece che su un giornale o in un negozio è per me utile, mi viene difficile sentirmi derubato della mia identità: do tu des.
Cos’è la mia identità? Chi è “io”? è così importante lavorarci come statue di creta con i nostri narcisistici pollici e poi cuocerci per rimanere infrangibili e autentici? Perché vogliamo far sapere su che panchina sediamo e quale libro stiamo leggendo indignandoci poi se ci arriva una pubblicità di quella casa editrice o del ristorante su cui si affaccia la panchina? Il tema mi pare questo: sia dal punto di vista buddhista, sia dal punto di vista facebookista le nostre identità non sono così importanti, anzi, mi pare necessario che tutto ciò che si determina nel cosmo degli atomi digitali sia da noi percepito come del tutto impermanente e smaterializzato. Chi è “io”?: un aggregato algoritmico, una fiammata di commenti o cuoricini o pollici che dicono che siamo OK per qualcuno per qualche istante. Non è dalla rete che partono opere robuste nel tronco e solide nelle radici. Un libro pubblicato forse è più permanente, ma in ogni caso non sarà così importante l’io di chi l’ha scritto, quanto cosa ha scritto, e se quel cosa sia utile o piacevole per altri.
Siamo tutti cibo per tutti. Tutto è uno spiluccare, un godere sull’abisso e sull’ineluttabile: «Dammiti, prendimi, prendimi e dammiti, cuccurucù!».
Per caso ho visto in quei giorni, come status di non mi ricordo chi: «Sarai mondo se monderai lo monno»; in rete girano genialate simili, così come giravano sui muri prima del web; sui muri o sul web i geni che inventano questi aforismi sono o diventano presto anonimi nella catena delle condivisioni, così come è accaduto per millenni per buona parte delle creazioni dell’uomo: invenzioni senza ufficio brevetti, poemi e pitture senza diritti d’autore. L’ultima che ho trovato è «SE AVANZO SURGELATEMI»: chi mai ha ideato questa folgorante parafrasi di un motto mussoliniano? Chi sarà mai quell’io che ci ha regalato questa perla del suo umorismo? Rido grazie a non so chi.
Come spesso capita navigando nella rete, onda su onda come cantava Paolo Conte, un dettaglio mi ha spiaggiato quindi su L’armata Brancaleone, che ho visto per la prima volta quando avevo 7 anni, nel 1966, e che per me è diventato una sorta di miniera di repertori che credevo di saggezza atavica popolare.
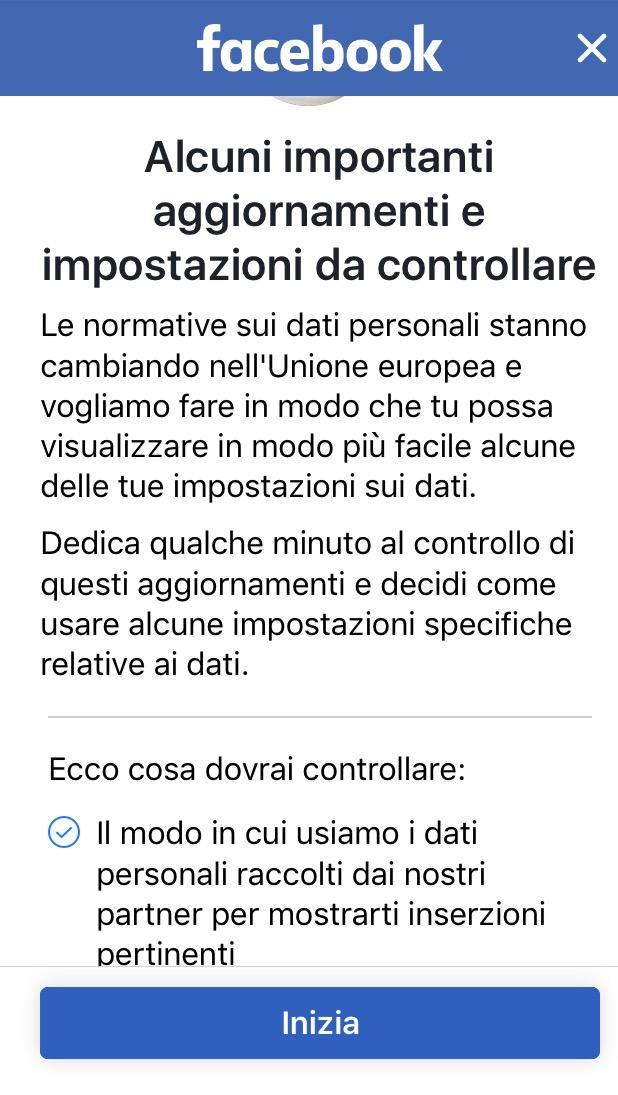
Studiando un po’ scopro che Mario Monicelli lo considerava uno dei suoi film più importanti, e che Age & Scarpelli quella lingua favolosa l’avevano inventata pescando nella nostra letteratura medievale e maccaronica. Gassman che si lascia adescare dalla sensuale signora e poi fugge sputacchiando quando lei gli parla della peste per me è sempre stato l’apoteosi del maschio italiano, insieme avventuroso e scemo. Enrico Maria Salerno predicatore isterico di castità e crociate contro gli eretici mori è in quel film straordinario, e soltanto rivedendo il film in questi giorni ho capito chi aveva in mente Faletti quando faceva lo spassoso personaggio del predicatore invasato al Drive In di Ricci: «Sanza armatura, sanza paura, sanza calzari, sanza denari, sanza la brocca, sanza pagnocca, sanza la mappa, sanza la pappa…». Quel Medioevo di deliranti ego e di disgraziati precari non mi sembra tanto diverso dai nostri giorni: L’armata Brancaleone ebbe un grande successo, fece ridere molti italiani, e lo trovo tuttora un film arci-italiano, con quella lingua prodigiosa completamente reinventata e insieme così credibile. Quante volte attraversiamo un “cavalcone” (ponticello di assi e corde) fidandoci di qualcuno, in rete, e poi sprofondiamo con lui o prima di lui nella voragine del fake? Quanti insignificanti ego seguiamo su Facebook e quanto è insignificante il nostro ego sul balcone di Facebook o di Instagram?
Ma ho la sensazione (fake?) che quel 1966 in cui potevamo sentirci italiani e prenderci in giro fosse felice. Fosse un sentire comune. Una sorta di identità nazionale. Insieme colta nella ideazione e nella realizzazione e popolare nel raccontare e condividere risate e senso della nostra più assoluta precarietà del vivere. Per grado di separazione poi sono balzato a Indietro tutta!, il programma Rai di Renzo Arbore del 1988: anche qui tutto è parodiato, con garbo, buon gusto, allegria, e a essere rappresentati siamo noi italiani: arguti, ignoranti, belle… Nino Frassica, presentatore esuberante, storpia sistematicamente la lingua italiana, e Arbore ridendo lo corregge. Un successo popolare e condiviso anche in quel caso, negli opulenti craxiani anni Ottanta, così come Brancaleone era giunto alla fine degli opulenti anni Sessanta democristiani. Felici anni, quelli? Certo molti più italiani si sentivano benestanti, e in un certo senso soltanto Pier Paolo Pasolini aveva capito che in realtà le tante autentiche Italie di popolo stavano piallandosi e sputtanandosi nell’idiozia di massa seriale che occorreva al capitalismo per trasformarci in consumatori clonati.
Gli anni Ottanta forse sono stati il nostro “amiamo e godiamo cuccurucù» e dopo il 1990 in cui è arrivato il web siamo via via esplosi in milioni di pixel e di ego clamanti nella brevissima attenzione di altri ego. Dopo il 1966 dell’Armata Brancaleone il 1988 di Indietro tutta! Eravamo felici o no? Certamente sapevamo usare ascoltare roteare la lingua italiana; poi, c’erano grandi tempi teatrali, le radici del talento italiano, sempre alto e basso simultaneamente, sempre capace di occupare il tempo rappresentativo con fenomenale ampiezza e virtuosismo.
Infine ho visto Zuckerberg sprofondare nel suo cavalcone, con il volto terreo davanti al fuoco di fila dei congressisti Usa: lui, il ragazzino che ha trasformato gli annuari fotografici dei college americani in un pratico database per contattare le più belle ragazze della scuola bypassando la timidezza dell’approccio live; il milionario era ridicolo, terrorizzato di perdere i suoi soldi virtuali e reali, racimolati grattando tag dai nostri ego ululanti al nulla. In un tempo i cui i nostri ragazzi non giocano con la nostra lingua, ma la rimpiccioliscono e perdono inseguendo il “non fare un cazzo pieni di soldi”, con il naso nello smartphone giorno e notte, «in fila longobarda».









