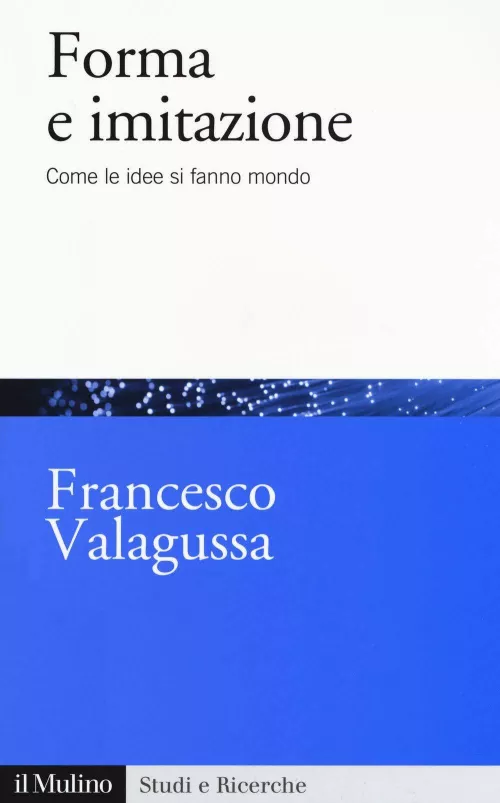Forma e imitazione / Diventare noi stessi
Come siamo giunti a vedere e sentire il mondo come lo vediamo e sentiamo? Come le idee si fanno mondo? Come siamo diventati e diventiamo gli esseri umani di oggi? Il cammino di attraversamento proposto dalla guida, nel senso proprio di una guida per un viaggio, di Francesco Valagussa (in Forma e imitazione. Come le idee si fanno mondo, Il Mulino, Bologna 2020), esalta le vie del divenire umani e suscita una profonda nostalgia, mista a indignazione, riguardo all’attuale triste indifferenza, anche istituzionale, verso gli studi classici, in particolare di storia e filosofia.
Lasciamoci, perciò, guidare in un cammino che va da Omero a noi, che viviamo di immagini, quindi di imitazioni più o meno riuscite delle forme, al punto di illuderci, cioè di giocare con il mondo, come se quelle immagini fossero le forme stesse, o di dimenticare del tutto le forme e vivere “di segni di segni, perché ci fanno difetto le cose”.
A un certo punto della nostra storia l’appartenenza tacita e coincidente con il mondo inizia a trasformarsi in domanda. Gli umani si distanziano dal fondo della vita e la visione cristallina dell’idea compare nella sua assolutezza. È l’intelletto che ha fatto irruzione. Dopo vagiti prolungati per differenziarsi dall’anima del mondo, i primi sapienti e i primi artisti iniziano a porsi domande a proposito del sorgere della forma. Mentre prima non facevano altro che costruire in pietra quel che il poeta esprimeva in parola, nella tradizione orale, come in Omero, accedono ora alla contemplazione affermando il primato della visione. Certo, la storia viene da lontano. Si può risalire alle origini del nostro comportamento simbolico e trovare fin da circa duecentomila anni fa i prodromi del tracciare segni inutili o incisioni altrettanto inutili – nel senso di non immediatamente strumentali e pratiche –, ma siamo, almeno fino agli egizi, dentro immobili schemi di apprensione tattile. La personalità si trovava immersa nella tradizione e veniva resa impossibile una consapevole separazione da essa.
“La separatezza dell’intelletto è una novità solo greca” (p. 40). “I Greci spezzano l’integrità della superficie, introducendo il movimento e l’illusione” (p. 41). Una realizzazione dei valori ottici. H. Wölfflin esprime con puntualità questa evoluzione: “da una parte si sentono gli oggetti nei loro elementi tattili, nel contorno cioè e nelle superfici, dall’altra si percepiscono in maniera da affidarsi esclusivamente all’apparenza visibile della realtà, rinunciando al disegno ‘tangibile’” [Concetti fondamentali della storia dell’arte, Longanesi, Milano 1984; p. 61]. Presa la distanza, speculano, nel senso di assumere la posizione e la distanza dello specchio, sul principio delle cose. Persa la tacita ingenuità dell’appartenenza appiattita sull’esistente, la coincidenza con l’anima del mondo, si domandano se «l’acqua è il principio di tutte le cose» [Talete, DK 11 A 12, I presocratici, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2012; p. 169]; se non si possa assumere «come principio l’infinito» [Anassimandro, D12 A17, I presocratici, op. cit., p. 189]; o se non vi sia a «principio di tutte le cose il fuoco» [Eraclito, I presocratici, op. cit., p.329].
La percezione diviene un atto mentale staccato dall’azione e dal movimento corporei; dal sapere, immediato e pratico si passa al sapere di sapere, ergendosi sulle colonne della sapienza greca alle origini del pensiero europeo [Onians, Le origini del pensiero europeo, (1951), Adelphi, Milano 2012]; per giungere successivamente al sapere di non sapere e iniziare da lì un viaggio circolare che riporterà al riconoscimento del non sapere di sapere, l’incidenza della conoscenza tacita e inconscia e della non padronanza di se stessi, fino ai tentativi di comprendere come facciamo ad apprendere ad apprendere, nel tempo in cui accadono due cose contingenti e contemporanee: l’affermazione del paradigma corporeo, del movimento e della percezione in quanto azione, come chiave per comprendere la conoscenza, e la rilevanza dell’immaginazione per accedere a campi conoscitivi come l’infinitamente piccolo, i quanti, o l’infinitamente grande, le galassie e gli universi, accessibili solo con l’immaginazione.
Nel momento in cui ci separiamo dall’anima del mondo, infrangendo la superficie e la nostra appartenenza tacita ad essa, per istituire la separatezza delle forme, ci ritroviamo a elaborare un trauma di particolare intensità. Un travaglio da nuova nascita. Pare che dalla elaborazione di quel trauma si generino la tragedia e la statuaria. «La tragedia trova il suo analogo», scrive Valagussa, «non nella singola statua a tutto tondo, bensì negli altorilievi che adornano i frontoni dei templi» (p. 44). E Nietzsche approfondisce: «Se un miracolo avesse infuso la vita, sul frontone del Partenone, a quelle figure marmoree della contesa tra Atena e Poseidone, esse avrebbero senza dubbio parlato la lingua di Sofocle» [F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 2006; p. 19]. Sempre Nietzsche si era reso conto della trasformazione avvenuta separando, fin da Anassagora, anima e intelletto e, pur servendosi di entrambi come di un’unica natura, dell’affermazione dell’intelletto come principio di tutto. A un certo punto l’anima del mondo si è messa a cercare il meglio sollecitata dall’intelletto. Prima, insomma, vi era la natura in quanto vita che sorgeva da sé e si alimentava in se stessa: l’anima vi prendeva parte, pienamente integrata nel ciclo vitale.
All’inizio, insomma, vi fu la necessità naturale. La separatezza delle forme compromette la forza vitale e genera il trauma della scissione tra psiche e phýsis che due millenni non sono riusciti a saldare. Da quel momento in poi non siamo più usciti dal dilemma platonico tra radicalizzare il movimento come opportunità di comporre il tutto, o guardare con occhio fermo alla separatezza per non perdersi nelle spire dell’indeterminato, nel salto netto tra l’idea e il sensibile. Né i cinque generi platonici, nel Sofista [BUR, Milano 2011], dall’essere, all’identico, al diverso, alla quiete, al movimento, possono essere considerati esaustivi di una saldatura possibile, pur considerando l’irrelatività delle forme e la comunicabilità tra i generi. D’altra parte, è dalla rottura o superamento dell’unità che può nascere lo spazio del confronto. Valagussa evidenzia come sia sullo sfondo del non essere che si produce la possibilità di quello sviluppo. L’attenzione è al passaggio, interno al “non essere”. Possono esservi due accezioni del “non essere”: dal “non essere” come contrario, al “non essere” come altrimenti, che saranno la base della pluralità e della composizione nelle arti e nella società. Il distacco dalla natura produce il senso del contrario, e da qui l’invenzione della diversità. “L’invenzione della diversità come un altrimenti comporta una negazione che dischiude: instaura uno spazio di confronto superando l’irrelatività delle idee” (p. 49). Evoluzioni e passaggi vertiginosi che preparano le condizioni per una società dialogica, aperta, che riconosce le differenze, che si apre alla possibilità stessa della democrazia. Di particolare interesse è che l’arte è antecedente all’evoluzione delle forme della cultura e della socialità, in particolare nella statuaria, nella tragedia, nella pittura vascolare.
Sono le contraddizioni del bello, riguardanti l’ammissione della diversità come altrimenti, che muovono la trasformazione. Nell’accezione greca arcaica, bello significa integrità e compiutezza, cosa che trova riscontro nella scultura a tutto tondo; una bellezza che sarà definita addirittura «sana», in base a una certa traduzione di Kalos. Quell’integrità si frantuma e ne sono una prova sublime i versi di Saffo: «L’uno dirà che della negra terra siano i cavalieri la cosa più bella, l’altro dirà i fanti o le navi, ed io ciò che il cuore, amando, desidera» [Liriche e frammenti, Feltrinelli, Milano 2002; p. 61]. Anche nel logos si verifica la non coincidenza tra essere e essere altrimenti, aprendosi così lo spazio della negazione che garantisce la possibilità di pensare le cose altrimenti. Nella capacità creativa umana, il linguaggio, ad esempio, permette molto più di quanto le parole stesse siano in grado di dire, “consente di fare con ciò che è conosciuto, cosciente, allusione a ciò che è sconosciuto, inconscio”, come scrive Francesco Marchioro nella densa e illuminante introduzione dal titolo: Le novelle e la natura dello psichico in Freud, contenuta in S. Freud, Aforismi metafore e passi, Bollati Boringhieri, Torino 2020. “Il segreto dell’arte”, scrive ancora Marchioro, “è la sua capacità di disporre e modellare quell’interminabile tesoro del mondo emozionale delle parole, dei sogni e delle passioni originarie, che precedono la distinzione razionale tra interno ed esterno” (p. 9).

“Precedono” è, qui, il concetto più rilevante. Sempre più riconosciamo di essere preceduti, nell’emergere dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni, dal corpo e dai movimenti del nostro mondo interno. L’accesso alla cognizione e, ancor più, alla nostra esperienza estetica, sono filtrati dalla nostra corporeità e dal nostro sistema sensorimotorio. Siamo preceduti, inoltre, dalla lunga durata dell’elaborazione tra sensibilità e intelletto, un conflitto estetico interiore che ci attraversa da tempo, la cui elaborazione ci ha cambiato e continua a cambiare la nostra sensibilità. Per molti aspetti l’arte contemporanea e la nostra attuale esperienza estetica sono composte dall’emergere e riemergere delle dimensioni arcaiche della nostra sensibilità e del conflitto continuo con le razionalizzazioni del nostro intelletto. La forma continua a fare i conti con la molteplicità irriducibile delle imitazioni che scaturiscono dal nostro conflitto interiore, e tutto questo è antecedente alle nostre esperienze e le informa e forma. Precisa, in tal senso Valagussa, avvalendosi del supporto platonico: “Il problema dell’apparenza come illusione è coevo al passaggio del non essere come contrario, al non essere come essere altrimenti. La mimesi è il terreno che si schiude quando la cosa può essere vista e pensata altrimenti: ‘rendersi simile a un altro nella voce o nella figura non è forse imitare colui che ci rende simili?’” (p. 14). Del resto, l’illusione non può essere considerata solo inganno o abbaglio. Riguarda anche la fantasia, l’immaginazione e la disposizione a giocare con la realtà e il mondo; la propensione a esprimere comportamenti mimetici così connessa al conflitto della conoscenza e al pensare altrimenti, ma anche a desiderare il desiderio di un altro, come ha ampiamente mostrato René Girard.
L’accesso alle varie raffigurazioni della realtà porta alla comparsa sulla scena dello spettatore che osserva la cosa di volta in volta adombrata, con il senso di perdita della realtà unica o realtà in sé. “Il problema dell’essere si trasforma nella questione dell’essere come appare, ossia della sua apparenza” (p. 55), lasciando spazio alla dimensione fantastica. Si pone allora un problema di non poco conto: come si fa a tenere insieme gli effetti dell’azione della sensibilità moltiplicatrice? È il logos che svolge la funzione di cercare di tenere insieme i frammenti, di ricostruire faticosamente uno sfondo, mentre la sensibilità moltiplica e scinde altro e altrimenti. E purtuttavia le fascinazioni del molteplice incantano; a metterle in discussione in base alla tendenza all’unità del logos si sperimenta un senso di perdita del piacere e del fascino risvegliato dall’altrimenti. Del resto, l’indeterminato ci circonda, ingestibile. Con una felice espressione Valagussa commenta: “un sofista meraviglioso ha provato a incantarlo (l’indeterminato) col suo ragionamento bastardo, e ci ha trasformato tutti in giovani che non toccano più con mano” (p. 63). Quel sofista si chiamava Platone, forse il più grande nemico dell’arte, mentre la creatura del suo inganno è la scienza. Una domanda si fa strada di fronte a una così profonda speculazione: per un animale che ha evoluto il comportamento simbolico, esiste un’altra via che non l’attribuzione di significato e l’illusione per conoscere il mondo? Quell’evoluzione viene da lontano, dalle prime effettive manifestazioni dell’espansione neocorticale che divengono riconoscibili mediante prove neurofisiologiche e archeologiche. “Un numero consistente di prove”, scrive D. Lord Smile [Storia profonda. Il cervello umano e l’inizio della storia, Bollati Boringhieri, Torino 2017; p. 208], “che spaziano dai pattern artistici alla forma del palato e alla posizione della laringe, sembra convergere verso un’esplosione creativa che ha avuto luogo pressoché contemporaneamente all’ultima diaspora africana. Dato che le popolazioni africane e non-africane condividono la medesima capacità del pensiero simbolico, sembra probabile ritenere che l’esplosione creativa sia accaduta prima della diaspora e, anzi, che sia servita da molla”. Diventare creativi significa evolvere una inedita modalità di affrontare il nuovo e l’imprevisto, con lo sviluppo di dinamiche anche cerebrali discontinue rispetto alle fasi precedenti.
Significa, quindi, accogliere l’incertezza, l’imprevedibilità e l’indeterminato nella propria esperienza, e assimilare gli effetti della loro elaborazione nel proprio sviluppo evolutivo. Se sottraiamo certezza in ragione del riconoscimento dell’indeterminato, otterremo un sistema più ricco, perché reso discreto in ragione della capacità illusiva e mimetica del linguaggio. Eppure, le incursioni dell’indeterminato andranno respinte o perlomeno contenute, riconoscendo che il primo fattore d’indeterminatezza è la negazione, è il “non”. Al fine di contenere l’indeterminato e controllare la polisemia della negazione, un primo principio o “recinto” è il principio di non contraddizione, “il più saldo, quasi nume tutelare di tutti gli altri ‘congegni’, costruiti per difendersi dagli assalti dell’indeterminato, a riprova della ‘evidenza della contingenza dell’ente’” (p. 77). Se il principio di non contraddizione tende a contenere la polisemia che sgorga dalla negazione, interviene il secondo principio, quello del terzo escluso, a cercare di gestire il potenziale della presenza e la sua indeterminazione. Possiamo considerarlo “una sorta di secondo ‘recinto’ a guardia dell’indeterminato, perché a volte sarà valido uno a volte l’altro dei corni dell’antifrasi, ma sempre uno di essi” (p. 81). Si potrebbe avvertire qui una criticità forse ineliminabile che ancora una volta evidenzia il conflitto della conoscenza: il terzo escluso agisce, in fondo, per ridurre il possibile alla logica del necessario. Del resto, viviamo all’insegna del primato dell’azione, l’atto viene prima, con il suo portato di indeterminatezza e apre continue brecce nella prospettiva scientifica aristotelica, che vuole domare il fertile grembo dell’esperienza.
Sarà il processo di delimitazione tra intuizione dimostrabile e sensazione che, in quanto terzo ‘recinto’, ci pone di fronte all’atto di nascita della scienza, intesa come la scelta di sospendere l’inesauribile processo di problematizzazione dell’esperienza a un determinato livello. A pensarci vi è una decisiva attualità nel pensiero antico, se con Ernst Mach ci troveremo poi, all’inizio del Novecento, a riconoscere l’indeterminatezza della conoscenza scientifica e la scelta necessaria dell’osservatore di introdurre un’invariante come condizione stessa della conoscenza possibile. Come scrive Valagussa: “Il campo della scienza è delimitato verso l’alto dai principi e verso il basso dall’individuale” (p. 91). All’origine della conoscenza vi è la facoltà dell’immaginazione che si trova “a gestire una zona grigia tra individuale e universale” (p. 98). L’immaginazione consente di generare assunzioni generali a partire da casi singoli e di tendere così all’universale come emancipazione dalla “contingenza degli attimi”, come l’ha chiamata Giorgio Colli. Con l’arte di immaginare giungiamo al teatro, alla poesia, al riconoscimento come trasformazione della non conoscenza in conoscenza. La profonda articolazione del contributo di Valagussa accompagna il lettore per le impegnative vie dell’immaginazione e della costruzione della sensibilità nel corso della storia. Si tratta di un excursus dotto e allo stesso tempo in grado di selezionare i prodotti dell’umana imitazione, dall’incarnazione fino alle più azzardate finzioni. Dal ruolo di Saulo di Tarso che diventa S. Paolo e che, mediante l’imitazione di Cristo, chiede a sua volta di diventare suoi imitatori, risolvendo con la fede il dilemma tra verità e realtà, fino al cosmo di Plotino, dove ogni realtà è immagine di un’altra realtà, e forma naturalistica e organica si intensificano fino a trovare il loro esaurimento, per indicare una delle molteplici tracce segnate da Valagussa. L’avvicinamento alla realtà, fino a voler far coincidere l’immaginazione con essa, lascia poi il posto all’astrazione e all’allegoria e periodicamente l’astrazione e la relazione astratta tra le cose diventano il canone dell’imitazione.
Un andirivieni tra incarnazione e imitazione, tra visione della pura bellezza secondo la concezione neoplatonica, e l’unicità esclusiva dell’incarnazione che è solo nell’immagine di Cristo, si produce e riproduce continuamente. L’umanizzazione della bellezza, ad esempio, fa continuamente i conti con la propensione alla trascendenza. Così, mentre Plotino definisce bello non solo ciò che è armonico, ma anche quello che è semplicemente espressione della natura, accade alle immagini di trasformarsi in simboli concettuali e astratti. L’imitazione e la verità, tra idealismo e naturalismo, continuano ad essere il filo portante della speculazione dell’autore per tutto il libro, e allo scopo viene mobilitata una parte davvero cospicua della filosofia e della ricerca occidentali. È quel che accade anche con Dante, che nella Commedia mette in figura il “perfetto quasi” attraverso in “quasi imperfetto”, inaugurando uno spirito nuovo sul quale si innesterà il pensiero del Rinascimento. Con Pico della Mirandola e Giordano Bruno, ad esempio, sarà la mente ad assumere una posizione centrale e la bellezza sorgerà come imitazione non di questo o quell’oggetto, ma dell’infinito. L’analisi delle trasformazioni della civiltà europea, seguendo le orme di Giordano Bruno o di Spinoza, fino a Kant, che intende ritagliare un ruolo trascendentale al sentire attraverso le categorie come forme dell’intelletto separate dalla baraonda delle sensazioni (p. 271), e a Nietzsche, portano a considerare il ruolo della mimesi tra sapere e potere. La separatezza mantiene la sua ambivalenza fino alla fine: mentre le forme sono luminose, compiute, il “resto” rimane movimento confuso.
Quella separatezza delle idee è, infatti ragione della loro assunzione a modelli tramite cui leggere il movimento del mondo sensibile, ma è anche causa dell’inattendibilità di un giudizio ultimo (p. 298). Sarà Walter Benjamin a sostenere che “l’oggetto della conoscenza non coincide con la verità […] La conoscenza è interrogabile, ma non la verità” [Dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1999; p. 5]. Ogni volta, come è evidente, si presenta un gioco che va dalla creazione di un modello, un’idea appunto, alla sua trasformazione in mondo tramite l’imitazione. L’intera tradizione occidentale ci scorre davanti agli occhi come una continua metamorfosi tra forma e imitazione. Le infinite produzioni dei corpi, le sensibilità, e delle menti, l’intelletto degli umani, finiscono per disegnare una trama che, allo stesso tempo ci costituisce e da cui siamo costituiti. In fondo, è in quel gioco e mediante quel gioco che diventiamo noi stessi.