Elogio della sottrazione
Non è facile definire una forma, costruire una morfologia, del nostro tempo. La nostra mente non è sgombra, anzi è decisamente satura, e fare spazio e silenzio per cercare di comprendere il presente risulta oltremodo impegnativo. Ci può aiutare, manco a dirlo, la poesia. A patto di impegnarsi, perché l’operazione non è gratuita, a stabilire una connessione tra ontologia, poetica e storia. È quello che cerca di fare, con esiti di grana fine Salvatore Tedesco con il suo libro La poesia e la forma del nostro tempo [Meltemi, Milano 2023]. Pare che per avviare e portare avanti un tentativo del genere sia necessario muoversi verso il carattere, concreto e indeterminabile allo stesso tempo, di un certo numero di interlocutori poetici che aprono finestre di luce e comprensibilità di almeno alcuni squarci del presente. Del resto, Luigi Pagliarani ha sempre sostenuto che quello hanno di speciale i poeti, vivono e sentono al di sopra delle proprie possibilità. Ebbene, due dei numi tutelari che Tedesco convoca nel costruire il proprio percorso di ricerca sono Osip Mandel’stam e Inger Christensen. La seconda, in verità, è una delle poetesse sul cui lavoro il libro è costruito, insieme a Mariella Mehr, Anne Carson e Marija Stepanova. Allo studio, nonché all’introduzione in Italia, della forza della poesia e del pensiero di queste poetesse, Salvatore Tedesco dedica da anni un intenso lavoro. Ascoltando, per il momento, Mandel’stam e Christensen, possiamo sentire vibrare le corde della fatica e del fascino commovente di cercare di dare forma ai nostri difficili giorni. Giorni in cui, come scrive l’autore nell’introdurre il libro, “nel simbolo del partito di maggioranza relativa al governo in Italia arde la fiamma dei repubblichini di Salò, e si avverte ancora più urgente l'esigenza di scorgere nella ricerca il contravveleno, in preparazione di tempi diversi”.
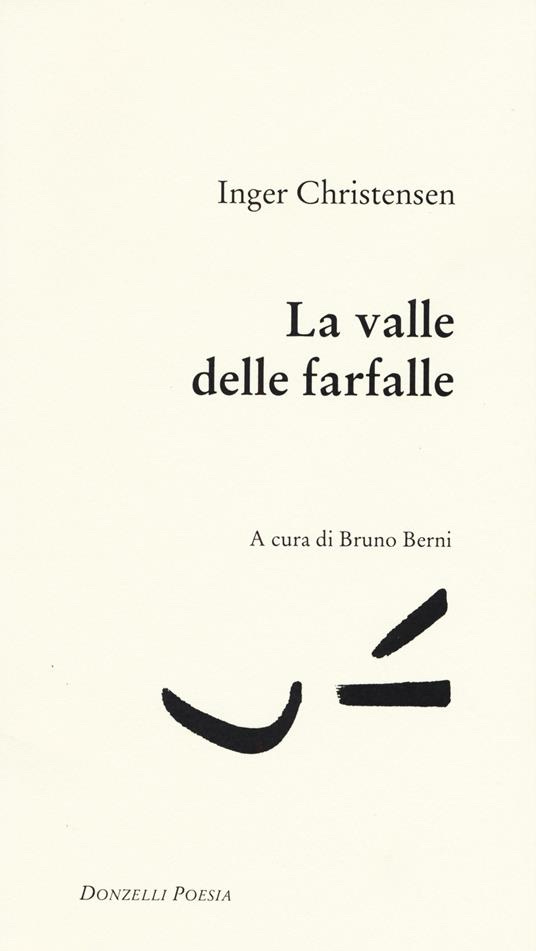
In un testo apparso in italiano nel 2003 da Bompiani, Dell’interlocutore, nel volume dal titolo Sulla poesia, Mandel’stam scrive: “Nel pazzo ci spaventa soprattutto la terribile, assoluta indifferenza che egli dimostra verso di noi. Non c'è nulla di più terrificante per un uomo della totale indifferenza di un altro uomo per lui”. A sua volta Christensen, in La stanza dipinta sostiene: “Ciò che dovremmo pensare è che dall'altra parte di questo ordine domina la libertà, e che è con quella libertà che dobbiamo condurre le nostre conversazioni sull'interpretazione della vita tra persone e mondo. Dallo scrivere i nostri cuori nel caos, e vedere una generazione dopo l'altra andare in rovina sotto un avvilimento sempre più grande, potremmo arrivare a iscrivere i nostri cuori nella libertà e vedere una vita umana dopo l'altra scivolare nel paese dei vivi” [I. Christensen, La stanza dipinta, Scritturapura, Asti 2014].
Se possiamo intendere l'indifferenza come la sospensione eccessiva della nostra naturale risonanza incarnata con gli altri, come abbiamo provato ad evidenziare nel libro Indifferenza [U. Morelli, Indifferenza. Crisi di legame sociale, nuove solitudini e possibilità creative, Castelvecchi, Roma 2023], l'indifferenza può essere terrificante e, parafrasando Christensen, metterci nelle condizioni di scivolare nel paese dei morti viventi. È l’altra parte di questo ordine che la poesia come pratica della libertà prova a mostrarci. L’attraversamento del dolore del presente non ce lo può togliere nessuno, si tratta di un esame di realtà necessario. Possiamo però provare a iscrivere i nostri cuori nella libertà e vederci scivolare insieme ad altri nel paese dei vivi. Fa eco a questa prospettiva, un’eco struggente, Maria Stepanova, portando all’estremo radicale la critica del presente e proponendo il “non-essere” come passaggio indispensabile per ritrovarsi, dove il fantasma dell’assenza diventa un dono irrinunciabile:
“chi non ha io,
può permettersi il non-essere
e vuole andare verso la libertà”.
È difficile immaginare, viene da considerare, una possibile via d’uscita da questo presente fallito e invivibile senza portare alle estreme conseguenze l’analisi critica, fino a vedere e sentire il vuoto per poterne cogliere una germinalità possibile.
Inevitabile l’associazione e la risonanza con un’altra voce potente e costantemente presente, quella di Ingeborg Bachmann, quando in Invocazione all’Orsa Maggiore [Adelphi, Milano 2023; p.119], scrive:
“Alla luce dell’uva, all’ombra della vite
matura il tuo ultimo volto.
La notte deve voltar pagina”.
A proposito del vuoto necessario, ci deve essere a un certo punto del tempo delle nostre vite una consonanza, uno spirito del tempo, che genera affinità di sentimenti e di pensieri, se Giorgio Agamben, proprio a proposito della nostra contemporaneità, scrive: “Percepire nel buio del presente questa luce che cerca di raggiungerci e non può farlo, questo significa essere contemporanei. Per questo i contemporanei sono rari. E per questo essere contemporanei è, innanzitutto, una questione di coraggio: perché significa essere capaci non solo di tenere fisso lo sguardo nel buio dell'epoca, ma anche di percepire in quel buio una luce che, diretta verso di noi, si allontana infinitamente da noi. Cioè ancora: essere puntuali a un appuntamento che si può solo mancare” [G. Agamben, La mente sgombra. Profanazioni, Nudità, Il fuoco e il racconto, Einaudi, Torino 2023].
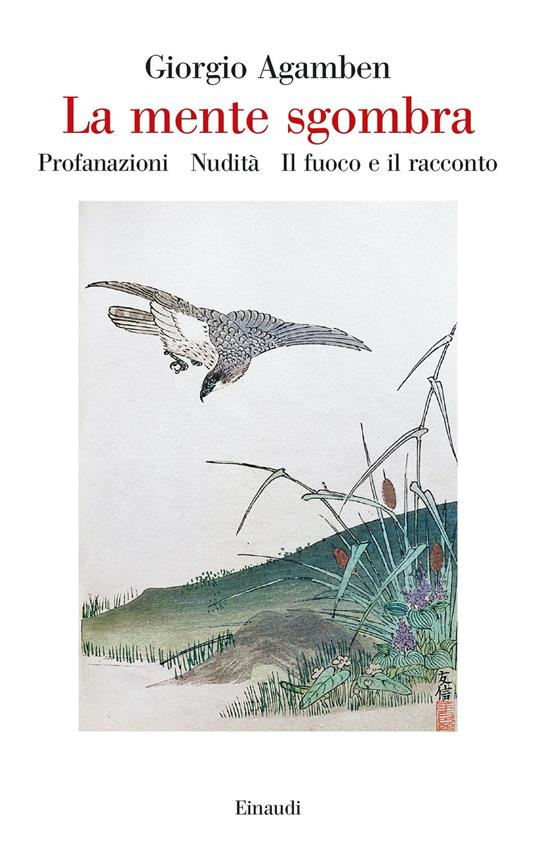
Secondo Agamben, di una cosa la parola e il pensiero hanno bisogno: che lo spazio per riceverli sia sgombro, che non vi siano muri e ostacoli che impediscano l'accesso. È proprio questa però la cosa più difficile e rara, perché la mente degli uomini è sempre ingombra e come murata. Fare un’operazione di sgombero, fare posto, non solo potrebbe essere la vera tradizione che, anziché conservare, finalmente sgombra lo spazio, si apre e ci parla, ma assume il superamento della soglia in cui arcaico e contemporaneo, teoria e prassi, coincidono senza residui. La stessa scrittura riconosce che “ha bruciato tutte le sue carte d'identità ed è, insieme, filosofia e letteratura, divagazione e scheda filologica, trattato di metafisica e nota di costume”. Il ritorno al vuoto originario ci consente di riconoscere che conviviamo dalla nascita alla morte con un elemento impersonale e preindividuale. “Ma la parte impersonale e non individuata non è un passato cronologico che ci siamo lasciati una volta per tutte alle spalle e che possiamo, eventualmente, rievocare con la memoria; essa è tuttora presente in noi e con noi e da noi, nel bene e nel male, inseparabile”. Avvicinarsi alla dimensione incandescente dell’impersonale, della derealizzazione, o della decreazione, per dirla con Salvatore Tedesco, è quello che le poetesse di cui il libro si occupa fanno, anche con la propria vita. Come è in particolare per Mariella Mehr, che abita con angoscia e creatività il suo e il nostro ultimo miglio di tempo. Avvicinarsi a quella temperatura può produrre panico, il sentimento che qualcosa ci avvenga di infinitamente più grande di quanto ci sembra di poter sopportare. “Per questo la maggior parte degli uomini fugge atterrita davanti alla propria parte impersonale o cerca, ipocritamente, di ridurla alla propria minuscola statura”, scrive Agamben. È evidente come sia la nostra dimensione emozionale la via attraverso cui entriamo in rapporto col preindividuale. Emozionarsi significa sentire ciò che ci precede, il non essere, l’impersonale che è in noi, facendo esperienza contemporaneamente di angoscia o letizia, di sicurezza o tremore. Si fa strada, quindi, prima ancora del mondo fuori di noi come nostro antecedente evolutivo, ciò che meraviglia e stupisce, ovvero la presenza in noi di una parte per sempre immatura, infinitamente adolescente, che esita sulla soglia di ogni individuazione. Noi adultescenti, diceva sempre Luigi Pagliarani.
Il rapporto con l’impersonale e l'originario si configura come un ritorno al futuro. Quello spazio sottile ci appare allora come uno spazio del possibile, anche perché altro non ci è dato che l'apparire di una forma in filigrana del tempo in cui viviamo e la poesia può esserne il filtro rivelatore. Scrive Salvatore Tedesco: “L'ipotesi che proveremo ad articolare in questo studio è appunto che sia possibile, e forse necessario, costruire attraverso la poesia e in dialogo con la poesia un discorso sulla forma del nostro tempo”. Se poiésis è il fare dal nulla, la creazione poetica è probabilmente la migliore candidata a cercare una morfologia del nostro tempo. Ad aprire lo spazio, e prima di tutto a sgombrarlo, Tedesco, avvalendosi delle trame profonde e inquiete delle poetesse con cui dialoga nel libro, candida processi come la derealizzazione, la decreazione e la dislocazione. Non ci è dato, per cominciare, che decostruire. Questo perché, come mostra con non pochi esiti commoventi Mariella Mehr, la terra in cui viviamo è divenuta esausta e inabitabile. Proprio riconoscerlo può aprire a una prospettiva inedita, impensabile:
Ora che bagniamo di pianto il ponte,
liberati uno del bagaglio dell’altro,
improvvisamente sorge una casa,
una finestra, lacrime, e ognuna
va oltre sé stessa,
un tavolo, due sedie, un letto.
Forme vuote ancora, ma tra poco,
ripulite dai sogni,
abitabili.
“Le Leerformen di una vita sottratta diventano forme abitabili nella scrittura, ed è attraverso la genesi di tale scrittura che il discorso della morfologia a sua volta abita la forma del nostro tempo”, scrive Tedesco. Non c’è nulla che possa essere lineare consequenziale in questa ricerca, ma è necessario un rendersi plurale delle logiche di costruzione e dei principi formali. I dialoghi tra processi creativi, come quello tra Inger Christensen e Anne Carson, attraversano tutto il lavoro di Salvatore Tedesco. A caratterizzarne il percorso e le stesse poetiche analizzate è un operare “per sottrazione” così articolato e costante da far venire in mente, nel campo della scultura, la forza creativa di Alberto Giacometti, quella forza inquieta e insoddisfatta, che proprio nell’arte del togliere, del sottrarre appunto, ha trovato così straordinariamente il proprio vertice e la propria cifra.
La derealizzazione, che pure con il vuoto e la sottrazione ha a che fare, è intesa come apertura inedita del senso del vivente e critica dei progetti di dominio della soggettività moderna.

Il punto zero di questi processi di decreazione e derealizzazione giunge, finalmente, a un nuovo punto di partenza che è il più originario di tutti i punti: il corpo. Il ritorno al corpo può essere lo spazio storico e formale insieme in cui emerge nel nostro tempo il discorso poetico. Salvatore Tedesco, del resto, lo dichiara esplicitamente: “Il corpo ritorna, come si è detto, è da molti punti di vista il punto di partenza e il punto di arrivo di questo studio”.
Non è difficile scorgere come sia di particolare rilevanza il fatto che mentre le scienze del riconoscimento, quelle della contingenza storica, e le neuroscienze in particolare, ci consegnano con sempre maggiore evidenza la pregnanza euristica e conoscitiva del paradigma corporeo, una poetica del presente consegni al corpo le basi per coltivare quella scienza profonda della libertà che attraversa scopi e finalità di questo contributo di Salvatore Tedesco.
A proposito del corpo che torna, si producono per quella via due esiti polari: una trascendenza che si riconosce nel corpo, che forse è l’unica trascendenza effettiva, e ci consente di divenire esterni a noi stessi in una dislocazione illimitata, a proposito della quale l’autore rintraccia un antecedente nell’universo infinito di Giordano Bruno. Allo stesso tempo emerge la sospensione e la sottrazione mediante la quale si dà la possibilità di rimettere in ordine e la produzione di uno spazio formale in cui anti-azione e derealizzazione consentono il passaggio dal possesso alla cura del mondo. È in particolare la poetica di Inger Christensen a esprimersi con la forza della denuncia rispetto alla necessità di cambiare, nel momento in cui si insinua nella cosiddetta volontà di autorealizzazione e ne evidenza l’effetto di acquisizione di potere sulle cose. Una posizione predatoria ed estrattiva che in ultima analisi diviene un progetto di sfruttamento della realtà, di ritraduzione della realtà in mera quantità di risorse indefinitamente appropriabili. Torcere il concetto di realizzazione contro sé stesso apre a una scoperta che consente di riconoscere il valore della derealizzazione. Scrive, infatti, Christensen: “Il giorno in cui entra in quelle che chiamiamo le fila degli adulti, il bambino inizia a realizzare sé stesso, così che qualcosa comunque debba essere presente, invece di derealizzare sé stesso, perché tutto è già presente”. Si evidenzia così l’importanza di creare un nuovo senso di appartenenza che solo un atto poetico può generare, fino a un’inedita considerazione di noi stessi. Siamo un tipo speciale di oggetti, sostiene Christensen, e “ciò che ci separa dagli altri esseri viventi forse non è tanto la coscienza in quanto tale, la coscienza naturale in sé e per sé, quanto piuttosto la nostra consapevolezza della coscienza, il fatto che possiamo accumulare e coordinare la conoscenza in molti strati di coscienza – e per dirla in modo più radicale, forse differiamo da tutto il resto solo perché usiamo la parola dio”. In questa prospettiva il vivente e il non vivente, l’animale, la pianta e l’umano si ritrovano insieme in questo ridestarsi che non smette mai di essere decreazione e derealizzazione, per fare spazio all’inedito necessario, alla possibilità poetica, alla dislocazione nei termini di una decostruzione critica dei modi contemporanei dello sfruttamento della natura nel nostro antropocene.
Come forse è diventato evidente è la libertà umana, e con essa l’idea stessa di umanità, ad essere chiamata in causa nel gioco poetico estetico e dunque nelle modalità di relazione fra sensibilità e forma in cui il gioco creativo è reso possibile. Giocare con la poesia dentro il mondo, ovvero illudersi e fingere, fare come se, è l’invito dai cui movimenti possiamo veder emergere una forma impensata e possibile del tempo a venire.
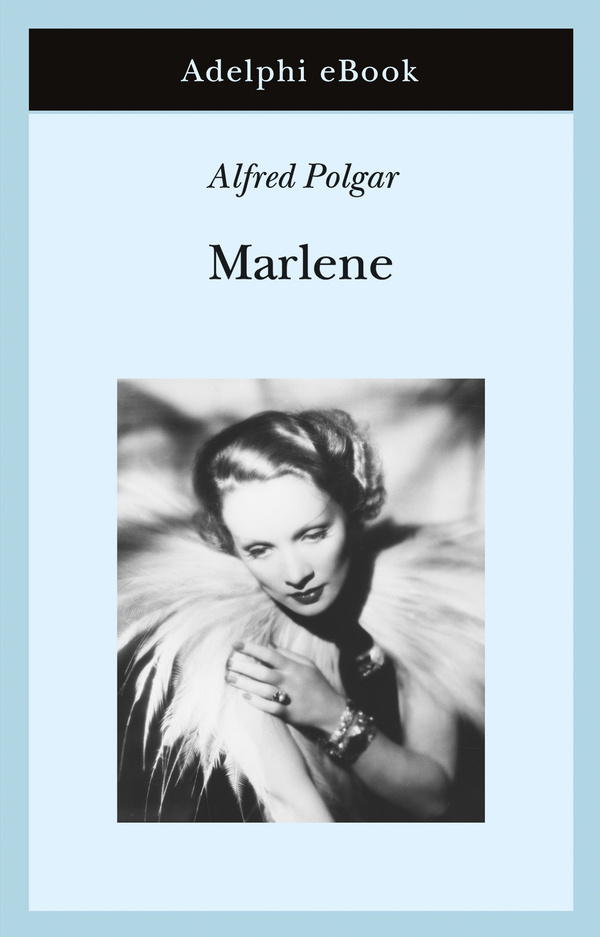
A proposito del confine poroso tra verità e illusione che coesistono, dove l’illusione è tutt’altro che l’inganno, ma dà forma a un mondo intermedio in cui è possibile giocarsi la genesi dell’inedito, dello sconcertante sempre più necessario in questo presente “senza”, nel quale esistiamo, la poesia può assumere volti inediti. Ne fornisce un esempio la descrizione di prima mano che Alfred Polgar fa di Marlene Dietrich in Marlene [Adelphi, Milano 2023; p. 12], appena pubblicato in italiano: “Quel viso singolare attraeva, più ancora che con quanto rivelava, con ciò che sottaceva, con le luci e le ombre che trascorrevano su di esso come i riflessi distorti di una luce lontanissima, con i segni di una vocazione fatale di cui l’interessata stessa sembrava non sapere o non voler sapere nulla”.
Leggi anche
Marco Ercolani, Marija Stepanova, Memoria della memoria
Marco Ercolani, Stepanova: cronache di dolori rivelati
Anna Toscano, Mariella Mehr e le coordinate del tempo
Anna Toscano, Mariella Mehr: “ognuno incatenato alla sua ora”
Vito M. Bonino, Campioni #9: Mariella Mehr









