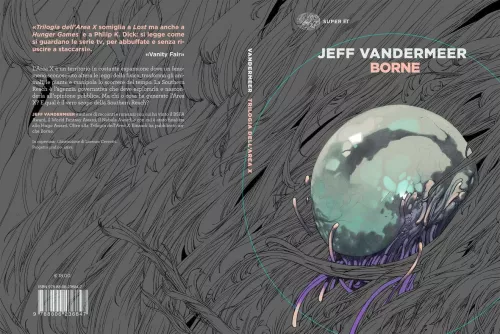Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne
1. La fantascienza e l’ecologia sono sempre andate d’accordo. La prima si è ispirata alla seconda per immaginare scenari utopici o distopici incentrati sul rapporto tra gli uomini e il loro ambiente. Del resto, come già spiegava Lewis Mumford (nella classica Storia dell’utopia, 1922: l’edizione italiana più recente, da cui citerò un brano, è uscita per Feltrinelli nel 2017), all’origine del pensiero e della letteratura utopica c’è sempre la tensione tra un territorio reale e un territorio ideale: come dice il nome, l’utopia è prima di tutto un concetto spaziale, che si trasferisce nel ‘disegno’ di un ambiente tale da consentire, con le sue caratteristiche naturali, lo sviluppo di un sistema politico e sociale. Per Fourier, ad esempio, lo spazio dell’utopia avrebbe avuto bisogno di un territorio adattabile a funzioni diverse: «Un terreno piatto come Anversa, Lipsia o Orléans sarebbe assolutamente inadatto […] a causa delle uniformità di paesaggio. Sarebbe perciò necessario scegliere una regione variata come i dintorni di Losanna o una amena vallata provvista di un corso d’acqua e di boschi, come la valle di Bruxelles o di Halle» (Storia dell’utopia, cit., p. 86).
Quando su queste basi s’innestano un moderno immaginario fantascientifico e un’ideologia ecologista, nasce il genere dell’Ecotopia: una sorta di fantapolitica ‘verde’, che ha il suo testo fondante nel romanzo di Ernest Callenbach così intitolato. Pubblicato nel 1975, con un séguito nel 1981, Ecotopia è ispirato dall’idea che un’adozione consapevole della tecnologia possa contribuire allo sviluppo ideale della società e alla sua armonia con la natura, invece che allo sfruttamento delle risorse. La vicenda è ambientata nel 1999, nella nazione di Ecotopia, fondata diciannove anni prima in seguito alla secessione dagli Stati Uniti della California settentrionale, dell’Oregon e dello stato di Washington (la West Coast americana dove, negli anni Settanta, si erano affermate tendenze della controcultura ecologista, come la urban ecology). Un giornalista, Will Weston, vi si reca per scrivere un reportage da un paese un tempo parte del territorio americano, ma ora autonomo e caratterizzato da costumi diversi e stranianti. Nella descrizione di Ecotopia, il narratore ricorre allo sguardo straniante del viaggiatore per rappresentare uno spazio noto da un punto di vista originale.
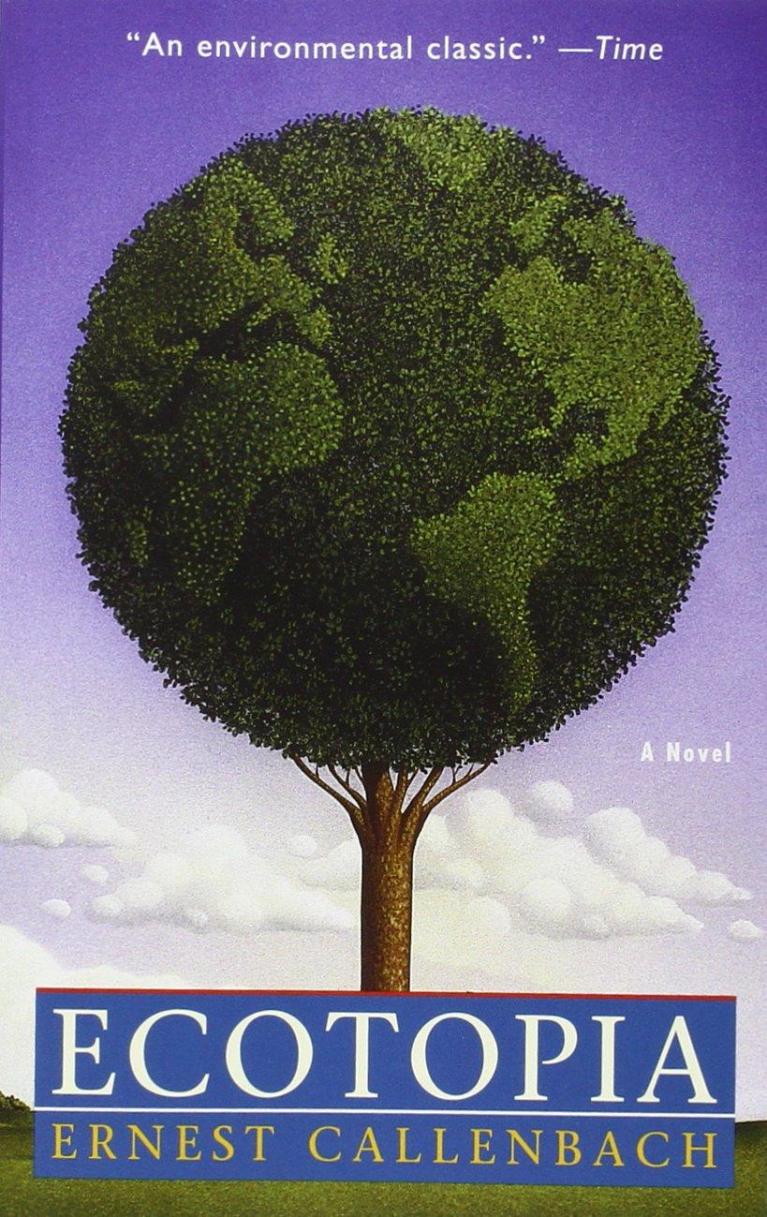
Ecotopia.
Lo straniamento è un dispositivo fondamentale della fantascienza, come insegnano gli studi sul genere, da quelli canonici di Darko Suvin a quelli recenti di Simon Spiegel (in particolare il saggio uscito nel 2008 in «Science Fiction Studies»: Things Made Strange: On the Concept of “Estrangement” in Science Fiction Theory). Ma una forma di straniamento è anche all’origine del pensiero ecologico, fondato sulla coscienza che il territorio nel quale viviamo è un ambiente (Umwelt) popolato anche da altre specie, che hanno di quello stesso spazio una percezione diversa, commisurata a caratteristiche ed esigenze biologiche diverse dalle nostre.
Il discorso ecologico si serve comunemente dello straniamento a fini persuasivi, per esempio per mostrare i danni prodotti dall’uomo sull’ambiente, facendoci guardare con occhi diversi gli effetti di alcune nostre abitudini quotidiane. Può farlo anche portandosi sul campo della finzione narrativa, raccontando la civiltà umana dalla prospettiva di animali e creature immaginarie, o rappresentandola da un orizzonte temporale lontano, soprattutto nel futuro. È in questo tipo di rappresentazione che si consolida la relazione tra ecologia e letteratura fantastica e fantascientifica; una relazione di lungo corso, le cui premesse risalgono a epoche premoderne, ma che negli ultimi decenni ha raggiunto un più alto grado di intensità proporzionato alla crescita del rischio ecologico e alla sua presenza nel dibattito politico, civile e culturale.
Intensità non significa solo frequenza. È vero, infatti, che la fiction a sfondo ecologico è sempre più diffusa, ma il credito di autori come Margaret Atwood o Jeff VanderMeer non dipende tanto dal successo del tema ambientale che spesso è alla base delle loro opere, quanto dal modo in cui quegli scrittori sono in grado di trattarlo. Per capire la ragione di un tale credito, è utile il ricorso alla categoria di ‘realismo capitalista’, elaborata da Mark Fisher (1968-2017) nel saggio così intitolato (Capitalist Realism, pubblicato nel Regno Unito nel 2009 e uscito in Italia all’inizio del 2018, nella traduzione di Valerio Mattioli). Del libro si è molto parlato, forse perfino troppo; ma è necessario farvi riferimento per i temi in questione, che Fisher affronta direttamente. Per definire l’epoca in cui viviamo, Fisher preferisce al termine ‘postmodernismo’ la formula ‘realismo capitalista’. Che cosa significa quest’espressione? La logica del capitalismo ha imposto un principio di realtà che ci porta a escludere dall’orizzonte delle possibilità tutto ciò che è al di fuori dal capitalismo stesso, dalla meccanica del suo sistema. La sua influenza è così pervasiva che anche molte espressioni dell’immaginario, come film e romanzi, apparentemente critiche rispetto alle derive della società capitalistica, finiscono per confermarne i valori. Così, la soluzione alla crisi viene cercata nei princìpi stessi che l’hanno prodotta. Tra gli esempi che Fisher propone ci sono film e libri ispirati a questioni ecologiche, come il celebre lungometraggio di animazione Wall-E (Disney/Pixar, 2008).

Wall-e.
Il protagonista è un robot-spazzino, abbandonato su una Terra ormai invasa dai rifiuti e disabitata; quel che resta dell’umanità viaggia nello spazio a bordo di un’astronave i cui ospiti vivono in un agio ipertecnologico, che li ha privati di ogni forma di autonomia rendendoli incapaci perfino di camminare. Ma, alla fine, quella stessa tecnologia che ha dapprima sommerso la terra di spazzatura e scorie, e che ha poi reso gli esseri umani disabili e disambientati, risolve tutto ricreando sul pianeta, come per magia, un’atmosfera abitabile. Come la fenice, il capitalismo rinasce dalle proprie ceneri; al di là di questo principio, niente sembra concepibile. «È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo»: questo il titolo del primo capitolo del libro. Sennonché – osserva lo stesso Fisher – la crisi ambientale, il riscaldamento globale e i fenomeni connessi non si risolvono premendo un bottone. Per questo, l’ecologia è la più grande pietra d’inciampo per il realismo capitalista.

Realismo capitalista.
Ora, la letteratura e, in parte, il cinema di fantascienza degli ultimi anni hanno preso coscienza dell’impraticabilità di una soluzione semplicistica e consolatoria. Se un discrimine può esistere tra fantascienza (o fanta-ecologia) ‘alta’ e ‘bassa’, questo va cercato proprio nella possibilità di immaginare sviluppi ed esiti che non tendano alla restaurazione o alla palingenesi, ma all’entropia e all’ibridazione. Due concetti, questi ultimi, che definiscono meglio degli altri la condizione degli ambienti in cui viviamo, e che hanno perciò un valore emblematico: un’ecologia non ideologica si concentra meno sui giardini che non sulle periferie, sugli spazi di soglia.
2. La permeabilità della soglia tra naturale e artificiale è il tema di fondo dell’opera narrativa di Jeff VanderMeer, tra i principali esponenti di un genere, il New Weird, che lo stesso VanderMeer ha contribuito a definire curando, insieme alla moglie Ann Kennedy, editor professionista, una fortunata antologia (New Weird, 2008).

VanderMeer.
Basate su elementi fantasy (come il tema della magia) trasferiti da un medioevo assoluto di ispirazione tolkieniana agli scenari tecnologici della fantascienza, le opere new weird ruotano spesso intorno alla scoperta di creature bizzarre e mostruose (per certi tratti ispirate ai racconti di un precursore come H. P. Lovecraft), la cui stessa natura, sfuggente e complessa, fa assumere alle storie un risvolto straniante.
VanderMeer, nato il Pennsylvania nel 1968, ha raggiunto una fama globale con la Trilogia dell’area X (Southern Reach Trilogy, 2014), pubblicata in Italia da Einaudi nella sua più importante e canonica collana di narrativa, «I Supercoralli».

Trilogia AreaX.
Dalla trilogia è stato tratto anche un film, Annientamento (‘Annihilation’) – diretto da Alex Garland e interpretato tra gli altri da Natalie Portman – che nella maggior parte del mondo è stato distribuito nei primi mesi del 2018 sulla piattaforma di Netflix. La vicenda che si snoda attraverso le tre parti (Annientamento, Autorità, Accettazione) ha origine nella scoperta della misteriosa Area X, teatro d’inquietanti fenomeni; per comprenderne la causa, l’agenzia governativa Southern Reach ha inviato sul posto varie missioni scientifiche, i cui componenti sono scomparsi o morti poco dopo il rientro. Una sorte analoga attende anche le quattro scienziate dell’ultima squadra, che scoprono che l’Area X si sta espandendo, minacciando di assumere proporzioni catastrofiche. L’Area X si comporta come una sorta di iperoggetto: chi è al suo interno, infatti, non è in grado di percepirne l’entità; la sua stessa esistenza è una qualità basata sulla relazione tra esterno e interno, che oltrepassa i limiti tra ciò che è naturale e ciò che non lo è.

Annihilation, locandina.
Il termine ‘iperoggetto’ si riferisce alle teorie di Timothy Morton (Londra, 1968). Morton, esponente della cosiddetta «OOO» (Ontologia orientata agli oggetti, ‘Object Oriented Ontology’), ha dedicato alcuni dei suoi maggiori studi alla presenza dell’ecologia nel pensiero e nell’arte contemporanei. Nella sua teoria, l’iperoggetto (hyperobject) è un’entità plurale, così ampia ed estesa da non poter essere localizzata in uno spazio e in un tempo determinato (Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, 2013). In questo senso, uno degli iperoggetti che più occupa il nostro orizzonte di esperienza è il riscaldamento globale. Non esiste un singolo, preciso fenomeno che possiamo osservare dall’esterno e chiamare ‘riscaldamento globale’. Il processo che va sotto quel nome si manifesta sotto forme molteplici, in tempi diversi, oppure simultaneamente ma in luoghi distinti, e soprattutto ci include e ci condiziona. Non può essere colto sulla stessa scala percettiva di altri eventi, come una qualsiasi manifestazione meteorologica. Non può essere neppure tenuto fuori di noi, perché l’iperoggetto, oltre a essere privo di una determinazione spaziotemporale, attraversa la soglia tra l’individuo e l’ambiente. Per questo, nella teoria di Morton, l’idea stessa di natura come dimensione separata non ha fondamento (di qui il titolo di uno dei suoi saggi più importanti, Ecology without Nature, 2007).

Annihilation, fotogramma.
3. Per certi aspetti la teoria di Morton, nota a VanderMeer (si veda per esempio un articolo del 2015, intitolato The Slow Apocalypse and Fiction), è utile anche per interpretare l’ultimo romanzo dello scrittore americano: Borne (2017), uscito in Italia all’inizio di quest’anno, sempre nei «Supercoralli» Einaudi (nella traduzione di Vincenzo Latronico). Il titolo coincide con il nome della misteriosa creatura trovata dalla protagonista e voce narrante, Rachel, tra le rovine di una città dove ogni spazio è invaso da macerie e rifiuti, masse antifunzionali di residui organici e tecnologici travolti da un’apocalisse ecologica:
Sono nata su un’isola che non cadde per una guerra o un’epidemia ma per l’innalzamento del mare. […] Avevo solo sei anni quando ce ne andammo, imbarcandoci come rifugiati. Me lo ricordo perché i miei genitori me lo raccontavano spesso quando ero più grande. Mi hanno raccontato a lungo quelle storie e noi eravamo sempre rifugiati, passavamo di campo in campo, di stato in stato, pensando di poter fuggire alla disgregazione del mondo. Ma il mondo si stava disgregando quasi dappertutto.
Ho ancora qualche ricordo dei campi. Il fango ovunque, ridotto in poltiglia dall’affollamento, una nube di zanzare così spessa che dovevi tenere la bocca chiusa, il caldo estremo bilanciato, più tardi, da un freddo polare (pp. 42-43).
Quel conglomerato di materia ibrida è il risultato di una civiltà al collasso (non così lontana dalla nostra realtà: guerre e migrazioni come conseguenza di crisi ambientali non sono un’invenzione distopica) basata sull’uso di biotecnologie ormai fuori controllo. Alcune creature, come Mord (una specie di orso dalle dimensioni gigantesche, crudele e vendicativo), si sono ribellate al controllo della Compagnia che le ha prodotte. Wick, che vive al fianco di Rachel, è un creatore di quel genere di organismi, che ancora coltiva in una sorta di vasca-vivaio. Wick alla lettera significa ‘stoppino’; ma più evocativa è la somiglianza con l’aggettivo wicked, ‘maligno’ e insieme ‘favoloso’, come un mago o uno stregone. Del resto, l’antagonista di Wick e Rachel è chiamata ‘la Maga’. Forse non è da escludere neppure una certa prossimità all’aggettivo weak, ‘debole’, quale il personaggio appare rispetto a Rachel. Nelle storie di VanderMeer, in effetti, il ruolo principale e il punto di vista appartengono in prevalenza a figure femminili (così è anche nella Trilogia dell’Area X); non a caso, lo scrittore ha curato, ancora insieme alla moglie Ann, un’antologia di ‘fantascienza femminista’ (Sisters of the Revolution, 2015), da poco pubblicata in italiano con il titolo di Le visionarie. Fantascienza, fantasy e femminismo: un’antologia (edizioni Nero, 2018; si tratta di ventinove racconti, tradotti da autrici italiane coordinate da Claudia Durastanti e Veronica Raimo).

Visionarie.
Quando Rachel trova Borne, «in una plumbea giornata di sole», la creatura le appare di colore «viola scuro, grande più o meno quanto un pugno, abbarbicato alla pelliccia di Mord come un anemone di mare spiaggiato» (p. 5). La sua natura è da subito incerta: appare come un residuo, forse un parassita, ma esercita immediatamente su Rachel un potere evocativo («per un istante sentii che quella cosa che avevo trovato veniva dalle calette sabbiose della mia infanzia», ibid.). In questo senso, Borne è un esempio di quella conversione del rifiuto in feticcio che, come ha spiegato Massimo Fusillo, si osserva spesso nella letteratura postmoderna (Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, il Mulino, Bologna, 2012). Ma l’evoluzione dell’oggetto nel corso del romanzo comporta, nei suoi confronti, anche un ulteriore e più complesso investimento emotivo e assiologico da parte della protagonista. L’attrazione di Rachel nei confronti di Borne è destinata a diventare presto un vero e proprio sentimento materno:
Borne stava anche crescendo. Sì, stava crescendo. Sulle prime non volevo ammetterlo, perché l’idea della crescita implicava quella di un cambiamento più radicale,il pensiero di un bambino che diventa adulto (p. 27).
– Sono come una madre per lui, – dissi pazientemente. – È il mio bambino – (p. 189).
Il nome stesso della creatura richiama l’idea di nascita e gestazione, come la stessa narratrice suggerisce, attraverso una sorta di gioco di parole tra born (‘nato’) e borne (participio passato di to bear, ‘portare’ ma anche ‘partorire’):
Lo chiamai Borne per via di una delle poche cose che Wick mi aveva raccontato del suo periodo alla Compagnia. Ricordando un esserino che aveva creato, aveva detto: «È nato da solo, ma in questo mondo ce l’ho portato io» (p. 20).
Capace di espandersi a dismisura e di assumere forme e sembianze di qualsiasi altro essere, Borne non è né umano né artificiale, né vegetale né animale. In questo senso, per la sua indefinibilità, può essere paragonato a un iperoggetto; ma è soprattutto un’entità transpecifica, metamorfica, che incarna quell’idea di porosità tra la natura e il suo opposto, messa in valore dai recenti sviluppi dell’ecologia letteraria (in particolare, dal cosiddetto material ecocriticism). ‘Incarnare’, d’altra parte, è un verbo che richiama una dimensione religiosa non estranea ai caratteri e alla vicenda della creatura immaginata da VanderMeer; allevato da una ‘madre’ e da un ‘padre’ per i quali si fa anche umano, Borne sembra assumere, sia pure in modo paradossale e weird, un connotato cristologico. La sua missione, l’inveramento stesso della sua natura, si risolvono infatti in un immane sacrificio di sé (to bear vuol dire anche ‘sopportare’) che prelude a una forma di rinascita in cui credere e sperare, quasi come per fede: «Un dubbio latente, un bisogno latente, e credo che almeno questo possiate perdonarmelo» – confessa Rachel, rivolgendosi ai lettori nelle ultime pagine del libro.
Il riscatto ecologico che si profila nel finale può confermare questa lettura. In tal senso, il libro ha un lieto fine, imperfetto ma abbastanza consolatorio. Il rischio di restare intrappolati nel circolo vizioso del realismo capitalista, di ripetere in grande stile l’«effetto Wall-E», viene più che sfiorato. Ma lo scenario immaginato alla fine del romanzo non è una palingenesi, non consiste nel ripristinare uno stato iniziale, per ridare avvio a un processo infinito che faccia credere tollerabile ogni deriva e temporanei i suoi effetti. Quel che il libro di VanderMeer sembra delineare è piuttosto una nuova alleanza tra natura e tecnologia, su cui incide ancora un immaginario sacrale (in particolare, il motivo del diluvio a cui molta letteratura distopica si ispira):
Fuori piovve per tre giorni e tre notti. Già di per sé sarebbe stato strano, un evento, ma quella non era una pioggia normale. Dal cielo caddero creature di ogni sorta, o sbocciarono al suolo al primo tocco di pioggia. L’erba crebbe rapida e selvaggia tutt’intorno alla cisterna, creando sentieri verdeggianti, e notai nuove foglie sui rami anneriti degli alberi morti in fondo alla scarpata. Su certi viali, in città, avrei scoperto in seguito, erano germogliati arbusti e rampicanti spariti da moltissimo tempo. Attraverso la tempesta si udivano i canti lirici degli uccelli, e animali nascosti da anni emergevano dai loro rifugi.
Ma per la maggior parte si trattava di bio-tec, inquietanti. […]
Il terzo giorno il nubifragio terminò, e l’umidità svaporò o fu assorbita dal suolo, e gran parte del verde avvizzì e i nuovi animali morirono o si nascosero o vennero mangiati. A un osservatore arrivato da poco la città sarebbe parsa esplosa e inutile come prima. Ma non lo era. Alcune delle novità erano rimaste, avevano messo radici, erano diventate permanenti. Alcune stavano prosperando. La città era stata ripulita nella misura del possibile, e ciò che le era stato tolto non era meno importante delle aggiunte. […]
Ma ora posso passeggiare per un viale punteggiato di alberelli, fare provviste a un mercato allestito sotto un tendone di fortuna in cui la gente ha ricominciato a barattare. Posso farlo, anche se ci sono ancora parti della città in cui non metterei piede perché ci si annida troppa violenza. A volte, nella zona dell’osservatorio, vediamo pulsare delle luci, e alcune sono elettriche, un pezzo del vecchio mondo che torna. I pozzi vengono ripuliti e filtrati, o ne vengono scavati di nuovi, e intere comunità vi crescono attorno. Si piantano verdure. Si vocifera di un frutteto (pp. 332-335).
Anche Borne, in fondo, si conclude con un’ecotopia, ma a generarla non è una fuga nell’idillio, né l’ingenuo ottimismo delle controculture. È un’ecotopia che non produce uno scenario edenico, che, come in sogno, riporti cioè l’umanità (o una sua parte) a vivere nella condizione precedente alla caduta. Al contrario, qui il disastro è avvenuto ed è irreversibile; niente è come prima, niente è puro. Non si celebra la vittoria della Natura, ma la fusione di diverse nature.