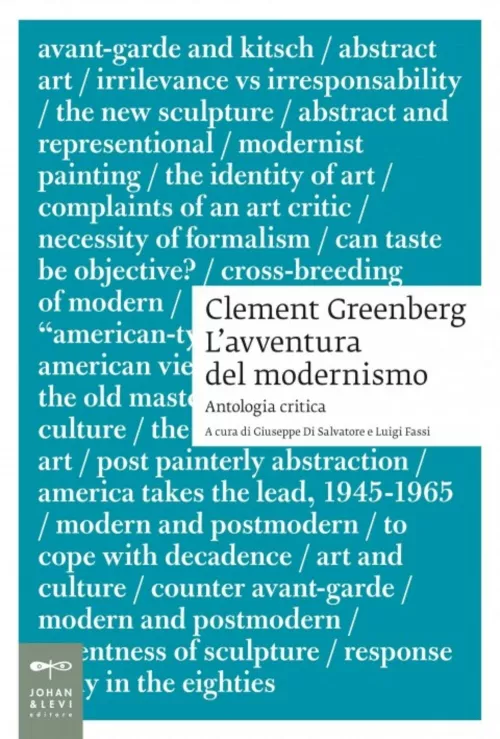Greenberg for Italians
Non esiterei un istante a considerare l’antologia italiana degli scritti del critico americano Clement Greenberg (L’avventura del modernismo. Antologia critica, Johan & Levi, Milano 2011, pp. 448, € 35) come uno dei maggiori eventi editoriali dell’anno. I curatori Giuseppe Di Salvatore e Luigi Fassi hanno pazientemente lavorato su un corpus di oltre 1.500 pagine, riuscendo nella sfida di offrire al lettore italiano una panoramica esaustiva del pensiero di Greenberg dal 1939 al 1986. In senso più ampio, l’antologia della Johan & Levi è da oggi lo strumento imprescindibile per comprendere il modernismo americano, in Italia conosciuto quasi esclusivamente attraverso il riflesso, a volte distorto dalla partigianeria critica, offerto dall’allieva più brillante, impaziente e ingrata di Greenberg, Rosalind E. Krauss, dato che, per una congiuntura editoriale anomala rispetto ad altri paesi europei, i lettori italiani, soprattutto i più giovani, hanno conosciuto Greenberg proprio attraverso Krauss & Co.
L’avventura del modernismo è ordinato secondo un criterio cronologico e tematico. Le prime tre sezioni corrispondono a grandi aree quali “Posizioni teoriche”, “Greenberg critico dell’arte moderna”, “Analisi sociale e contesto culturale”. L’ultima è cronologica e circoscrive la produzione degli ultimi vent’anni d’attività di Greenberg, quando, tramontata l’età dell’oro della scuola di New York, puntualizza le proprie posizioni, conosce un’apertura teorica e gioca sulla difensiva rispetto al postmodernismo e agli artisti esclusi dal suo canone modernista (ad esempio Malevic, Duchamp, i surrealisti e i minimalisti). I temi toccati dai quasi settanta testi dell’antologia sono troppo ricchi per passarli in rassegna in questa sede. Nell’insieme tratteggiano una delle narrazioni più organiche, coerenti e persistenti della pittura del XX secolo: l’influenza di Cézanne, dell’ultimo Monet e della pittura cubista sull’astrazione americana; la graduale conquista della planeità della superficie pittorica; la crisi della pittura da cavalletto, accolta da Greenberg prima con entusiasmo, poi con timore; il declino della scuola di Parigi e l’affermarsi dell’espressionismo astratto; la pittura color-field in quanto apice del modernismo e così via.
C’è tuttavia una domanda su cui credo valga la pena di soffermarsi, resa urgente da questa pubblicazione e accennata nell’introduzione dei curatori come in quella di Caroline Jones, curiosamente intitolata Greenberg for Italians: cosa vuol dire leggere Greenberg nel 2011 in Italia? nello specifico, perché Greenberg non ha mai costituito un referente per gli artisti, gli storici, i critici e i teorici dell’arte contemporanea italiani? a cosa è dovuta la sua assenza dal nostro dibattito culturale? mera disinformazione? un buco nero nel Piano Marshall? o che tra Greenberg e l’Italia vi sia stato in finale, azzardo in anticipo la mia ipotesi, un pervicace disinteresse reciproco?
L’Italia guarda Greenberg
Partiamo dall’attenzione dell’Italia verso Greenberg, che è una semina irregolare in un terreno accidentato. Pare che Ignazio Silone avesse tradotto “Avanguardia e Kitsch” (1939); bisogna però attendere fino al 1960 perché un saggio di Greenberg sia pubblicato in italiano (Saggio su Klee [1950], Il Saggiatore 1960), affiancato dal classico Teatro delle marionette di Heinrich von Kleist. Nel 1968 è la volta di un estratto di “Avanguardia e Kitsch, incluso da Gillo Dorfles nella sua fortunata antologia Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto (Mazzotta). L’insistenza sul kitsch metteva però in ombra la problematica articolazione con l’avanguardia. In sintesi, l’avanguardia voleva risolvere una volta per tutte i problemi lasciati irrisolti dagli artisti delle generazioni precedenti. Greenberg invece, per salvare la cultura alta dalle sabbie mobili del kitsch, insiste sul valore culturale della continuità col passato e, con una mossa abilissima, finisce per identificare l’avanguardia con la tradizione, o meglio col formalismo e col modernismo. L’avanguardia assume così un ruolo conservatore, ovvero l’esatto contrario di quanto perseguiva con tutti i mezzi e tutte le forze. Pochi anni dopo è la volta di un testo italiano di diverso tenore, la prefazione a India antica di Maurizio Taddei (Mondadori, 1972). Paul Klee, il Kitsch, la scultura devozionale indiana: un tipo eclettico questo Greenberg, dovevano pensare i suoi primi lettori italiani.
Nel 1988 compaiono finalmente quattro articoli fondamentali – “La crisi della pittura da cavalletto”, “Paralleli bizantini”, “Sul ruolo della natura nella pittura moderna” e “Pittura ‘di tipo americano’” – nei Quaderni della Foundation for Improving Understanding of the Arts (Jaca Book), fondata nel 1980 e dedita alla promozione dell’opera di William Congdon, pittore americano trasferitosi in Italia nel 1948 e convertitosi al cattolicesimo una decina d’anni dopo. Nessuno sembra accorgersene, al punto che questa pubblicazione non viene citata né nella successiva edizione italiana di Arte e Cultura né in L’avventura del modernismo. Eppure l’introduzione di Rodolfo Balzarotti è, se non vado errato, il primo testo critico italiano su Greenberg. Le intuizioni non mancano: la simbiosi tra lo storico dell’arte e il critico militante; il suo debito verso il puro visibilismo riguardo all’autonomia della sfera estetica e alla contrapposizione tra ‘ottico’ e ‘tattile’; la teoria ciclica degli stili ripresa da Wölfflin e Roger Fry. S’intravede inoltre un’idea che oggi va per la maggiore: la millenaria tradizione europea come “costante punto di riferimento” dell’arte contemporanea; il formalismo come via maestra per comprendere l’arte americana nel quadro della nostra tradizione artistica.
Balzarotti sosteneva infine che l’arte di James Turrell (intervistato nello stesso volume), Dan Flavin e Robert Irwin, nella loro tendenza a uscire dai confini ben delimitati della pittura da cavalletto “getta una nuova luce sull’opera di autori come Pollock, Barnett-Newman [sic] e Rothko”. Si tratta di uno spunto critico prezioso, sviluppato tra gli altri da Michael Auping. Ma sostenere, come prosegue Balzarotti, che tale sguardo retrospettivo “rende parimenti giustizia al rigore e all’acume delle analisi di Greenberg” era inesatto. Di più, era un vero e proprio fendente nel ventre del critico americano il quale, fedele al suo modernismo ortodosso che non si spingeva oltre la color-field painting, puntava i piedi davanti alla pittura di Frank Stella e di Jasper Johns per non parlare dei minimalisti. Figuriamoci davanti a Turrell, Flavin e Irwin, portatori di una visione diabolica – cioè non modernista – della crisi della pittura da cavalletto. Per rendersene conto basta leggere Le monochrome et la toile vierge di Thierry de Duve, uno straordinario lavoro di scavo dei paradossi del modernismo di Greenberg pubblicato nel 1989, un anno dopo l’edizione della Jaca Book purtroppo risucchiata troppo presto nel buco nero dell’editoria italiana.
Il 1991 è l’annus mirabilis per la fortuna di Greenberg nel nostro paese: Arte e Cultura – uno dei classici della storia dell’arte del XX secolo – viene tradotto da Allemandi. Nell’introduzione laconica Gillo Dorfles insiste quasi esclusivamente su “Avanguardia e Kitsch”, già incluso nella sua antologia. Riguardo alle 220 pagine che lo seguono, Dorfles ha solo incisi, come dire, organolettici: “pasto particolarmente prelibato”, “breve ma non meno gustoso”, “straordinaria lucidità e freschezza”, “giudizi equilibrati e pregnanti”, “squisita capacità esegetica” – manca solo “buon appetito”. Ma a mancare è soprattutto il termine che fa da pietra angolare all’architettura del libro, “modernismo”, e che forse in quegli anni avrebbe fatto scattare diverse molle concettuali, ad esempio, è solo un’ipotesi, una rilettura di Arte e Cultura dirimpetto alla vague postmodernista. Seguono vent’anni di solitudine prima di ritrovare “Avanguardia e Kitsch” e il fondamentale “Pittura modernista”, ben contestualizzati nell’antologia di Giuseppe di Giacomo e Claudio Zambianchi (All’origine dell’arte contemporanea, Laterza 2008). Ed eccoci infine a L’avventura del modernismo.

Greenberg guarda l’Italia
Invertiamo i termini del rapporto. Cosa dire delle conoscenze italiane di Greenberg? Il 20 aprile 1939 s’imbarca per la prima volta per l’Europa, dove resterà fino al 6 giugno. Su suggerimento di Dwight MacDonald, direttore della Partisan Review, intervista nel suo francese stentato Ignazio Silone, allora in esilio a Zurigo. Visita la Cappella Sistina – “Raffaella [sic] – Il Parnaso”, si legge in una cartolina dalla Città del Vaticano datata 22 maggio 1939, lo stesso giorno in cui viene siglato il patto d’acciaio tra l’Italia fascista e la Germania nazista. Su insistenza della sua compagna, l’artista Helen Frankenthaler, nel 1954 trascorre due mesi e mezzo in Europa (Spagna, Francia, Svizzera, Italia). A Firenze visitano i musei della città ma Giotto e Piero della Francesca gli sembrano “over-rated”, sopravvalutati rispetto ai veri maestri: Tiziano, Rubens, Velázquez e Rembrandt. Di passaggio a Ravenna, l’autore di “Paralleli bizantini” manca di vedere i mosaici. Tra gli incontri decisivi non si annovera alcun italiano: ai Tatti incontra Bernard Berenson; nonostante la distanza siderale tra le loro opinioni sull’arte contemporanea, Greenberg stimava l’occhio di Berenson e l’attenzione verso la qualità delle opere d’arte, piatto forte della connoisseurship. Venezia è un altro luogo di incontri poco italici: Peggy Guggenheim e i dipinti di de Kooning alla Biennale.
Non saprei dire se Greenberg abbia incontrato un “clandestino” (come lo chiama Aldo Tagliaferri) quale Emilio Villa, che si occupava degli stessi artisti americani che interessavano a Greenberg. Siamo comunque agli antipodi del tour francese, se pensiamo che nel 1939 Greenberg incontra Jean Arp, Hans Bellmer, Man Ray, Paul Eluard, Georges Hugnet, Virgil Thompson e Jean-Paul Sartre (che aveva appena pubblicato La nausea), con cui discetta sul valore letterario di Faulkner e Dos Passos.
Sul piano dei debiti intellettuali, ho l’impressione che Benedetto Croce non abbia giocato un ruolo determinante nella formazione intellettuale di Greenberg e che acquisti importanza soprattutto negli ultimi scritti. Bisogna aspettare il 1971 per leggere che Croce è lo studioso d’estetica che Greenberg ammira di più dopo Kant (lo si legge nella sua raccolta di scritti più ambiziosi da un punto di vista teorico, stranamente non considerata dai curatori dell’antologia italiana: Homemade Esthetics. Observations on Art and Taste, Oxford UP 1999). Nelle recensioni alle opere di Lionello Venturi traspare una stima intellettuale piuttosto che un vero e proprio debito. E, ad ogni modo, Greenberg legge Venturi perché Venturi s’interessa all’arte del XIX secolo e all’impressionismo, non perché è a capo della via italiana all’astrazione con il Gruppo degli Otto, e ancora meno perché Greenberg si appassiona al destino dell’estetica crociana nel dopoguerra. Le recensioni ai libri di Venturi sono inoltre piene di riserve, non ultima “the professor’s elliptical concept-juggling prose, so much in the tradition of philosophical idealism” (1947). Quando Venturi si avventura nel XX secolo – cioè quando gioca sullo stesso terreno di Greenberg – questi non manca di dargli il benservito, come nel caso di Chagall: il critico italiano “ha scritto troppo spesso su di lui ma mai in modo sufficientemente critico” (1957), e quello che dice è arbitrario. Da quando l’arte ha smesso di essere impressionista Venturi non è a suo agio, al punto da mostrare “un’ostilità inconfessata o inconscia” (1945) verso gran parte dell’arte contemporanea.
Per semplificare, ho l’impressione che Greenberg recensisca Venturi ma s’interessi a Berenson; intervisti Silone ma sia influenzato da Brecht; citi di sfuggita Croce ma legga approfonditamente Kant e Wölfflin. La magra lista di contatti italiani si chiude con il critico letterario Paolo Milano di stanza a New York, un’amicizia non ascrivibile nel quadro più ampio dei rapporti culturali tra Greenberg e l’Italia. Milano era, se non semplicemente l’“amico italiano” – ogni newyorchese che si rispetti ne ha uno, come il “compagno etiope” in Ecce bombo –, un interlocutore prezioso per avere qualche ragguaglio sul dibattito culturale italiano.
Senza appello, infine, le perplessità di Greenberg sull’arte italiana del XX secolo. Il Futurismo è un movimento accademico; Marinetti, Severini e Balla non hanno colto quello che è successo nell’arte a partire da Courbet, fatta eccezione per un paio di Carrà, riusciti “only by accident” (1948). Non solo Sironi, Garbari, Guidi, Marussig, de Pisis ma persino Giorgio Morandi – incarnazione della via italiana al modernismo – “fanno poco più che ripetere timidamente la pittura francese pre-cubista” (1948). Giorgio de Chirico fa mostra di un’“ostilità logica a tutta la pittura realmente moderna sin da Courbet”; come colorista è “trecento anni in ritardo rispetto a Delacroix” (1947); allestisce “una parodia della composizione rinascimentale” (1943) ma è incapace di trovare qualcosa che sostituisca i resti del Rinascimento che lui stesso ha mandato in frantumi; la sua non è propriamente una pittura da cavalletto ma un “elementary interior decoration”. Colpo di grazia: alla fine degli anni quaranta, nello sforzo di “stay modern”, gli artisti italiani hanno ripiegato su una sorta di “archeologia espressionista”. Siamo distanti anni luce dagli standard del modernismo americano. Così quando Greenberg incontra Piero Dorazio – un artista che stima e che è stato a mio avviso l’italiano più vicino al critico – lo esorta a restare negli Stati Uniti, cioè là dove si giocava veramente il destino del Modernismo.

Greenberg, Italia 2011
L’assenza di Greenberg dal panorama storico-critico italiano è un soggetto appassionante che resta da indagare. Prima o poi qualcuno scriverà qualcosa tipo “Le fonti italiane di Greenberg”, sebbene temo che non sarà nutrito come “Le fonti dell’estetica tedesca di Greenberg” o “Le fonti ebraiche di Greenberg”. E le ragioni culturali del disinteresse reciproco tra Greenberg e l’Italia non sono riducibili alla situazione autarchica del mercato editoriale italiano verso gli autori transatlantici. Autarchica perché abbiamo letto l’opera omnia della Krauss prima di capire, grazie a L’avventura del modernismo, contro cosa polemizzava l’autrice; perché mostri sacri come Leo Steinberg, Michael Fried e Jonathan Crary sono tenuti ancora al confino mentre si possono leggere Barbara Rose e Robert Storr; perché Harold Rosenberg, con la sua prosa esistenzialista, ha circolato solo in quanto ha avuto la fortuna di trovare un’amica e una traduttrice d’eccezione in Gabriella Drudi; perché Meyer Schapiro ha conosciuto un revival nella veste di semiotico della pittura, dismessa quella più scomoda di marxista; perché di Alfred Barr è spuntata una biografia ma mancano i suoi testi, ecc.
Forse l’Italia ha preferito la strada francofortese, Adorno in particolare. Come scriveva Renato Solmi introducendo nel 1954 l’edizione italiana di Minima Moralia, e che era in realtà un’introduzione al pensiero di Adorno tout court: “Mi rendo benissimo conto che molte delle tesi di Adorno potranno sembrare, a un lettore italiano, paradossali e arbitrarie. E questa impressione sarà, almeno in parte, giustificata. Il mondo che Adorno ci descrive è la moderna società americana”. Se Adorno ci apriva le porte dell’America, che bisogno c’era di leggere Greenberg oltre ad “Avanguardia e Kitsch”, non a caso il più adorniano tra i suoi scritti? È solo una pista, e mi auguro di leggerne presto delle altre più convincenti.
Resta il fatto che, per tirare crudamente le somme, l’Italia è stata per Greenberg un interlocutore secondario. Pensiamo ancora alla Francia: Greenberg, lettore avido dei Cahiers d’art, misura l’emergere, l’affermarsi e l’egemonia del modernismo americano in rapporto all’Ecole de Paris. È per questo che la storia e la critica dell’arte francesi hanno sempre manifestato un’attenzione morbosa nei riguardi del modernismo greenberghiano. Questa era dettata, se non altro, dalla necessità di difendere, ribattere e proporre narrazioni alternative a quella che smantellava l’illusione della centralità artistica di Parigi nel dopoguerra a favore di New York. Dell’Italia, invece, Greenberg ebbe sempre un’immagine di rimbalzo, quasi da Guide bleu: a Roma nel 1954 si affida al city tour dell’American Express, che lo porta al Vaticano e a Fontana di Trevi, in cui getta qualche monetina per essere sicuro di ritornare (come accadrà per due settimane nel 1965). A Napoli si lamenta dei “creepy, starving, make-a-lire Neapolitans”: non ricorda lo sguardo annoiato e impermeabile alla città dell’inglese in affari interpretato da George Sanders in Viaggio in Italia, che Roberto Rossellini gira l’anno precedente la discesa greenberghiana negli inferi partenopei?
“Greenberg for Italians”: nel titolo ottimista dell’introduzione di Caroline Jones non posso fare a meno di sentir risuonare il titolo di una collana americana pop di guide divulgative (tra i titoli con la A: Acoustic Guitar Songs for Dummies; African American History for Dummies; Alaska for Dummies; Alzheimer for Dummies; Anger Management for Dummies; Anti-inflammation Diet for Dummies; Arabic Phrases for Dummies). Come recita lo slogan della collana: “A Reference for the Rest of Us”. Il paragone, ne sono convinto, è involontario. Ma sono convinto che un “Greenberg per Italiani”, una “Reference for the Rest of Us”, debba ancora nascere. Lo stesso vale per un ipotetico “Italiano per Greenberg”. Nella cartolina spedita a Harold Lazarus il 18 maggio 1939 si legge: “Sous in Italia! I genti parlano molte come gl’American”. Altrove confessa: “In Italia me la cavo nei distributori di benzina e nei ristoranti, ma non sono in grado di sostenere una conversazione”. Il mio miglior augurio è che l’indispensabile antologia della Johan & Levi riesca a far uscire Greenberg dal ristorante italiano, a togliergli da sotto il palato gli “squisiti pasti prelibati” e a indurci finalmente a intavolare con il grande critico americano una conversazione, per quanto difficoltosa. Ognuno nella sua lingua.
Questa recensione è apparsa, in versione ridotta, su «Alfabeta2».