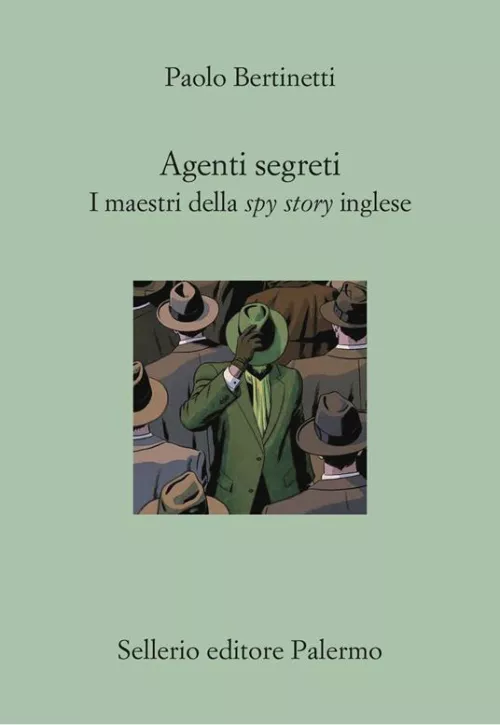Kipling, Conrad, Greene, Le Carré e altre spie
Perché il tema dello spionaggio dovrebbe interessarci e coinvolgerci? Perché ha a che fare con il potere, con l’attività politica vera, oltre il velo della retorica e della demagogia, ha a che fare con i migliori principi civili e con i peggiori interessi che spingono gli esseri umani ad agire, e a volte a morire.
Paolo Bertinetti ha dedicato al rapporto tra spionaggio e letteratura un libro notevole, Agenti segreti. I maestri della spy story inglese, uscito in prima edizione nel 2015 e da poco ripreso, ampliato e aggiornato, da Sellerio in una elegante edizione in piccolo formato. Bertinetti, da molti anni professore ordinario di Lingua e letteratura inglese, ha pubblicato nel corso degli anni importanti saggi sul romanzo e sul teatro britannici, e curato le ultime edizioni dei romanzi di John le Carré e il Meridiano Mondadori che raccoglie le opere di Graham Greene. In questo saggio racconta gli intrecci tra letteratura e spionaggio dalla fine dell’Ottocento a oggi con chiarezza e fluidità, con precisione e senza inutili tecnicismi e sovraccarichi di note. Leggendo questo libro si resta affascinati dalla descrizione delle affinità e differenze tra gli autori di spy story, e si scopre che molti di loro hanno lavorato per brevi o lunghi periodi nei servizi segreti, ad esempio William Somerset Maugham, Graham Greene, Ian Fleming, Len Deighton, John Le Carré. Bertinetti ricorda inoltre Daniel Defoe, anch’egli un agente segreto, e la prima trama spionistica mai pubblicata (1821), La spia di James Fenimore Cooper, l’autore di L’ultimo dei mohicani: non si ferma ad approfondirli perché Defoe non ha mai scritto un romanzo di spionaggio e Cooper era americano, non inglese.
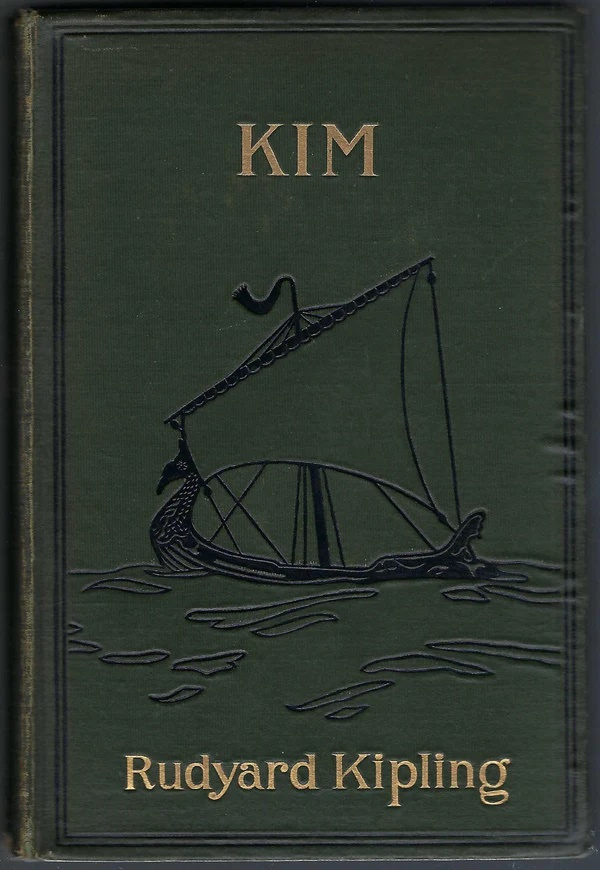
Tutto ha inizio con il Grande gioco, così venne definito il conflitto, caratterizzato da attività diplomatica, spionistica e di sabotaggio, tra Regno Unito e Russia nel corso dell’Ottocento nell’Asia centrale, soprattutto in Afghanistan. Il primo grande libro che Bertinetti prende in esame è Kim di Kipling, una storia di viaggio e di iniziazione alla vita adulta, ambientata proprio negli anni del Grande gioco e proprio in Afghanistan.
Kim, diminutivo di Kimball, un ragazzino figlio di un sergente dell’esercito inglese e di una bambinaia indiana, viene arruolato per una missione di spionaggio da Mahbub Alì, un pashtun che commercia in cavalli, ma è anche una spia al servizio degli inglesi. E così, Kim entra anche lui nel Grande gioco, dimostrando coraggio e astuzia.
Poco più di dieci dopo la pubblicazione del libro, Harold Adrian Russell Philby, nato ad Ambala in India nel 1912, venne soprannominato Kim da suo padre, ammiratore di Kipling, e per tutta la vita sarà conosciuto come Kim Philby, la più famosa spia doppiogiochista del Novecento: per anni ai vertici del Servizio segreto inglese, ma da sempre una spia sovietica che danneggerà pesantemente gli interessi britannici e occidentali.
Bertinetti passa poi a raccontare un altro autore, noto quanto Kipling ma conosciuto soprattutto per le crime story dominate dalla figura di Sherlock Holmes: Arthur Conan Doyle. In realtà, sin dai primi racconti, Conan Doyle tratta il tema dello spionaggio. IN Il trattato navale del 1894 Holmes è impegnato in un servizio di controspionaggio su suolo inglese, contro agenti russi e francesi.
E nel 1917, in quella che doveva essere l’ultima raccolta di racconti con protagonista Holmes (ma così non fu per le proteste dei lettori), una delle brevi storie, intitolata L’ultimo saluto, vede Holmes svolgere con efficacia il ruolo di double agent – il primo nella letteratura di spionaggio – fornendo per due anni informazioni false alla Germania e facendo arrestare un loro pericoloso agente. Un racconto che voleva essere anche un contributo alla guerra in corso, e che si chiude con il patriottico auspicio che Holmes rivolge a Watson: “…quando la tempesta finirà, la luce del sole splenderà su una terra migliore, più pulita e più forte”.
Nel Regno Unito letteratura e storia procedono come binari paralleli riguardo l’attività spionistica. Risale al 1887 la creazione della prima istituzione pubblica preposta allo spionaggio, il Naval Intelligence Department, ma l’anno decisivo è il 1909, quando viene creato il Secret Service Bureau, composto da Secret Intelligence Service, comunemente noto come MI5 (Military Intelligence, Section 5), legato all’Esercito e con compiti di controspionaggio, e MI6 legato alla Marina (agli inizi del secolo il pericolo maggiore era rappresentato dalla Marina Imperiale tedesca).
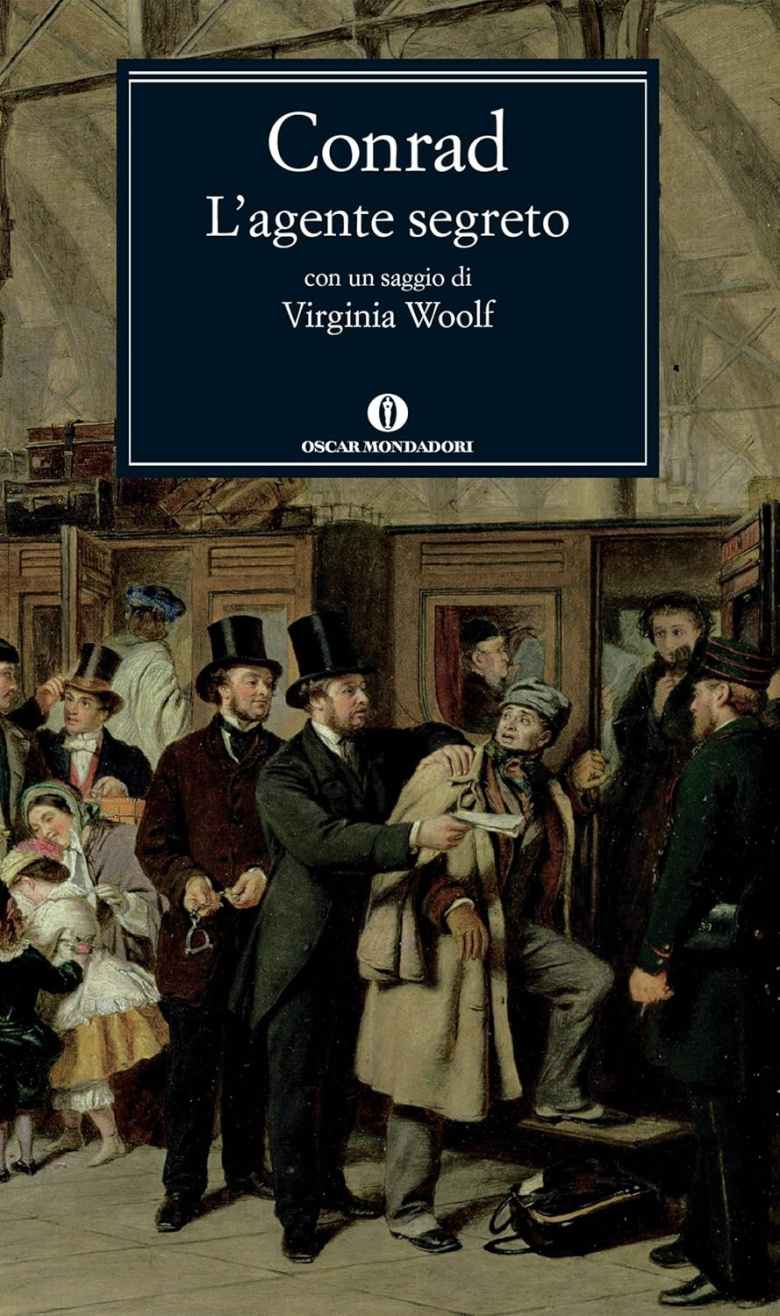
Ai primi del Novecento, il capolavoro letterario nell’ambito trattato da Bertinetti è L’agente segreto (1907) di Joseph Conrad, un’opera cupa, diversa dalle storie di mare che hanno reso famoso lo scrittore anglo-polacco, che anticipa drammaticamente gli orrori del Novecento: gli attacchi delle grandi potenze dittatoriali alle democrazie dell’Occidente, la lunga stagione del terrorismo, la strategia degli attentati da addebitare ad altri. Il libro si ispira a un attentato davvero avvenuto, nel 1894, contro l’Osservatorio astronomico di Greenwich, ad opera di un agente provocatore di una potenza straniera. Da questo episodio prende spunto la vicenda narrata da Conrad, con l’ideazione da parte di una centrale spionistica straniera (probabilmente russa), di un attentato dinamitardo contro quel simbolo della scienza e del progresso. Lo scopo è di far ricadere la colpa sugli anarchici rivoluzionari, così da spingere i governanti inglesi a rendere più dura la loro legislazione, troppo attenta alla tutela dei diritti individuali, anche verso i rifugiati stranieri. “La clemenza della magistratura inglese e l’assenza completa di misure d’ordine repressivo sono uno scandalo per tutta l’Europa”, così declama il consigliere d’ambasciata Vladimir mentre commissiona l’atto criminale all’agente doppiogiochista Verloc.
Conrad sa di cosa parla: la sua patria d’origine, la Polonia, è oppressa da più di un secolo da due stati totalitari, l’Impero germanico e la Russia zarista (migliore la situazione nella parte di Polonia occupata dall’Impero austro-ungarico), e della sua patria d’adozione, il Regno Unito ama soprattutto il rispetto delle libertà e delle regole democratiche.
Dura anche la descrizione dei rivoluzionari: privi di vera empatia verso le genti che vorrebbero liberare, pronti a uccidere senza remore morali, dominati da una spropositata auto considerazione.
Al centro del romanzo Verloc e la moglie Winnie, personaggi senza particolari qualità, che finiranno stritolati negli ingranaggi di una vicenda molto più grande di loro.
Tra gli autori immediatamente successivi, è opportuno ricordare qui almeno William Somerset Maugham. Già negli anni Venti era uno scrittore affermato e non legato ad alcun genere (Schiavo d’amore è del 1915), con importanti esperienze diplomatico-spionistiche durante la Grande Guerra, compreso un viaggio in Russia nel 1917 per tenere i contatti tra il capo del governo russo Kerenskij e quello inglese Lloyd George, in vista di un disperato tentativo di rinforzare militarmente il primo. Maugham entra nelle spy story nel 1928, con Ashenden o L’agente Inglese, e fa subito centro: il libro è una raccolta di racconti così realistici da spingere Winston Churchill, che aveva letto i manoscritti, a bloccare la pubblicazione di 14 di essi. La vita degli agenti segreti, tra frustrazioni ed errori, è raccontata con estremo e innovativo realismo.
Devono molto a Joseph Conrad i due maggiori scrittori inglesi di spy story del ‘900, Graham Greene e John le Carré.
Greene lo ricorda spesso nelle lettere (A life in letters, Alfred A. Knopf, 2007), nel 1935 viaggia in Africa con Cuore di tenebra in valigia, si ispira a Conrad in alcuni romanzi e racconti, e quando viene anche per lui il tempo di una biografia, lascia che la scriva Norman Sherry, uno dei biografi dello scrittore anglo-polacco.
Le Carré condivide con Conrad lo sguardo lucido e disincantato, il pessimismo di chi vede l’oscurità e le tempeste, ma sceglie comunque di battersi, e ne fa lo scopo della propria vita. Come il capitano MacWhirr di Tifone: “Un uragano è un uragano, signor Jukes, e un piroscafo nella pienezza dei suoi mezzi deve affrontarlo. C’è una certa quantità di cattivo tempo in giro per il mondo, e non di più; è giusto passarci attraverso”. Il canto della missione, un romanzo di le Carré ambientato in Africa, tra sfruttamento post coloniale e guerre civili, porta in epigrafe una citazione da Cuore di tenebra di Conrad: “La conquista della terra, che sostanzialmente consiste nello strapparla a quelli che hanno la pelle diversa dalla nostra o il naso leggermente più schiacciato, non è una cosa tanto bella da vedere, quando la si guarda troppo da vicino”.
Nei maggiori romanzi di Greene domina il tema dell’individuo stretto tra la fedeltà al proprio Paese e quella ai propri valori individuali, ai propri affetti; soprattutto in Il terzo uomo, Fine di una storia, Il console onorario, Il fattore umano. E il dovere di non cedere mai al diritto-dovere di critica anche verso la parte giusta, o meno sbagliata, dei conflitti. Quando si accettano crimini o nefandezze in nome di una guerra da vincere a tutti i costi, quando si perdono di vista i principi per i quali si era iniziato a lottare, si rischia di non distinguere più il confine tra bene e male, giusto e sbagliato.
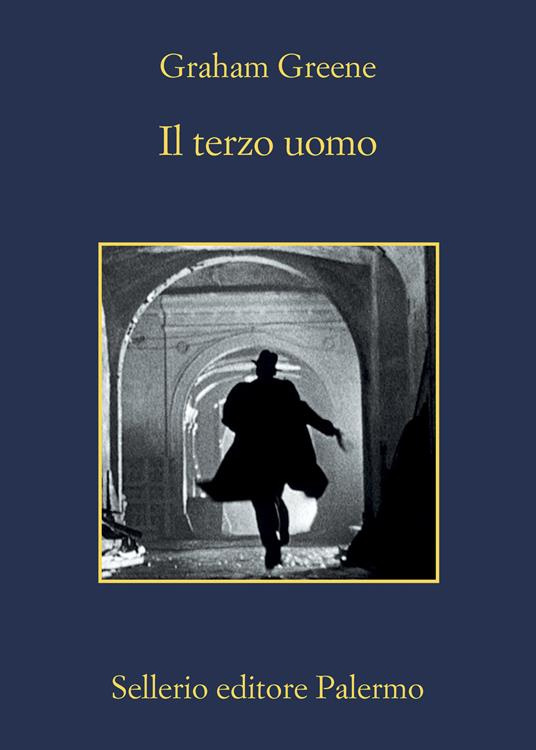
Più solide, dal punto di vista della credibilità spionistica, le trame di Le Carré, che descrive senza indulgenze un mondo avvelenato dal cinismo e da una guerra sotterranea priva di regole d’onore e di umanità. Nonostante tutto, l’etica dei protagonisti delle sue storie – Smiley ad esempio, nella Talpa, o Quayle, nel Giardiniere tenace – è sorretta da una disillusa determinazione. Le Carré è più oggettivo di Greene anche nel giudizio su Philby: Greene è più indulgente, scriverà anche la prefazione a un libro di memorie del traditore; le Carré rifiuterà sempre qualsiasi contatto, giudicandolo un criminale con tante morti e tanti danni irreparabili sulla coscienza. Greene ha qualche speranza, e anche un afflato religioso; in le Carré, come accennavo prima, c’è invece un combattivo pessimismo che ricorda quello di Conrad: la lotta usque ad finem contro il male non è solo un modo di affrontarlo, diventa anche un fine che dà senso alla vita dei suoi personaggi, alla vita di tutti noi. Le Carré lotterà anche in prima persona, battendosi contro la demagogia e le fake news che porteranno i suoi concittadini a farsi abbindolare scegliendo la catastrofica Brexit. Non si rassegnerà alla sconfitta e chiederà la cittadinanza irlandese, ottenendola poco prima della sua morte, ritornando così, almeno come singolo individuo, nell’amata Europa.
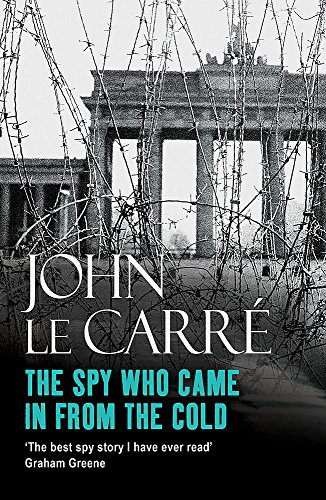
Quando nel 1963 esce il suo La spia che venne dal freddo, Graham Greene lo definì “il miglior romanzo di spionaggio che avesse mai letto”, nel 1986 Philip Roth giudicò La spia perfetta il più bel romanzo inglese degli ultimi quarant’anni, infine, Ian McEwan, in occasione della pubblicazione nel 2013 di Una verità delicata, uno degli ultimi romanzi di le Carré, dichiarò che il suo autore era “il più importante romanziere inglese della seconda metà del Novecento”. Al di là di questi entusiasmi un po' eclatanti ma comunque motivati, si tratta di opere ben scritte, che affrontano aspetti cruciali della nostra esistenza, che aiutano a comprendere il presente e a intravedere il futuro. Non è poco per delle spy story.
Greene e le Carré hanno in comune anche l’interesse del cinema nei confronti delle loro storie, con esiti discontinui per Greene: ottimo Il terzo uomo (ma scrisse prima il soggetto cinematografico, il romanzo dopo la realizzazione del film), buono Fine di una storia, modesto Il fattore umano. Più fortunate le trasposizioni cinematografiche dei romanzi di le Carré, da La spia che venne dal freddo al duro e malinconico La spia – A most wanted man. Un dolente Philippe Seymour Hoffman, nella sua ultima apparizione cinematografica, riuscì a raffigurare in modo magistrale il dolore trattenuto, la rabbia e la solitudine del protagonista.
Oltre agli scrittori sin qui ricordati, nel libro di Bertinetti vengono esaminati anche altri autori di opere interessanti ma di minore qualità letteraria, come Eric Ambler (Il caso Schirmer), Ian Fleming (la saga dell’agente 007), Len Deighton (La pratica Ipcress), Ken Follett (La cruna dell’ago), Frederick Forsyth (Il giorno dello sciacallo, Dossier Odessa). I più credibili sono indubbiamente Ambler, il primo ad avvicinare le spy story alla realtà, e Forsyth, che proviene dal giornalismo d’inchiesta in giro per il mondo, il meno attendibile Fleming, ma tutti hanno in comune il tema dello spionaggio, della guerra sotterranea tra Paesi o delle velleità criminali di singoli individui particolarmente ricchi, potenti e pericolosi. Per molti anni si è pensato che i rischi provenienti dai secondi fossero poco credibili, adesso forse non è più così.
Un autore e un personaggio che avrebbero potuto essere aggiunti in questo libro? Forse Robert Louis Stevenson e Alan Breck Stewart, il coraggioso avventuriero che affianca e protegge David Balfour, il protagonista di Il ragazzo rapito, a bordo di un veliero prima, nella brughiera scozzese poi. In missione segreta in Scozia, travestito da soldato francese, Alan agisce per conto degli Stuart, i reali scozzesi da anni esiliati in Francia, ed è il compagno di avventure che ogni ragazzo vorrebbe avere.
Dispiace che il prezioso libro di Paolo Bertinetti sia stato sostanzialmente ignorato dalle riviste di cultura più diffuse nel nostro Paese.
Attraverso il filtro della letteratura, Agenti segreti parla di problemi e pericoli reali, di valori importanti, come la dignità umana e la libertà, che confliggono con il conformismo e la demagogia dilaganti. Non è un libro salvifico, ma aiuta a non arrendersi di fronte alle oscurità della storia, a certe infelici decrescite della cultura e della democrazia.