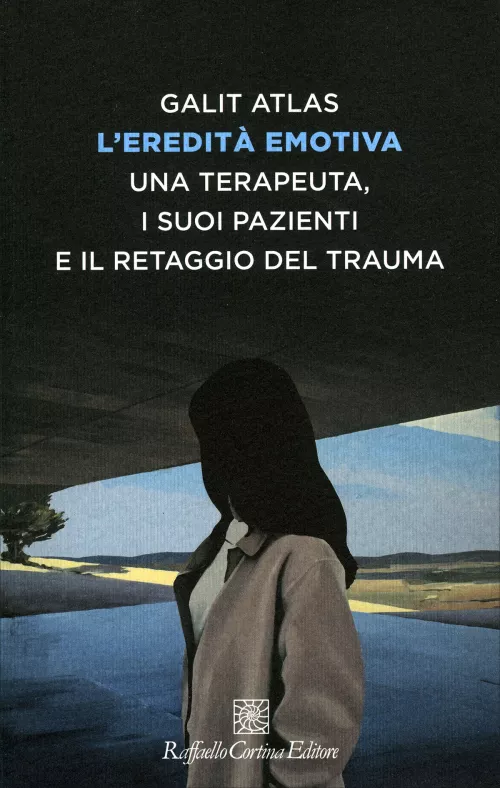Galit Atlas, i traumi sul lettino
Si può trattare la psicoanalisi come se fosse un romanzo? La risposta è sì, e Galit Atlas si rivela all’altezza di famosi narratori del lungo e tortuoso percorso psicoterapico come Irvin Yalom e Torey Hayden, solo per fare due nomi.
Non è semplice, per gli addetti ai lavori, tradurre la relazione terapeutica in una narrazione fruibile per tutti, ci sono ostacoli come il segreto professionale, il dover rendere una storia coerente nonostante la necessità di modificare i dettagli, gli aspetti più intuitivi e inconsci che “accadono” in seduta, difficilmente descrivibili ma non per questo meno importanti.
Ciò non significa che gli psicoanalisti non leggano e non scrivano, anzi, i contributi di nicchia e specialistici sono numerosissimi, più difficile invece la diffusione.
Questo libro è strutturato in undici capitoli che sono undici storie di pazienti. Ciò che li accomuna è il trauma, che ciascuno ha subito nelle sue forme così differenti e caratterizzanti. La preparazione teorica e clinica di chi conduce i colloqui e racconta, non è disgiunta da un’umanità che non viene mascherata: il terapeuta è una persona, che a sua volta può aver subito traumi. Il suo dialogo interiore, gli inciampi e le sbadataggini si coniugano con la profonda commozione e la lunga memoria per le storie incontrate, anche a distanza di anni.
Il trauma si presta bene a un’indagine alla Sherlock Holmes: in tutte le storie, intrecciate a un sapere storico della psicoanalisi comprovato in anni di pratica clinica, c’è la ricerca di un evento del passato, remoto o recente, che può aver determinato il breakdown, il crollo. L’analista ha di fronte a sé una persona, con il suo corpo, le sue parole, i suoi sguardi e i suoi silenzi, che richiedono a volte, per poter trovare un percorso a cui attingere e per allacciare un dialogo interiore, il ricorso anche all’immaginazione. “Mi immagino la bimbetta che è stata, che cercava di fare la brava rimanendo in silenzio per non interrompere nessuno, per non cacciarsi nei guai, facendo finta di non esistere” (p. 29). È per questa via che a volte si riesce a trovare una chiave interpretativa che apre mondi sepolti.
Di tanto in tanto ci giungono elementi e curiosità del sapere psicoanalitico, mai banali e sempre di grande pertinenza nella comprensione delle storie degli analizzanti: “Freud ha scritto che una delle cose che amava di meno era lavorare con pazienti innamorati. Secondo Freud, l’amore è un sentimento irrazionale e la persona innamorata vive una fase semi-psicotica, non in contatto con la realtà” (p. 39). Certo, sappiamo bene come Freud non fosse incline ad abbandonarsi al sentimento oceanico, come lui stesso ammise a più riprese. Tuttavia i misteri dell’innamoramento e della sessualità possono darci chiavi di lettura sorprendenti nella comprensione della storia, degli intrecci, delle origini dei traumi di una vita, come nel caso di Eve.
Nel secondo capitolo riveste un ruolo significativo la famosa espressione di Ferenczi “confusione delle lingue”. Lo psicoanalista ungherese, misconosciuto da Freud proprio per le sue insistenti ricerche sui traumi reali di origine sessuale e violenta, fece luce su come ciò che avviene nell’abuso sessuale di un bambino sia una confusione tra il linguaggio della tenerezza e il linguaggio della passione. Se il linguaggio della tenerezza è l’unica lingua che possono parlare e comprendere i bambini, tutt’altro è il registro parlato e agito dagli adulti abusanti, dove la sessualità adulta presuppone uno sviluppo e un funzionamento che gettano il bambino nella confusione.
Questa confusione comporta appunto difficoltà di discernimento, colpa, rimozione. “L’abuso sessuale non viene registrato sempre come traumatico dal bambino, sopraffatto da qualcosa che non riesce a elaborare e a cui non riesce a conferire un senso” (p. 64). Ed è proprio questo ciò che caratterizza tutte le undici storie: un senso si è perduto. Il sintomo irrompe improvviso, a volte feroce, e con molta pazienza, amorevolezza e professionalità, occorre ricostruire insieme il suo possibile senso.
Nelle storie trovano posto anche alcune ricerche recenti, meno note anche nella letteratura di settore, e che possono apparire curiose, come quella sulla “radioattività” del trauma a cura della prof.ssa Yolanda Gampel di Tel Aviv University: “come una pioggia radioattiva, la radiazione fisica ed emotiva di una catastrofe si diffonde nella vita delle generazioni successive, manifestandosi in forma di sintomi fisici ed emotivi, reminiscenze del trauma, di un attacco alla propria vita” (p. 110).
 Si aprono qui capitoli riguardo ai traumi transgenerazionali, dove l’esposizione di una generazione al peggior non senso della storia, l’Olocausto e tutte le persecuzioni razziali, può ripetersi sotto forma di sofferenza muta per intere generazioni. “Effetti mostruosi e distruttivi provocati dalla sconvolgente violenza sociopolitica. Non riusciamo a proteggerci dall’impatto di eventi accaduti molti anni fa in luoghi lontani, nemmeno quando non li abbiamo vissuti in prima persona o non ne conosciamo i dettagli” (ibid.).
Si aprono qui capitoli riguardo ai traumi transgenerazionali, dove l’esposizione di una generazione al peggior non senso della storia, l’Olocausto e tutte le persecuzioni razziali, può ripetersi sotto forma di sofferenza muta per intere generazioni. “Effetti mostruosi e distruttivi provocati dalla sconvolgente violenza sociopolitica. Non riusciamo a proteggerci dall’impatto di eventi accaduti molti anni fa in luoghi lontani, nemmeno quando non li abbiamo vissuti in prima persona o non ne conosciamo i dettagli” (ibid.).
Ci sono poi traumi dovuti a perdite secche e improvvise, emorragie libidiche vere e proprie che possono arrestare le vite di intere famiglie. Come nel caso di Jon, ultimogenito di cinque fratelli, il cui destino si incrocia, a pochi mesi di vita, con la tragedia della morte della sorella maggiore dodicenne travolta da un incidente in bicicletta. La vita di tutti si arresta. Il senso di colpa di chi sopravvive è acuto e indicibile. Divenendo padre, a distanza di molti anni, Jon ha un tracollo, si fa strada in lui l’idea bizzarra di non poter meritare la vitalità della paternità.
“Non ho nemmeno una storia da riportarle, non posso dirle: ‘Mi è successo questo e quello’, eccezion fatta per ciò che le ho già detto. Tutto qui. Davvero, non ho quasi alcuna immagine della mia infanzia. Mio fratello Jake mi racconta che mia madre mi avrebbe lasciato cadere dalle braccia quando seppe dell’incidente di mia sorella, ma probabilmente questa cosa non è nemmeno accaduta. Non voglio cercare scuse” (p. 134). Un’infanzia senza ricordi, un enorme buco nero di una vita non vissuta fino al giorno dello scatenamento sintomatico, in cui Jon finalmente può gridare aiuto e chiedere di essere tenuto in braccio, metaforicamente parlando. È anche di questo che si tratta nella relazione analitica, trovare un luogo dove non si viene lasciati cadere nella ripetizione del trauma.
Che dire invece di chi ha avuto un suicidio in famiglia? Come può continuare a vivere, un figlio, un partner, una madre, un padre, dopo il suicidio di una persona cara? Per figli e nipoti è un’eredità pesantissima. Il mistero che porta con sé il nonno suicida di Leonardo è vissuto come una maledizione, una sorta di ripetizione assurda e irresistibile a farsi del male. “Quando la nostra mente ricorda, il nostro corpo è libero di dimenticare” (p. 126).
Se il silenzio è il miglior alleato patogeno del trauma, che lascia aleggiare fantasmi anche attraverso le generazioni, la parola, il discorso, l’ascolto di un analista che rilanci lo spirito del linguaggio, sono medicine, le uniche davvero efficaci. Questo libro si pone come una goccia in controtendenza, celebra la capacità di fermarsi a pensare, a rielaborare la propria storia, all’interno di una buona relazione protetta e unica, come è (e dovrebbe essere) quella con l’analista.
“Comunicazione inconscia’ significa che una persona può comunicare con un’altra senza passare attraverso la consapevolezza e senza intenzione, persino senza che le persone se ne accorgano. Tutto questo ha implicazioni profonde: siamo interconnessi secondo modalità che non riconosciamo appieno né possiamo controllare, e sappiamo, l’uno dell’altro, più di quanto ci rendiamo consapevolmente conto” (p. 127). È proprio da questa comunicazione inconscia che si generano i fantasmi che ci abitano, che orientano le nostre vite e determinano le nostre sofferenze.
L’analista, tra le altre cose, è un decifratore simbolico dei fantasmi di cui si nutre il trauma, di irriducibili resti di discorsi mai detti ma scolpiti nel corpo di chi soffre psicologicamente. E la sopravvivenza della psicoanalisi è legata al rilancio del piano simbolico, dell’esistenza come un piano che sì, ci determina perché già scritto, ma su cui si può lavorare creativamente a partire da un disegno comune, rivitalizzato da un linguaggio che si rinnova nel discorso analitico.
Per definire la vita umana Lacan ha più volte evocato la leggenda antica dello schiavo-messaggero che portava scritto, sulla propria nuca rasata, il messaggio che avrebbe dovuto recapitare senza poterlo leggere. Questa metafora indica come tutti noi portiamo sulle nostre nuche le sentenze, le maledizioni, gli auspici, le speranze, i desideri, le gioie di chi ci ha preceduto senza poterle leggere direttamente.
Ciascuno porta scritto sulla propria nuca il destino che l'Altro ci ha assegnato senza poterlo decifrare. Se non ci fosse una disciplina deputata a leggere, tradurre e decifrare la lettera che l’Altro ha tatuato sulla nostra nuca, non ci sarebbe lavoro analitico. Se non si scommettesse sulla possibilità di trasformare i simboli che ci hanno marchiati non ci sarebbe psicoanalisi, ma solo ortopedia del comportamento psicologico.
Il mestiere dell’analista non è sempre così avventuroso, ogni traduzione del percorso analitico in libri, film, serie TV, deve necessariamente passare attraverso l’imbuto della spettacolarità di una vicenda, che ha una premessa misteriosa, un decorso e un esito, di solito di guarigione. A volte in analisi si fanno passi indietro, ci sono degli arresti nella risoluzione sintomatica, una caratteristica del trauma è quella di insistere nel riproporsi, in diverse soluzioni paradossali e sintomatiche.
Ma questo libro funziona come un condensato e un catalizzatore, in un’epoca di disorientamento in cui tutto ciò che ha un valore dev’essere misurabile e performante, la descrizione di un processo analitico è la prova che si può sostare, anche a lungo, nell’incertezza e nel dolore, che c’è chi ha una vocazione per farlo e può resistere nell’incertezza, nell’accompagnare in un viaggio unico e percorribile solo nella misura in cui un analista, a propria volta, ha portato a fondo a sua volta la sua propria analisi personale.