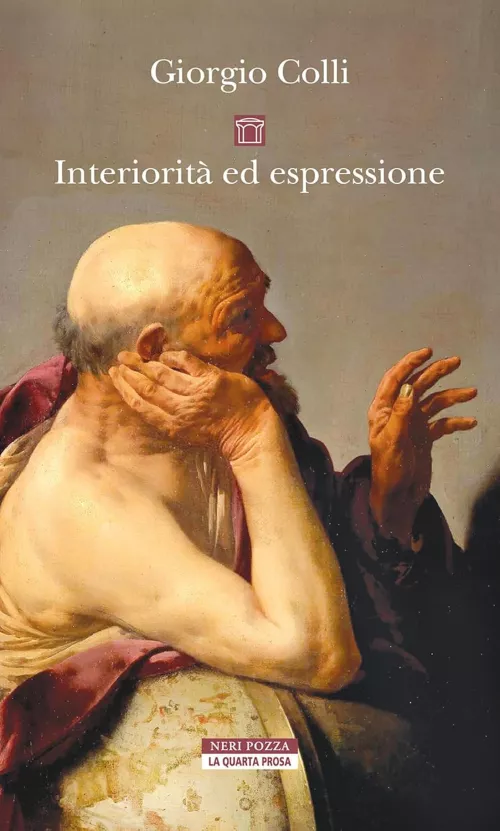Giorgio Colli: la dismisura nella misura
Nel presentare Interiorità ed espressione (a cura di M. Cutrì e L. Torrente, Neri Pozza, Vicenza 2024, pp. 202) il libro di Giorgio Colli che raccoglie i suoi appunti giovanili, Giorgio Agamben, nell’Avvertenza, osserva giustamente che non è possibile cogliere la singolarità e l’originalità del pensiero di Giorgio Colli se si separano le sue riflessioni filosofiche dall’attività editoriale. “È noto, scrive Agamben, che, senza di lui, due fra le più prestigiose case editrici italiane, Boringhieri e Adelphi, non sarebbero diventate quelle che sono”. Einaudi si lasciò convincere “dalla parte più ottusa della cultura della sinistra italiana” a recedere il contratto con Giorgio Colli per quell’edizione delle opere di Nietzsche che sarà pubblicata dalla nascente casa editrice Adelphi e che, grazie a Colli e a Mazzino Montinari, restituirà un pensiero critico tra i più potenti della filosofia occidentale contemporanea e non solo (sulle vicende dell’edizione critica delle opere di Nietzsche e in generale su Giorgio Colli, cfr. qui).
Aggiungo che non si deve neanche separare la riflessione filosofica di Colli dalla sua attività di traduttore e di filologo. Tra le sue non poche traduzioni rammento La critica della ragion pura di Kant (pubblicata nel 1957 e riproposta da Adelphi nel 1976) e L’Organon di Aristotele (apparsa per la prima volta nel 1955, ma più recentemente riproposta anch’essa da Adelphi nel 2003). Ed è proprio da quest’ultima traduzione che vorrei partire per discutere Interiorità ed espressione. Dell’Organon fa parte quello scritto aristotelico che è noto come De interpretatione, parola latina che traduce perì ermenèias (da cui ermeneutica). Colli traduce con Dell’espressione, concetto chiave nel suo pensiero al punto che egli ha pubblicato nel 1969 una Filosofia dell’espressione (Adelphi, Milano 1969). Che rapporto c’è tra interpretazione e espressione? Perché usa espressione e non interpretazione? Credo sia un modo di rispondere a Nietzsche, rimanendo nel suo solco, e alla sua famosa affermazione secondo cui non ci sono fatti, ma solo interpretazioni.
Queste rinviano ad altre interpretazioni in un gioco in cui non vi è più quella separazione tra superficie e profondità che caratterizzava il pensiero moderno a partire dalla prospettiva rinascimentale e poi da Descartes, o almeno non vi è più l’identificazione della superficie con la prossimità e della profondità con la distanza. D’altra parte non si dà corrispondenza tra linguaggio e cose e ancora meno tra soggetto e oggetto. “La cosa in sé, scrive Nietzsche, (la verità pura e priva di conseguenze consisterebbe appunto in ciò) è d’altronde del tutto inafferrabile per colui che crea il linguaggio, e non è affatto degna per lui di essere ricercata. Egli designa soltanto le relazioni delle cose con gli uomini e ricorre all’aiuto delle più ardite metafore per esprimere tali relazioni” (F. Nietzsche, Verità e menzogna in senso extramorale, trad. di Giorgio Colli, Adelphi, Milano 2015, p. 17). L’espressione, prima ancora che interpretazione, è rappresentazione, ma una rappresentazione che non è costruita, come quella di Descartes, sulla relazione tra soggetto e oggetto. Essa rinvia a qualcosa di ignoto. Le interpretazioni rinviano ad altre interpretazioni, le espressioni rimandano a qualcosa di nascosto, come la natura in Eraclito.
Come fa notare Luca Torrente nella Prefazione, in tutto il pensiero di Giorgio Colli è centrale l’immediatezza della vita da cui hanno origine l’astrattezza del pensiero e la rappresentazione. Il gioco è nietzscheanamente tra apollineo e dionisiaco, tra misura e dismisura. La vita è nascosta nel dionisiaco e il pensiero e la rappresentazione sono la misura dell’apollineo che tuttavia non esaurisce ciò che è nascosto nell’immediatezza vitale del dionisiaco. I filosofi antichi, Eraclito, Parmenide, Empedocle sono i suoi eroi, coloro che hanno colto l’impossibilità di conciliare apollineo e dionisiaco, ma nello stesso tempo, la necessità di vivere tale impossibilità. Eraclito ed Empedocle “sono uomini che sentono i contrari in modo talmente violento che riesce per loro impossibile comporli col mezzo apollineo della misura.

La misura è per essi una maschera, una maschera tragica – a passi misurati essi camminano verso il loro abisso”, (Interiorità ed espressione, cit., p. 128). E per quel che riguarda Parmenide, egli si domanda quale sia la sua dottrina: “non è il principio logico di identità, ma l’intuizione suprema, l’estasi fuori del tempo, la luce abbagliante che appare improvvisamente a conclusione di tutto il processo di disumanamento, quando ci si è liberati da ogni immagine e da ogni interesse terreno” (Ivi, p. 133). Non siamo lontani, a mio parere, dal rifiuto di Heidegger del famoso detto di Protagora, “l’uomo è misura di tutte le cose”; il percorso di Colli è parallelo, ma diverso. L’espressione per lui è mancanza di quel che resta d’altro dopo che il linguaggio si è espresso. Quest’altro, nascosto, evoca l’Essere di Heidegger, anche se in Colli più acuto sembra il dolore nella lotta che Eraclito, Parmenide, Empedocle combattono tra apollineo e dionisiaco, tra misura e dismisura. Gli eroi di Heidegger sono Eraclito e Parmenide; ad essi Colli aggiunge Empedocle di Agrigento. Il suo suicidio non fu per pessimismo, “ma per troppo amore per la vita, per salvare la maschera apollinea, per tradurre apollineamente (visivamente) la sua ultima Erlebnis [l’esperienza vissuta], perché il suo spirito non gli schiantasse il corpo – espressione ultima della pienezza di vita, morire nel bello” (Ivi, p. 128).
Il dramma intellettuale di Giorgio Colli è l’impossibilità di rivivere l’immediatezza della vita se non attraverso quei sostitutivi che sono il linguaggio, il pensiero e la memoria, che non hanno il potere di colmare, sostituendolo, ciò che è. La vita dionisiaca basata sulla dismisura ha comunque la meglio su quella apollinea caratterizzata dalla misura, anche se gli uomini non possono fare a meno di quest’ultima, anzi essi sono nel gioco tra apollineo e dionisiaco, tra l’ordine del pensiero e il pulsare della vita, tra la costituzione dell’individualità e il flusso vitale della collettività. L’interiorità consiste nella dismisura dionisiaca, la vita nel suo affermarsi; l’espressione consiste nella misura apollinea, la conoscenza nell’essere illusione rappresentativa. Ma in questo gioco tragico tra dionisiaco e apollineo emerge lo scontro tra collettivo e individuale. Immergersi negli altri o separarsi dagli altri.
Quella che successivamente chiamerà espressione è forse la risposta a un problema drammatico sofferto appunto dai filosofi greci: “sentirsi separati dagli uomini mentre vorrebbero farsi capire” (Ivi, p. 105). Platone, influenzato da Socrate, per tutta la vita porta con sé l’illusione di farsi capire, ma il vero eroe della solitudine e del distacco dagli uomini è Eraclito: “né Empedocle, né Nietzsche sono arrivati alla sua altezza: Sua opera come prodotta contro la sua volontà – uscita da una tensione spirituale senza paragone – espressione di una volontà di potenza insuperabile – sua oscurità” (Ibidem). Volontà di separarsi e di nascondersi della filosofia? Aristocratismo? Compiacimento dell’oscurità, al punto da considerare Platone con i suoi miti un illuso? Forse. Lo vedevo così quando ero studente all’Università di Pisa dove lui insegnava Storia della filosofia antica. Ma oggi non saprei. Il richiamo di Colli al senso tragico di separatezza dei suoi eroici filosofi presocratici esprimeva forse soltanto una tragica impossibilità, ma se visto con gli occhi di oggi, nel bel mezzo del dominio dei social e della filosofia pop, evoca un’utopia, che ha avuto (lo ha ancora?) un senso importante: applicare il metodo comunicativo del dialogo, basato sulla relazione uno-uno o uno-due, là dove, in democrazia, nel rapporto uno-molti, viene usata la retorica. È un metodo rischioso: Hannah Arendt imputa a Socrate l’errore di avere usato, durante il processo contro di lui, il metodo dialogico là dove era necessaria la retorica. Ma è un rischio che merita di essere corso: l’utopia dell’insegnamento è di applicare la relazione dialogica in un rapporto uno-molti, quello tra insegnante e alunni. È un rischio che si dovrebbe correre in politica. Inoltre, quello che per Eraclito, Parmenide e anche per il democratico Empedocle risultava impossibile, dovrebbe trasformarsi, proprio grazie a loro e alla forza dissacrante di Nietzsche, nel sogno di un altro mondo possibile, quello in cui tutti possano accedere al sapere alto piuttosto che abbassarsi alla condizione dei prigionieri della caverna di Platone del “non sapere di non sapere”.