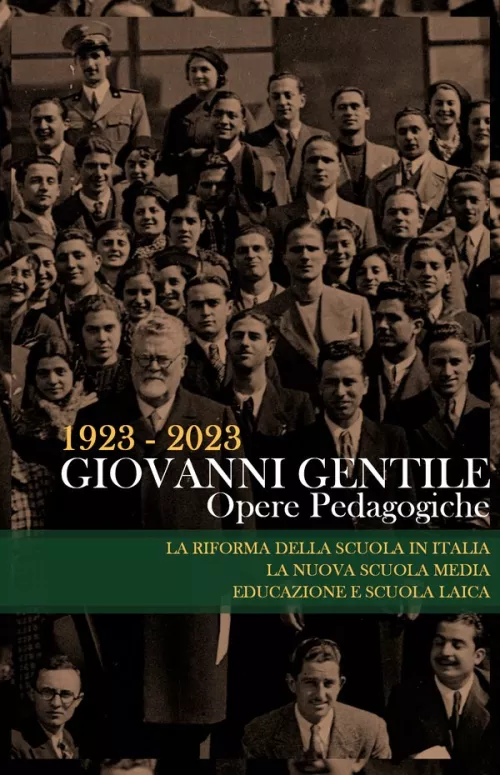Giovanni Gentile. Un’erotica della scuola
Rileggere Gentile per proporre una rivoluzione pedagogica che sia all’altezza delle urgenze del nostro tempo non può non apparire un proposito equivoco e pericoloso. Se poi con “rivoluzione pedagogica” si intende addirittura una “erotica della scuola” che ne esalti il tratto radicalmente democratico, inclusivo, emancipativo ed universalistico, la cosa si fa francamente imbarazzante. Non c’è dubbio infatti che la Scuola ideata dal Ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile al tempo del primo governo Mussolini, nel 1923, sia esattamente la scuola che Don Milani avversa e che combatte. La scuola della “Riforma Gentile” è una scuola di classe, è una scuola che esclude, è una scuola che seleziona, è una scuola maschilista, fallocentrica, ed è una scuola che ha un tratto odiosamente “fascista”. Ma lo è anche l’idea di scuola di Gentile filosofo attualista? Tra l’idea di scuola del filosofo e la Scuola progettata dal Ministro vi è tutta la differenza che passa tra una erotica della scuola ed una retorica della scuola, tra un sapere libero e fine a se stesso ed un sapere asservito ad un ideale, un sapere che deve funzionare e produrre dei risultati quantificabili e utili per lo Stato (oggi, si direbbe “per l’impresa”). Indipendentemente dal tipo di eros al quale vogliamo fare riferimento, c’è infatti una “erotica” quando un fare condiviso ha come fine il suo stesso esercizio, quando non è vincolato ad un servizio da rendere, ad una produzione o a una riproduzione, quando è un fine in sé (come quando si “fa l’amore” per il piacere di “fare l’amore”). Così è per la filosofia che cessa di essere una erotica del concetto quando pretende di farsi discorso edificante. In tal modo la veggenza del filosofo è spenta in nome di un preteso “dover-essere”. Per Gentile Ministro e militante politico il “valore” era lo stato etico, incarnato in Benito Mussolini. Ed è proprio la retorica che ucciderà Il filosofo Gentile il 15 Aprile del 1944 a Firenze: sarà un retoricissimo discorso a favore della coscrizione obbligatoria tenuto da Gentile mentre i fascisti facevano strage di giovani renitenti alla leva a segnare la sua condanna a morte.

Ma se si sfogliano le pagine della Prefazione al Sommario di Pedagogia scritto da un Gentile trentasettenne si fanno delle scoperte sorprendenti che gettano luce sul nostro presente indicandoci vie di fuga dal nostro quotidiano “orrore pedagogico”. Gentile racconta che quel libro nasceva da una “repugnanza antica per la pedagogia come è comunemente intesa”. Gentile si riferisce polemicamente alla pedagogia positivista dell’Italia post-unitaria, ma la sua repugnanza investe il presupposto metafisico di quella pedagogia, un presupposto che, ulteriormente raffinato a colpi di scienze umane e di cibernetica, continua a valere più che mai per noi, oggi, e che orienta silenziosamente, quasi fosse una ovvietà indiscutibile, tutta la nostra discussione sulla scuola. Gentile, parlando en philosophe, lo denuncia come “metodo della trascendenza”, come “naturalismo”, come “obiettivismo”, come “realismo”. Noi possiamo tradurlo nella lingua della teoria della comunicazione che ci è più familiare di quella hegeliana. Esso consiste nel pensare il nesso insegnamento-apprendimento sul modello della trasmissione di un messaggio da una fonte (il maestro) ad un ricevente (il discente) alla più alta velocità consentita dal canale. Gentile lo chiama “metodo della trascendenza” perché questo modo comune di intendere l’insegnamento-apprendimento presuppone il sapere già interamente costituito, indipendentemente dall’evento della sua comunicazione reale (la scuola, la lezione, il corso di studi), il quale, anzi, costituisce solo un fattore di disturbo che deve essere il più possibile ridotto (ad esempio, definendo con cura e anticipatamente gli “obiettivi” dell’insegnamento-apprendimento ed elencando le “competenze” che devono essere acquisite perché si possa giudicare la riuscita della “trasmissione”). Al limite, secondo questo schema, il fatto che ci sia comunicazione reale, qui e ora, tra queste persone vive costituisce un incidente purtroppo ineliminabile alla buona riuscita della comunicazione!

La repugnanza gentiliana per questo metodo astratta ha un’origine veramente “antica”. Quando Platone stigmatizzava la tecnologia alfabetica, nel Fedro e nella Settima lettera, aveva di mira proprio questo “metodo della trascendenza” reso possibile da un algoritmo, l’alfabeto appunto, che permetteva di trasmettere la voce del maestro all’allievo alla più alta velocità possibile e con la minore perdita di informazione. Non era nemmeno indispensabile che il maestro fosse vivo e che l’allievo fosse nato perché la scrittura non ha bisogno della presenza essendo la portavoce di una verità impersonale che parla a tutti e a nessuno in particolare. Così poteva accadere che un giovane tiranno siracusano potesse dirsi platonico perché aveva “letto” i biblia di Platone. Platone provava “per la pedagogia come è comunemente intesa” la stessa repugnanza del suo futuro collega italiano. Per entrambi, il momento erotico dell’incontro, il momento della comunità reale, la scuola, insomma, lungi dall’essere il fattore di disturbo, è il perno del processo di insegnamento-apprendimento. Senza di esso non vi è sapere, ma, come dice Platone, solo una macchina astratta del ricordo o, come dice Gentile, solo una cultura “libresca” e “pedante”. Noi diremmo che senza l’erotica della scuola vi è solo tecnicizzazione e funzionalizzazione.

All’orrore pedagogico della scuola delle competenze e della programmazione, Gentile contrappone il “metodo dell’immanenza” che, nella sua invecchiata e talvolta stucchevole lingua, corrisponde all’“idealismo”, all’“attualismo”, allo “spiritualismo”, ma ciò che egli intende in ultima analisi è una vera propria rivoluzione epistemologica che, senza che Gentile se ne renda minimamente conto, è in linea con quello che stava accadendo in quegli stessi anni nei laboratori di fisica. Secondo questo metodo, la verità non va presupposta al sapere, come qualcosa di dato, magari irraggiungibile dal nostro intelletto finito, ma comunque essente “da qualche parte”, ad esempio, nell’intelletto di Dio per chi ci crede. Il sapere non è insomma una adeguazione, sempre approssimativa, graduale, ad un vero trascendente. No. Verità e sapere sono fatti per Gentile della stessa pasta. Come per i filosofi pragmatisti suoi contemporanei, come per Bergson (e aggiungerei in questa lista anche il nome di Freud), per Gentile non c’è la verità (trascendente, separata, immobile, intangibile…), c’è un divenire vero, volta a volta, occasione per occasione. Il giovane Gentile non esita a trarne tutte le conseguenze sul piano pedagogico, lasciandoci ancora oggi basiti per la sua radicalità. Se infatti le cose stanno così il nesso insegnamento-apprendimento da cinghia di trasmissione di un sapere presupposto diventa il luogo in cui la verità, tutta la verità, accade e si rinnova. Da luogo della comunicazione-trasmissione del sapere dato, nella testa di Gentile, come nei voti dei più folli utopisti rivoluzionari, la scuola diventa luogo della sperimentazione del sapere. Certe formulazioni della pedagogia gentiliana, che ad una prima lettura appaiono intrise di roboante retorica spiritualistica (e in parte lo sono veramente), andrebbero lette in questa chiave. Così quando Gentile dice che non ci sono due o più attori del processo educativo, ma che c’è solo lo spirito, il quale con un ritmo trinitario, genera incessantemente se stesso – e lo fa in ogni età della vita, perché l’educazione è permanente –, sta di fatto affermando, contro ogni trascendenza, contro ogni dogmatismo, che la verità è evento, che l’assoluto è sempre presso di noi e che noi viviamo in esso. Se la verità è evento, se è l’assoluto il soggetto che nella “scuola” non cessa di farsi non essendo mai fatto, allora è del tutto empirica la distinzione tra chi forma e chi è formato, è del tutto empirica la distinzione tra maestro e allievo. Nel “modo in cui la pedagogia è comunemente intesa” gli attori erano due e erano tra loro in una relazione di potere dissimmetrica. Nel cosmo pedagogico gentiliano la piramide lascia il posto alla sfera infinita di Giordano Bruno dove centro e periferia diventano indistinguibili. L’“autoritario” Gentile, il “reazionario” Gentile, il “fascista” Gentile, sembra qui dare voce alle istanze metafisiche più profonde che animeranno la rivoluzione culturale maoista.
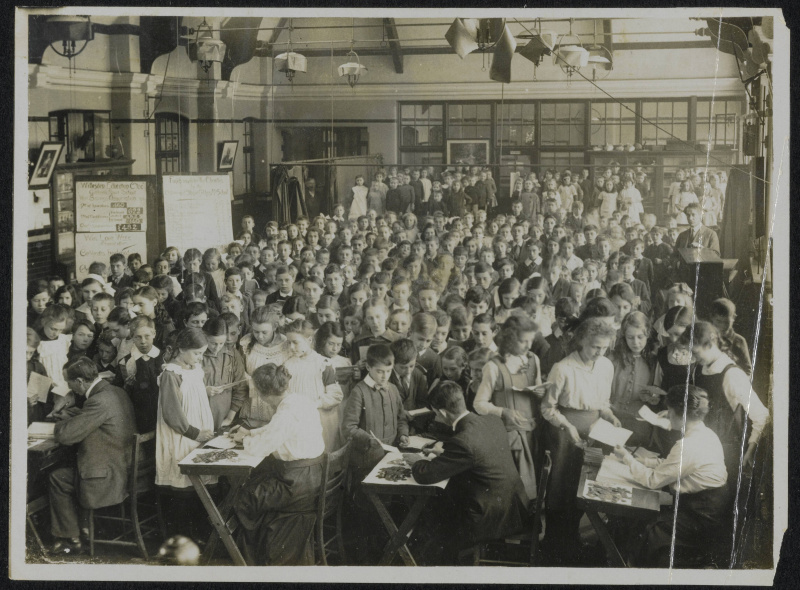
Da questa premessa discende la tesi gentiliana più invisa alla moderna pedagogia. Questa si è costituita nei nostri dipartimenti universitari come scienza autonoma proprio sul fondamento della contestazione di quella tesi. La pedagogia, per Gentile, non è una scienza pratica, non è una scienza normativa, non è nemmeno una scienza umana, la pedagogia non è nient’altro che filosofia nella misura in cui la filosofia è episteme tes aletheias, è scienza della verità. Ma vale anche il reciproco: la filosofia non è nient’altro che pedagogia. Il che esclude il tanto vituperato primato della filosofia sulla pedagogia, perché, se la verità è evento, pedagogia e filosofia sono veramente il medesimo. Ne consegue che la “filosofia dello spirito”, come la chiama Gentile, non è una teoria che si “applica” alla scuola ma coincide punto a punto con la prassi educativa, ad ogni livello, dalla scuola primaria all’università, indipendentemente dalla disciplina che viene materialmente insegnata. Insegnare a leggere e a scrivere, insegnare la matematica o la chimica, è già, insomma, filosofia in atto. Una proposizione che andrebbe ricordata a quei feticisti della filosofia che credono che portare la filosofia ai bambini della primaria voglia dire raccontargli favolette sulla caverna di Platone.

Gentile ha enunciato il concetto dell’assoluto che deve ispirare una scuola fondata sul metodo dell’immanenza. Lo ha fatto in occasione dell’aspro dibattito su scuola confessionale / scuola laica che ebbe luogo in occasione del VI Congresso nazionale della Federazione degli insegnanti delle scuole medie che si tenne a Napoli dal 24 al 27 Settembre del 1907. Il giovane Gentile era relatore. L’uditorio era prevalentemente composto da spiriti liberali, laici e progressisti. La tesi gentiliana suonò subito scandalosa. Per Gentile, infatti, la scuola confessionale godeva di un primato sulla scuola cosiddetta laica perché manteneva un concetto dell’assoluto (la fede antirazionale nella trascendenza, il senso del mistero e dell’autorità). Senza un concetto dell’assoluto non vi è infatti scuola e il laicismo, che dismette ogni assoluto, scegliendo la via della neutralità e del relativismo, non può essere principio di nessuna scuola. Una scuola laica che vuole essere scuola deve allora attrezzarsi con un concetto dell’assoluto opposto a quello teologico. Il giovane Gentile lo chiama “un concetto sintetico della vita”. Potremmo, dice, formularlo così: “la ragione della vita è dentro e non fuori dalla vita; la ragione di tutto quello che si pensa è nel seno stesso di quest’essere, che vediamo. Nulla trascende il nostro mondo concepito razionalmente; e però (non in senso avversativo, nota mia) nulla trascende il nostro spirito. I misteri, le sorgenti imperscrutabili dei valori umani sono la negazione dell’autonomia e quindi di ogni valore umano (G. Gentile, Educazione e scuola laica, Vallecchi, Firenze 1921, p. 110). Ecco l’Idea di scuola del filosofo Gentile così diversa, al limite dell’incompatibilità, dalla Scuola del Ministro Gentile ma anche dalla nostra scuola delle competenze e della funzionalizzazione. Il suo fondamento è un empirismo radicale ed una immanenza assoluta – “nulla trascende il nostro mondo” – che per principio interdice ogni dinamica autoritaria ed ogni esclusione. Trasvalutata eroticamente, la “scuola”, intesa nella sua accezione più vasta, diventa quell’ambito privilegiato e felice in cui la vita si esprime al massimo della sua potenza.