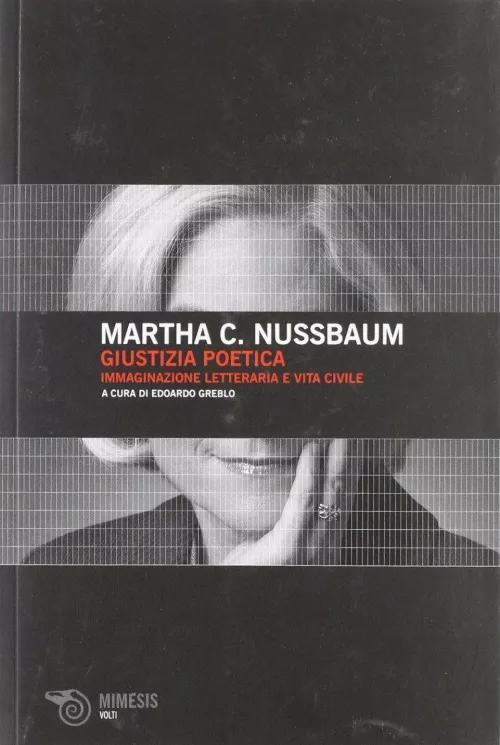L'uso delle parole / Letteratura e giustizia
Legittimo impedimento, presunzione d'innocenza, patteggiamento, prove, indizi. Questi termini sono ormai parte del nostro linguaggio, e anche del nostro immaginario, di cui le parole sono sempre le spie.
Da qui viene da chiedersi: la lingua del diritto è davvero così fredda, inerte e oscura, come a prima vista si potrebbe pensare? E in che rapporto sta il linguaggio della legge con quello della letteratura?
Le parole dei giuristi (legislatore, giudice, avvocato), più di altre, non si limitano a descrivere fatti, li provocano esse stesse. La lingua del diritto è potentemente creativa, poiché genera norme, atti amministrativi, contratti e sentenze: essa insomma ha conseguenze reali sulla vita delle persone, modificandola. Certamente come ogni linguaggio di settore, le parole dei giuristi sono caratterizzate da una terminologia e da un frasario tecnici, il cui uso è, in qualche misura, necessario, perché vi sono categorie e concetti che non possono essere espressi e comunicati con la lingua comune.
Tuttavia la letteratura è stata la prima ad accorgersi della potenzialità creativa di questa lingua gergale irta di stereotipi, di arcaismi, di frasi formulari. Non a caso (soprattutto nelle università americane) esiste un campo di studi che s’interessa proprio delle corrispondenze tra letteratura e legge. Sì, perché per quanto possa apparire sorprendente, le infiltrazioni sono reciproche sia nell’uno sia nell’altro campo. Si rintracciano convergenze tematiche e discorsive tra due diverse arti della parola e dell’espressione: tematiche perché le rappresentazioni del crimine e del processo assumono grande importanza nella storia del discorso narrativo fino a diventare uno dei motivi fondamentali della costruzione della trama realista (dal naturalismo fino alla cinematografia contemporanea); discorsive perché il discorso forense sfrutta appieno le risorse messe a disposizione dalla retorica classica e dalla narrazione per potenziare i propri meccanismi persuasivi.
Ma la lingua del diritto non è solo quella dei processi penali, anche se certo i crimini, con il loro corollario di indagini, aule giudiziarie, prove e indizi, abitano l’immaginario di molti scrittori e di molti lettori di legal thriller, senza tenere conto di tutta la cronaca nera che, soprattutto in questi anni, riempie i giornali e fa il pieno di ascolti dei talk show. La lingua dei giuristi è anche quella del diritto di famiglia, per esempio.
Se ne è accorto qualche anno fa lo scrittore inglese Ian McEwan che, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro: La ballata di Adam Henry (Einaudi), ha dichiarato: «Gli scrittori di regola preferiscono i casi criminali. Ma la maggior parte di noi non vive in un mondo di pistole, coltelli e stupri. Quelle sono catastrofi che accadono di rado nelle vite delle persone. Mentre le divergenze su come educare i figli dopo un divorzio o sulle cure da adottare quando sono malati toccano molti, e a mio avviso sono materia perfetta per i romanzi». Come dargli torto. La trama del suo libro – ha spiegato lo stesso romanziere – ha preso spunto proprio dalla lettura della sentenza di una corte londinese che ha imposto a un ragazzo adolescente di curarsi mediante trasfusioni di sangue, alle quali i genitori, testimoni di Geova, si erano opposti con tutte le loro forze. Protagonista del romanzo è Fiona Maye, giudice quasi sessantenne in crisi col marito, convinta di restituire “ragionevolezza a situazioni senza speranza” nei casi affrontati. Questa volta tocca al conflitto religione/legge, o meglio al caso straordinario di Adam Henry, un ragazzino diciassettenne affetto da leucemia, bisognoso di trasfusioni di sangue che però gli vengono vietate dai precetti religiosi dei genitori di fede Geova.
Il romanzo di Ian McEwan mette bene in evidenza il rapporto tra letteratura e giustizia: la letteratura infatti è per eccellenza la capacità di sentire concretamente la vita di altri, di personaggi incontrati o solo immaginati o inventati; di sentirli vivi come noi e di farli vivi come noi; così anche la giustizia ha a che fare con la vita e con quella rappresentazione della vita che è l’arte, proprio perché nasce dal senso concreto dell’individuo e dalla capacità di sentire, non solo di pensare, che esistono, altrettanto concrete e in carne e ossa, persone che hanno come noi passioni, sentimenti, esigenze.
I rapporti tra letteratura e giustizia (concetto ben più ampio di quello del diritto) riguardano non solo la lingua, la forma, ma anche la sostanza. Su questo tema, meglio di tutti ha scritto la filosofa americana Martha C. Nussbaum. Nel volume Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile (Mimesis), la studiosa ha sostenuto che un bravo giudice non dovrebbe semplicemente applicare regole, ma comprenderle sviluppando la capacità di «riconoscere corrispondenze».
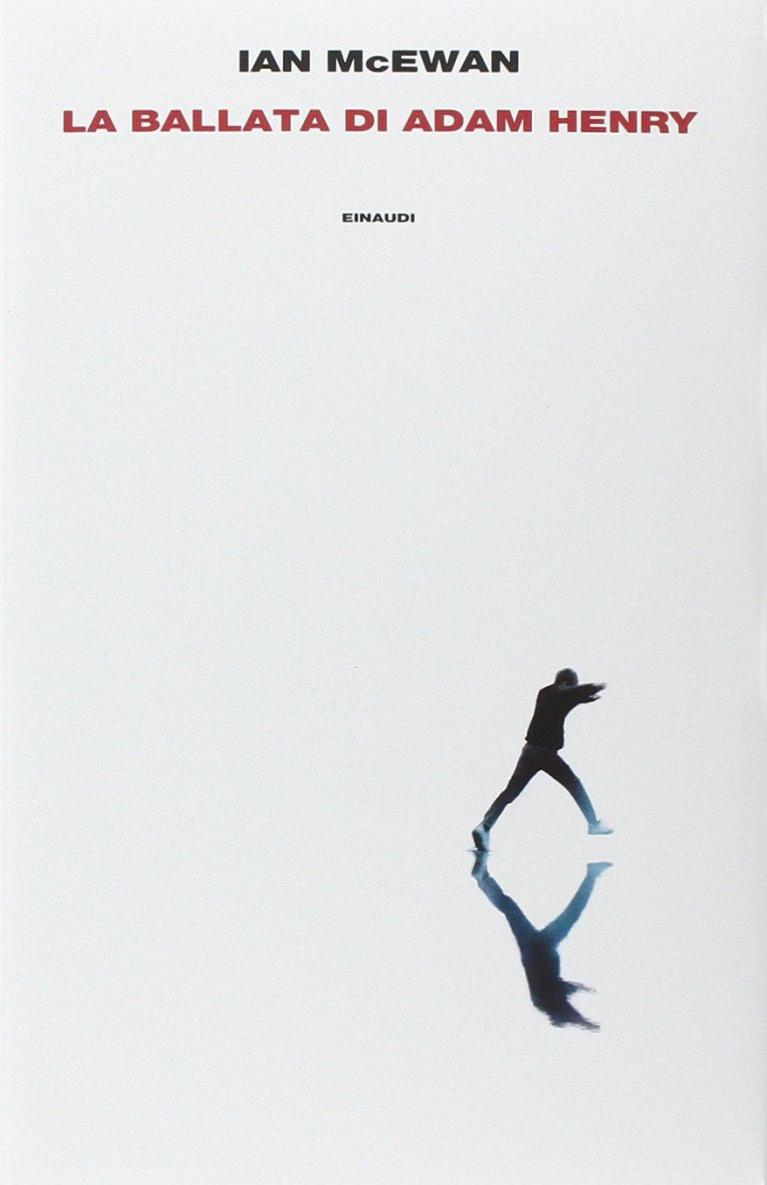
Senza rinunciare all’imparzialità, ovviamente. «Il giudice-letterato – spiega infatti la docente statunitense – è vincolato alla neutralità, propriamente intesa. La sua neutralità non richiede una grande distanza dalle realtà sociali dei casi che deve affrontare; in effetti il suo compito è di esaminare a fondo quelle realtà, con la concretezza immaginativa e le risposte emotive che sono tipiche dello spettatore imparziale – o di chi svolge la sua funzione, il lettore di romanzi». I romanzi dunque servirebbero a esprimere un senso normativo della vita e ad assumere alcuni atteggiamenti mentali piuttosto che altri.
È in questo ritrovato e rinnovato connubio tra formazione giuridica e letteraria che si può comprendere il vero significato della presenza della letteratura nella scienza giuridica. La narrativa, come scrive Brodskij, funge, infatti, da «antidoto permanente alla legge della giungla» (La condizione che chiamiamo esilio) perché è in grado di dotare il giurista di una nuova e diversa prospettiva sul diritto, sul modo in cui esso opera all’interno della società e sul fenomeno giuridico nella sua globalità.
Non si tratta dunque soltanto di individuare nel diritto un possibile oggetto di interesse letterario, quale mero spunto di attività narrativa, ma la necessaria relazione tra i due saperi può e deve tradursi nella reciproca integrazione delle sensibilità che muovono le discipline. È tramite questo completamento che il diritto può ambire a perseguire il più alto significato di giustizia. In questa prospettiva, assume rilievo primario il linguaggio. L’esperienza letteraria, nel rinnovare di vita e di significato i testi normativi, si serve della parola, riscoprendone così la centralità. Come osservato da Gianrico Carofiglio – giurista e scrittore, autore del ciclo di romanzi dell’avvocato Guerrieri – le parole, linfa vitale del diritto, richiedono un’attenta ponderazione, poiché esse non sono solamente il veicolo e la forma di concetti e pensieri ma, aderendo alla realtà delle cose, li plasmano e danno loro significato. In tal senso, nell’imprescindibile esigenza di comprendere e padroneggiare la lingua, il giurista può trovare un valido alleato nella sensibilità e nella profondità umana propria della letteratura, la cui metaforica lente di ingrandimento può cogliere, a un livello generale e a uno propriamente giuridico, il valore della chiarezza e della ricchezza espositiva e, di contro, constatare il pericolo e la diffidenza generati dall’oscurità e dalla pochezza linguistica (La manomissione delle parole).
Nelle pagine di tanta letteratura internazionale il tema della giustizia, così come il linguaggio giuridico, sono centrali. In particolare, una grande linea della cultura ebraica legata alla Legge, alla Torah, al Pentateuco, che va da Kafka a Paul Celan, da Saul Bellow a Isaac Singer a Edmond Jabès e, in area italiana, da Michelstaedter a Franco Fortini a Elsa Morante. In questi autori ricorrono continuamente i due simboli storici e mitici della giustizia, la bilancia e la spada. È quest'ultima che sembra prevalere: una spada che incombe sui nostri giorni e ci costringe a un regime di massima sorveglianza.
Le tematiche giuridiche hanno avuto un rilievo fondamentale anche nelle creazioni di Rabelais e Cervantes, Shakespeare e Milton, Balzac e Dickens, Tolstoi e Dostoesvskij, Hugo, Gide, Camus, Dürrenmatt e tanti altri. Molti di loro hanno addirittura svolto lavori che in qualche modo hanno avuto a che fare con il diritto: Dickens è stato garzone di studio (e poi cronista giudiziario); nel Novecento, Robert Musil, Jorge Amado e il poeta Wallace Stevens sono stati giuristi.
In Italia forse il più grande scrittore-giurista del Novecento è stato proprio Salvatore Satta, professore di diritto civile e autore del romanzo Il giorno del giudizio, che il grande critico George Steiner ha definito: «Uno dei capolavori della solitudine e della letteratura moderna». In quest’opera forma e sostanza si sono fuse in un equilibrio perfetto, dentro un linguaggio distillato dall’uso di parole strettamente necessarie, a dimostrazione di quanto il linguaggio sia fondamentale per un giurista: dall’uso che quest’ultimo ne fa può dipendere il destino di un uomo. Perché in fondo la giustizia si esprime attraverso formule, sentenze, in sostanza attraverso un atto verbale. È la parola che si traduce in pena.