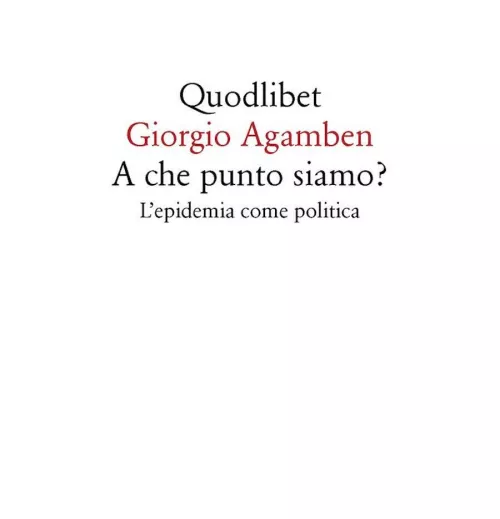Il caso Agamben / Biopolitica del virus
Le prese di posizione sulla pandemia di Giorgio Agamben, ora raccolte nel volume A che punto siamo edito da Quodlibet, hanno suscitato stupore e irritazione. Gli si rimprovera, e non velatamente, l’adesione alla tesi della “dittatura sanitaria”. La semplificazione giornalistica delle tesi agambeniane è brutale e ingenerosa, tuttavia è un fatto che la piazza negazionista non ha avuto difficoltà a fare proprie le parole d’ordine di una una delle più raffinate, potenti e precise teorie filosofiche che la contemporaneità abbia prodotto. La questione sollevata da questo uso politico della filosofia è, a mio giudizio, enorme e va ben oltre i semplici confini della buona o cattiva ermeneutica. La questione, direi, è innanzitutto politica. Ciò che si registra, se guardiamo alle piazze della protesta, è infatti la singolare convergenza che si è venuta a creare tra la critica dell’ideologia neoliberale – dunque qualcosa di molto leftish nella sua genealogia intellettuale – e la mobilitazione di masse spaventate che delirano complotti orditi da élites sataniche e che sognano palingenesi fasciste. Non c’era certo bisogno del Covid perché si avviasse questo processo di cui l’Italia è stata storicamente un laboratorio per tutto il Novecento. Il Covid lo ha però accelerato, facendo, come si suole dire, venire i nodi al pettine.
Tagliare questi nodi con il moralismo di chi si sente autorizzato a giudicare sommariamente mi pare un grave errore. I passi da compiere sono piuttosto due: innanzi tutto comprendere la fondatezza e, direi, l’immanente necessità della posizione agambeniana; poi, ed è il passo più importante, mostrare come tra le “virtù” del Covid sia da annoverare il fatto che ci costringe, volenti o nolenti, a riformulare diversamente il problema che Agamben, per coerenza intellettuale, non poteva non porre. Non è, insomma, ignorando la piaga sulla quale preme il dito del filosofo che se ne esce, ma provando a cicatrizzarla per altre vie.
Il nodo dei nodi è espresso da due formule che hanno conosciuto una straordinaria fortuna nella letteratura filosofica degli ultimi trent’anni: “biopotere” e “stato di eccezione”. Anche il lettore digiuno di teologia politica riconosce immediatamente la pertinenza di queste espressioni alla situazione che stiamo vivendo. Da un lato c’è una “sovranità” che si esercita nella sospensione momentanea dell’ordine costituito e legale (“stato di eccezione”), dall’altro c’è il nuovo “oggetto” su cui si applica questo potere: non più o, meglio, non solo l’individuo e la società, come avveniva per le tecnologie cosiddette “disciplinari”, ma l’uomo come specie, l’uomo come essere vivente, l’uomo come funzione variabile di quella vita che vive e che si riproduce in forza di una “spontaneità mostruosa” (la “nuda vita”) di cui il propagarsi del virus è molto più di una efficace immagine (“biopotere”).
Se il manganello che raddrizza le schiene storte degli asociali può rozzamente esemplificare un potere disciplinare, la medicina di base, l’igiene pubblica, l’epidemiologia o il sistema dell’assistenza sociale sono gli strumenti di un biopotere che si prende in carico la gestione del vivente. In un libro famosissimo del 1994, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Agamben ha indicato nei campi di sterminio di massa il paradigma del biopotere. Con metodo e diligenza, infatti, nei Lager si ricacciava sistematicamente nella morte quanto, secondo il razzismo di Stato, ostacolava la promozione e la cura della vita ariana (il “cancro” ebraico).
Nella modernità il corpo sui cui il potere sovrano si esercita è fuor di metafora proprio il corpo del vivente, la sua “nuda vita”. Ora, Agamben, in saggi che sono diventati bestsellers filosofici su scala mondiale, ha mostrato come nessun potere totalitario sulla vita si dia senza stato di eccezione generalizzato. I due momenti si implicano reciprocamente, al punto tale che, come scrive in L’Uso dei corpi (2014), si può dire che “il potere non ha oggi altra forma di legittimazione che l’emergenza e dovunque e continuamente si richiama ad essa e, insieme, lavora segretamente a produrla”. A questa diagnosi fa seguito un sospetto, che i giornalisti oggi definirebbero “complottista”: “come non pensare – si chiede Agamben, mettendo la domanda fra prudenziali parentesi – che un sistema che può ormai funzionare solo sulla base di un’emergenza non sia anche interessato a mantenerla a qualunque prezzo?”
Le tesi “scandalose” di Agamben sulla pandemia vengono dunque da lontano e possono vantare un illustre pedigree. Il loro passato prossimo è costituto dalle ricerche sul nuovo ordine neoliberale condotte da Michel Foucault nella parte finale della sua carriera filosofica – una carriera che, per ironia del destino, fu interrotta proprio da un altro celebre virus, l’HIV.
Insieme al Foucault che, nei suoi corsi al Collège de France, ragionava sul nuovo biopotere all’orizzonte del moderno, va citato un compagno di strada della sinistra sessantottina, Ivan Illich, il quale della critica della dittatura sanitaria ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Secondo Illich, l’apparato istituzionale avrebbe progressivamente espropriato l’esperienza umana, depauperandola dei suoi saperi tradizionali, facendone la riserva di caccia di presunti “tecnici-competenti” che la gestirebbero in modo autoritario usando terroristicamente delle “parole-ameba” come “salute pubblica”, “sicurezza” o “vita”. Scolarizzare le masse, medicalizzare la salute, tecnicizzare il lavoro, sarebbero, quindi, secondo Illich, tutte pratiche che espropriano i soggetti della loro autonomia, lasciandoli in balia della “benevolente” impersonalità delle istituzioni dello Stato.
Quelli di Illich e Foucault sono nomi impegnativi che rimandano a una stagione del pensiero critico alla quale in tempi di omologazione culturale si guarda con nostalgia e di cui non è certo facile sbarazzarsi con una semplice scrollata di spalle. Andando ancora più indietro nel tempo, come Agamben ci invita fare (in saggi dove l’erudizione non è mai fine a se stessa), vi è il grande dibattito che tra l’XI e il XIV secolo impegnò le menti più sottili sul rapporto che sussisterebbe tra la potenza “assoluta” di Dio e la sua potenza “ordinata”. In quel crogiuolo dialettico – dove i teologi discettavano dottamente su quali fossero, se mai ci fossero, i limiti della potenza di Dio, se, cioè, la sua potenza non fosse segnalata proprio dalla capacità di sospendere l’ordine che egli stesso aveva deliberatamente voluto – si forgiava l’dea moderna di “sovranità”.

Essa risulta così fin da subito connessa alla “stato di eccezione”. Il “sovrano” è infatti colui che decide nello stato di eccezione: l’emergenza è il suo habitat naturale. La teologia sembra averlo compreso molto prima di Carl Schmitt al quale si assegna solitamente la paternità della definizione.
Infine, risalendo all’origine del problema, che è sempre una origine greca (cioè platonico-aristotelica), il pensiero di Agamben incrocia il grande tema dell’antropologia filosofica. Che cosa definisce l’uomo come specie nella sua differenza dagli altri enti naturali? La risposta di Agamben è la risposta classica della grande tradizione filosofica occidentale: l’uomo è l’essere del possibile, l’uomo è “l’essere della lontananza”, secondo la felice formula coniata da Martin Heidegger.
A costituirlo nella sua essenza non è una definizione statica, non è un’essenza data, ma un fare o, meglio, un farsi, un “processo di soggettivazione” o una “forma di vita”, che è un costante trascendersi in direzione di se stesso. C’è una bella espressione con la quale Agamben sintetizza tutta la sua antropologia. La trae da Aristotele che polemizza con quegli strambi personaggi chiamati dal “filosofo” per antonomasia “i megarici” (nella storia del pensiero occidentale i megarici hanno sempre rappresentato il rovescio perverso della metafisica): l’uomo è definito nel suo essere dal “potere di non”, un privilegio, quello della negazione, che gli deriva dal fatto eccezionale di “avere il linguaggio”. Non è un caso che l’eroe agambeniano per eccellenza sia Bartleby lo scrivano di Hermann Melville, il quale, come in un quadro di Hopper, se ne sta in meditazione alla finestra del suo ufficio newyorkese, davanti ad un muro cieco, salmodiando il mantra perfetto della inoperosità: I would prefer not to, avrei preferenza di no, come ha tradotto Celati…
Non c’è dubbio che Agamben nel biopotere veda la minaccia definitiva portata al cuore dell’umano modo d’essere. È allora per coerenza con le premesse del proprio pensiero che egli ha letto nella risposta politica alla pandemia (reticolazione dello spazio sociale, limitazioni delle libertà personali, screening di massa, medicalizzazione coatta ecc.) una verifica della sua tesi metafisica. Se “il potere non ha oggi altra forma di legittimazione che l’emergenza”, il virus è infatti la tempesta perfetta. Non credo che Ivan Illich si sarebbe espresso diversamente se avesse potuto essere testimone della nostra attuale catastrofe. Non ha perciò alcun senso, oggi, rinfacciare ad Agamben, scandalizzati, la sua coerenza, anche se le equivoche alleanze che si stanno stringendo nel nome di queste tesi sul biopotere non possono non suscitare giustificati allarmi (si rileggano, a questo proposito, le cronache americane di Alessandro Carrera pubblicate su questo sito e si scoprirà, non senza un certo disagio, quanto la critica foucaultiana, illichiana e agambeniana del biopotere possa giustificare sul piano teorico il rifiuto della estrema destra americana della riforma sanitaria di Obama, il negazionismo sul Covid, l’antivaccinismo, l’antiscientismo, il disprezzo per la competenza, ecc.).
La questione, filosoficamente parlando, è un’altra. E se il biopotere, ci chiediamo, che si affaccia all’orizzonte con il Covid, avesse subito una mutazione, proprio come accade ai virus, e non fosse più il biopotere stigmatizzato da Foucault, Illich, Agamben? Nella sua definizione standard, comunemente accettata, il biopotere è la presa in gestione integrale della “nuda vita”. Il biopotere è il sogno o, se si vuole, l’incubo di poter “produrre” la vita: non più riceverla come un “dono”, come pretende una stantia saggezza, non più parteciparne nei limiti del possibile, come credevano gli antichi, ma letteralmente generarla a partire da un punto zero, vale a dire da quella soglia illocalizzabile occupata dal “sovrano” nello “stato di eccezione”. La definizione calza a pennello per la delirante immagine dello stato sociale che hanno gli elettori di Trump come per l’eugenetica nazista, ovvero per strutture (reali o immaginarie che siano) che sono strutture di “dominio”, che hanno il loro paradigma, non a caso, nella libera creazione di un ordine da parte di un Dio onnipotente, di cui il sovrano con la corona in testa è solo la replica terrestre o, forse, l’inconfessabile prototipo. Ma ha veramente ancora senso usare questo paradigma tutto novecentesco per la nuova “biopolitica” del tempo del Covid? La biopolitica appartiene tutta al genere “dominio”?
Intendo con il termine “biopolitica”, anch’esso mutuato da Agamben e soci, quell’agire collettivo cui siamo obbligati se vogliamo far fronte come specie ad eventi ecologici di nuovo tipo, trascurati o ignorati prima che la crisi generata dall’antropocene li mettesse al primo posto nell’agenda pubblica, eventi di cui il virus planetario è, purtroppo, solo il primo esempio. Il virus, è stato giustamente detto, ci interpella non come popolo ma come popolazione nel senso che questo termine prende in zoologia e nelle scienze statistiche ed è proprio come popolazione che siamo chiamati dal virus ad agire politicamente nella Città. Come nel racconto di Kafka, la trasformazione è radicale. La posta in gioco ora è una biopolitica che non sia biopotere, che non sia dominio sulla “nuda vita”. È infatti come viventi e non come soggetti liberi e sovrani che, dalla situazione, siamo chiamati a farci carico della vita che tutti viviamo, una vita che si presenta con il tratto dell’indisponibile e del necessario. Ed è come viventi una vita fluida, irriducibilmente anarchica e “nuda”, che dobbiamo soggettivizzarci “politicamente” se vogliamo “governare” il cambiamento che ci trascina come un mare in tempesta. Forse avevano ragione Deleuze e Guattari nella loro lettura anticonformista del racconto di Kafka: lo scarafaggio-cimice Gregor Samsa potrebbe rappresentare positivamente anche una “linea di fuga” politica…
Dopotutto, bisogna sempre tener presente che il virus ha falsificato la tesi metafisica della eccezione umana; ha ricacciato l’“essere della lontananza” della retorica heideggeriana nella immanenza sconvolgente della natura. Ha sconfessato il suo aristocratico “potere di non” per assegnargli, come tratto caratteristico, un più servile e plebeo “non poter non”. Ha messo in mora l’illusione del “dominio”, un’illusione di cui erano imbevute tutte le immagini del potere sovrano, sia che esso avesse la forma classica del potere della spada, vale a dire, come scriveva Foucault, del potere di uccidere e di lasciar vivere, sia che assumesse, invece, l’aspetto “moderno” del potere di promuovere la vita, di curarla e di gestirla e infine di produrla come “vita umana” eliminando sistematicamente tutto quanto ne screzierebbe il cristallo. Ciò che resta, come compito politico, è l’arte umile del governare, la “cibernetica” (nell’accezione antica), servendo e ubbidendo a una “nuda vita” che non è davanti a noi, a disposizione, come un oggetto, ma in noi, come un soggetto, un soggetto però sempre più antico e sempre più giovane di “noi” che, come tutte le cose di questo mondo, non possiamo che “passare”.