Il Bergson di Federico Leoni / L’organo della stupidità
E se l’intelligenza fosse l’organo della stupidità? Se ci fosse bisogno di giustificare la filosofia, mostrandone non solo l’utilità, ma, direi, la necessità, basterebbe fare riferimento a questa domanda che solo un filosofo parlando da filosofo può sensatamente porre, giacché in qualsiasi altro contesto apparirebbe poco più di un mot d’esprit. La ritroviamo al centro del saggio che Federico Leoni dedica a Henri Bergson (Henri Bergson. Segni di vita, Feltrinelli, Milano 2021). Coerentemente con lo spirito della collana Eredi che lo ospita (ideata da Massimo Recalcati), il Bergson di Leoni non è un capitolo di un manuale di storia della filosofia. Bergson è piuttosto un “intercessore” in senso deleuziano, vale dire una sorta di Stalker tarkovskiano che funge da guida nel territorio accidentato del pensiero in atto: “Non è mai del tutto chiaro, scrive Leoni, dove ci porterà la sua chiarezza così ordinata e spoglia. Nessuna enunciazione filosofica novecentesca è stata così enigmatica, cangiante, imprendibile” (p. 12). Che sia una vecchia foto d’epoca a inaugurare il saggio è sintomatico del carattere ad un tempo archeologico e sperimentale dell’esplorazione filosofica condotta da Leoni nel territorio del bergsonismo.
Dunque, non è propriamente Henri Bergson (1859-1941) l’oggetto di questo studio, ma il bergsonismo come stile di pensiero, quello che meglio, secondo Leoni, sa surfare sull’onda della vita instancabile generatrice di imprevedibili novità. Ed è perché Leoni prova a pensare con Bergson, mimandone il gesto, senza troppo preoccuparsi di rendere conto della genesi dei concetti che ne hanno decretato la fortuna, che il filosofo-erede può formulare quella strana domanda. Essa suppone l’ipotesi leibniziana della continuità, una ipotesi su cui Leoni ha lungamente indugiato nei suoi scritti più recenti (L’automa. Leibniz, Bergson, Mimesis, Milano 2109; Jacques Lacan. Una scienza dei fantasmi, Orthotes, 2019). Che ne è del soggetto, si chiede Leoni, che ne è di ogni soggetto senza eccezioni, dall’ameba al ragno all’uomo, se il suo proprio, espresso dal verbo “essere” (S è P), non è una identità ma la continuità di un processo in atto? Che ne è dei suoi predicati se questi non sono ciò che esso “ha” a distanza e di cui dispone liberamente, ma sono ciò che esso “è” e non può non essere (è la grande tesi leibniziana: i predicati ineriscono al soggetto in ogni proposizione vera, contingente o necessaria che sia)?
Questo soggetto, Leoni lo chiama l’automa e ne fa il personaggio concettuale dell’originalissimo romanzo filosofico che da almeno un decennio sta scrivendo coniugando, in uno stile scintillante, psicoanalisi lacaniana e fenomenologia radicale (radicale perché asoggettiva), strutturalismo e, appunto, bergsonismo.
Non bisogna cercare l’automa tra le macchine, come ci verrebbe naturale fare. Queste semmai ne sono i duplicati prodotti dall’intelligenza. E come tutti gli artifici intellettuali, prodotti assemblando parti in vista di un progetto, risultano largamente deficitarie. Piuttosto, seguendo una indicazione bergsoniana, il suo archetipo va cercato tra gli insetti. La metafisica del bergsonismo è, infatti secondo Leoni, una “metafisica degli insetti” e “gli insetti sono lo spirito” del cosiddetto spiritualismo di Bergson. Siamo qui al cuore del saggio di Leoni, che è uno strano bestiario dove gli insetti la fanno da padroni. Ciò che il nostro dire nomina “ragno” o “vespa”, lasciando intendere con tali “segni” che vi sia realmente una qualche identità stabile supporto di predicati, non è altro che il divenire dei suoi organi-strumento: il ragno è infatti in assoluta continuità con le sue zampe, con la sua tela, con il suo nido e… con la sua vittima, che sa immobilizzare all’istante e tenere in vita in un’atroce agonia per nutrirsene, meglio di quanto farebbe il più abile è il più crudele degli anestesisti immaginato da Tom Six di The human centipede.
La vespa “è” il bruco che uccide, il bruco “è” un suo (della vespa) organo-strumento e non metaforicamente. Naturalmente vale anche la reciproca: la potenza passiva del bruco di essere trafitto dal pungiglione della vespa “è” immediatamente, senza pause, senza esitazioni e senza margini di errore, la potenza attiva della vespa di trafiggerlo all’istante. Già Aristotele, aveva sostenuto che dalla compresenza simultanea di potenza attiva e potenza passiva si genera automaticamente una sostanza sensibile. In questo caso la potenza non può non passare all’atto, la potenza, come sostenevano gli antichi filosofi megarici, non ha altra dimensione che nell’atto. “L’automa, scrive Leoni, è il nome di una potenza che transita sempre in atto” (p. 126).
Per spiegare l’automatismo Bergson, in pagine celebri della sua opera più nota (L’evoluzione creatrice del 1907), faceva riferimento alla fatalità e all’inesorabilità dell’istinto che non manca mai il bersaglio, nella misura in cui l’istinto “è” immediatamente il suo bersaglio. È a questo livello dell’interrogazione che Leoni avanza allora la sua specifica questione: in che rapporto, si chiede, l’intelligenza critica, vanto della specie umana e (apparente) segno della sua eccezionalità, sta con l’automatismo implacabile del vivente? E dato che per noi l’istinto rappresenta il contrario dell’intelligenza critica, in che rapporto stanno intelligenza e stupidità? Già il fatto che siano dei contrari suscita qualche problema. A differenza egli opposti, i contrari implicano un genere comune di cui scandiscono la massima divergenza. Che razza di genere è, allora, quello che li comprende nel suo seno? C’è forse una continuità misteriosa che concatena il determinismo inflessibile dell’insetto all’essere umano libero e razionale? C’è forse un formicaio latente in ogni società civile sviluppata, così come la parte più antica del nostro cervello è ancora quella di un rettile? Ma se è così che senso ha chiedere poi all’intelligenza critica di rimpiazzare l’istinto, quasi fossero due opposti? Il raffinato individualismo degli intellettuali illuministi e la pancia delle plebi partecipano del medesimo genere, a velocità differenti, secondo ritmi diversi. Più contratto quello delle viscere popolari che secernono immediatamente un’azione, senza riflettere; quasi azzerato, invece, il movimento dell’intelligenza critica che “esita”, amleticamente, davanti al da farsi, interrogandosi sulle migliori ragioni per agire (senza mai trovarne veramente una più potente di un'altra).
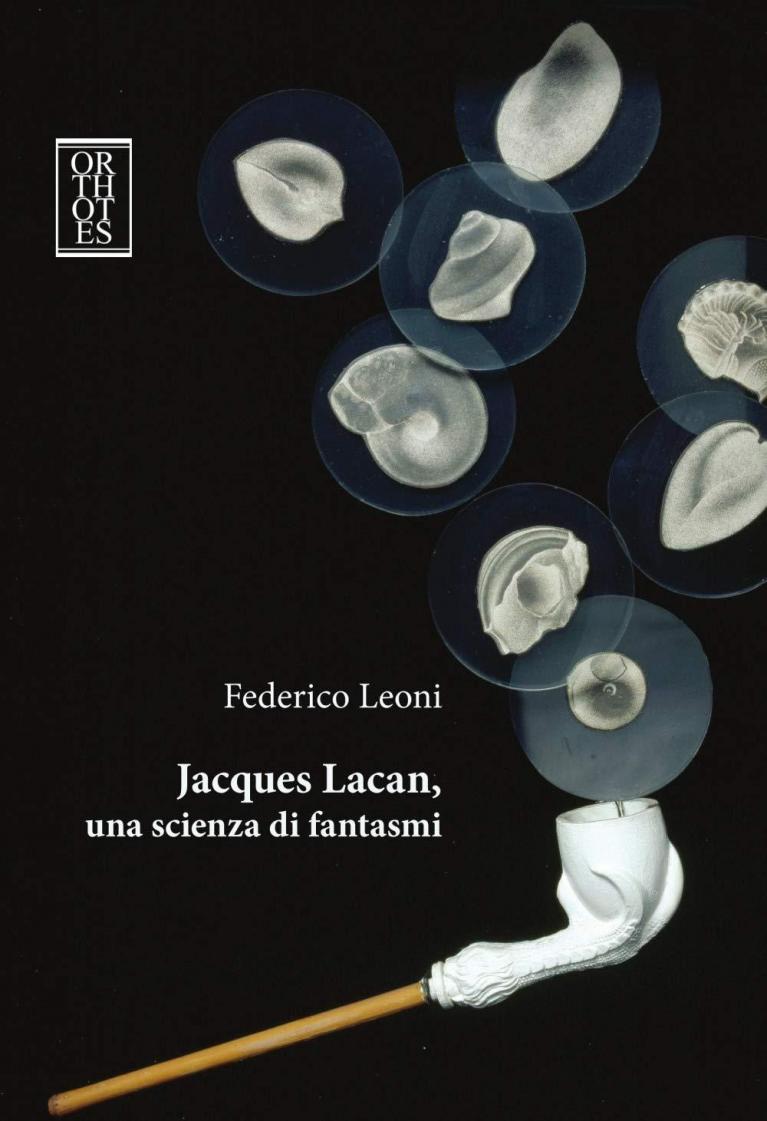
La risposta di Leoni a questi interrogativi metafisici (ed etico-politici) è una risposta deleuziana, del Deleuze lettore e interprete di Leibniz (La piega. Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino 2004). La risposta è la “piega” che è la metafora utilizzata da Leibniz per illustrare il “labirinto del continuo”. L’intelligenza è infatti per Leoni il ripiegarsi dell’“opaca perfezione dell’organismo” su se stessa, una “impronta che l’automa stesso deposita nel fondo della sua plasticità”. “La stupidità, continua, non è altro che la materia destinata a camminare dentro se stessa in forme intelligenti, cioè secondo distanziamenti da sé via via differenti, secondo auto-oggettivazioni sempre nuove” (p. 128). L’intelligenza è insomma la stupidità dell’istinto che si guarda allo specchio, dal di fuori, e che si cerca in quella immagine riflessa, in cui ormai non è più. A prima vista, Leoni sta qui avanzando un’ipotesi iperclassica e assai diffusa nel pensiero contemporaneo, da Sartre a Lacan a Sini: l’intelligenza, sembra dire, è riflessione, mentre l’istinto è immediatezza. L’uomo sarebbe allora quell’essere specialissimo che pone a distanza da sé quella vita che è immediatamente per ritrovarla davanti a sé come oggetto di una ricerca infinita e sempre deludente nei suoi esiti: la ritroverà infatti invertita in segni che rinviano sempre a un’assenza di principio.
All’inizio della sua Introduzione alla metafisica Bergson lo dichiara apertamente: non è attraverso i segni che si può infatti giungere a “toccare” il reale. L’intuizione del reale non è faccenda “simbolica”. Tuttavia, la riflessione così intesa – e, direi, così “umanizzata” – non è propriamente una piega del tessuto. Piuttosto è una discontinuità, una negazione, un vuoto che interrompe in un punto critico il fluire immediato della vita. La riflessione-piega si fonda invece sull’ipotesi della continuità. Ripiegandosi non si nega nulla, l’automatismo non si inceppa e continua a funzionare. Le pieghe non sono tagli, sono inflessioni di uno stesso tessuto che non cessa di ripiegarsi. Il che significa che a sostenere, a spiegare e a generare il ripiegamento riflessivo è ancora il cieco automatismo del vivente: l’intelligenza, scrive Leoni, si alimenta con “il carburante dalla stessa stupidità fondamentale, non smette mai di percorrere lo spazio inevadibile dell’automa” (p. 128). L’automa è il fondamento che non smette mai di fungere nel fondato. Un fungere che è un pulsare ritmico. L’intelligenza critica è così un “modo” dell’automatismo irriflesso, una sua peculiare “velocità”. La “stupidità” è il fondo dal quale essa emerge, protendendosi, e al quale l’intelligenza sempre, in qualche modo, ritorna, seguendo le vie traverse della “semiosi”. È questa la tesi audace dell’intelligenza come organo-strumento della stupidità che Leoni enuncia confrontandosi con uno degli aspetti meno frequentati di Bergson, la sua filosofia della tecnica.
L’intelligenza è un “organo”. In greco organon significa “strumento”. Che cosa sia propriamente un “organo” è stata una delle preoccupazioni costanti della ricerca di Leoni, fin da Habeas corpus (Bruno Mondadori, Milano 2007) che poteva essere letto come un trattato di “organologia” o, come forse sarebbe meglio dire, di “organogenesi”. Lo pseudopodo dell’ameba ne è l’esempio puro. Al tempo stesso piede, bocca e stomaco esso è un organo momentaneo (è “situazionista”, scrive Leoni). Si protende in “esteriorità” quel tanto che basta per assicurare una “presa” perfetta sull’ambiente che, come scriveva un altro filosofo bergsoniano, Alfred N. Whitehead, la “soddisfi”. Bisogna immaginare questa “perfezione” come una irrelatezza di principio, come una chiusura autistica sempre riconquistata e sempre mantenuta dal vivente. Lo strumento organico, scrive Bergson, “chiude come l’istinto il cerchio dell’azione in cui l’animale si muoverà automaticamente”. Leoni commenta: “L’automatismo nomina nel modo più preciso il funzionamento dell’organo in quanto il corpo ‘è’ quell’organo e quell’organo ‘è’ il corpo” (p. 125). Nella lingua degli uomini questa assenza di mondo e di relazione definisce però la “stupidità” ed è stigmatizzata come “mostruosa”. Heidegger definiva infatti “stordita” la presunta esperienza dell’animale (Concetti fondamentali della metafisica, Il melangolo, Genova 1992). Il modo d’esser dell’animale era inteso da lui difettivamente a partire dal modo d’essere umano: se quello è immediatamente il suo corpo e i suoi organi, l’uomo, e solo l’uomo, non è immediatamente ciò che è, ma lo “ha” a distanza, vi inerisce differendovi. Lo può fare perché abita il suo corpo come un colono si insedia in una terra straniera (non è mai stato sufficientemente indagato il modello coloniale della psicologia metafisica, da Platone ad Heidegger).
Ma, ricorda Leoni, qualcosa come un interno, un chiuso e un senza luce, si danno solo per uno “sguardo” che lo investa dal di fuori, per uno sguardo “coloniale” addestrato a distinguere sostanze e accidenti, cose e predicati che ineriscano loro differendone (S è P perché S non è P sennò come potrebbe S avere, possedere P?). Fin dalla prime righe del Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), Bergson insiste sul fatto che solo nell’orizzonte del dire predicativo il reale ci appare attraversato da quei dualismi che sono la croce e la delizia della metafisica. Anche quello sguardo logicamente attrezzato, che giudica il mondo, rubricandolo in categorie (sostanze e accidenti), è tuttavia un “organo”. Anch’esso, a suo modo, è situazionista come lo era nella sua scioccante elementarità lo pseudopodo dell’ameba. Anch’esso, a suo modo, è un “modo” dell’automa che sempre siamo e non possiamo non essere.
Bergson ha mostrato mirabilmente come l’intelligenza sia una funzione della vita (un organon). Ha una genesi tutta pragmatica e, per questo non le si possono assegnare compiti di pura speculazione: quello che ci mostra, insomma, non è il vero, non è l’“in sé” delle cose, semmai è delle cose il loro “per noi”, la loro faccia più interessante per i nostri scopi. Tuttavia l’intelligenza è organo “situazionista” secondo una modalità inedita, che segna la differenza tra evoluzione naturale e storia, tra la “natura” e quel primate eccezionale che noi siamo. Si considerino i prodotti più semplici dell’attività intelligente, grazie ai quali il paleontologo riconosce infallibilmente la presenza di una forma umana di vita: la selce scheggiata o la ciotola d’argilla. A differenza dello pseudopodo, infatti, che è un organo internamente prodotto, questi, come il bastone del primate, sono “strumenti inorganici”.
L’intelligenza è fabbricatrice, La sua dimensione è poietica, essa produce oggetti trascendenti che, una volta generati, acquisiscono autonomia e capacità normativa. Significa forse questo che c’è una cesura tra natura e artificio, che il regno dell’intelligenza comincia dove tramonta quello dell’istinto? Nient’affatto. La risposta di Leoni, lettore di Bergson, è che la tecnicità dell’umano è ancora organica, sebbene l’organo non sia interno ma prodotto in esteriorità e come esteriorità. La tecnica, insomma, come organo del vivente, l’organo come piega dell’automa, il linguaggio, i segni, la semiosi, l’informazione come strumenti della natura naturante.
Che ne è allora del soggetto in questa prospettiva? Si apre qui, credo, uno sconfinato terreno di ricerca metafisica sul quale vale veramente la pena avventurarsi se si crede nella possibilità della filosofia. A dover essere revisionata e criticamente congedata è quell’immagine superstiziosa del soggetto che se lo raffigura come il rovescio simmetrico dell’automa. La “metafisica degli insetti” di Leoni entra di fatto in collisione con la linea maggioritaria del pensiero filosofico contemporaneo e italiano in particolare che del “potere di non”, della possibilità sciolta dalla sua realizzazione, della libertà sovrana ha fatto la cifra della “sovranità” del soggetto, un soggetto, beninteso, esclusivamente umano. Non è un caso se, salvo rare eccezioni, il bergsonismo sia stato così a lungo assente nel dibattito filosofico italiano o sia stato considerato con sufficienza, come se difettasse di quella profondità “abissale” di cui si compiace il “pensiero negativo”. Il saggio di Leoni ci restituisce, invece, un Bergson filosofo della superficie capace di seguire con la propria arte da surfer (che Bergson chiamava arte della nuance) il flusso inarrestabile della vita che non può che vivere.









