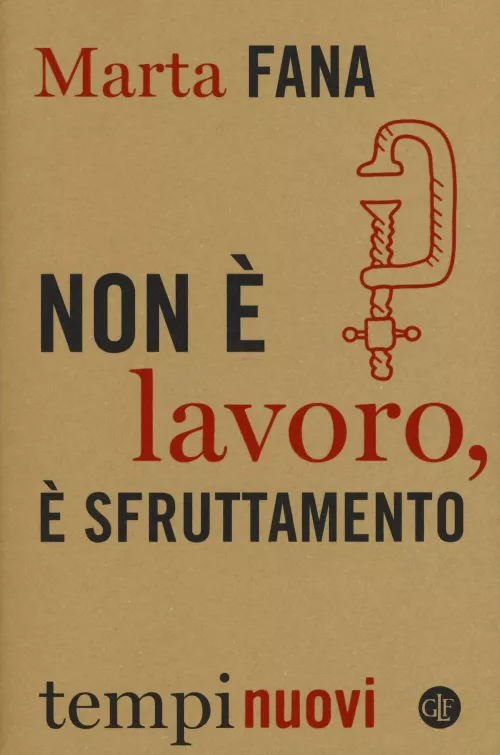"Non si esce vivi dalla precarietà. Non si esce vivi da soli” / Non è lavoro, è sfruttamento
Marta Fana, dottore di ricerca presso l’Institut d’Études Politique de SciencesPo a Parigi e giornalista, ha scritto un libro che, giunto alla terza edizione in poche settimane, è diventato occasione per tornare a discutere della condizione del lavoro in Italia. Si intitola Non è lavoro, è sfruttamento con involontario ossimoro, poiché, evidentemente, il lavoro è sempre sfruttamento. Benché infatti abbia fondato la possibilità per gli individui di uscire da relazioni di servitù e la possibilità di “esistere per sé stessi”, tuttavia, a partire dall’avvento del sistema di produzione capitalistico, esso è attività comandata (“lavoro comandato,” nell’espressione di Adam Smith), cioè, anche e soprattutto, fonte di ricchezza per altri. Certo, Marx non era arrivato a immaginare un mondo nel quale l’accumulazione sarebbe stata capace di crescere pur evitando di pagare del tutto (o quasi) la “merce” per eccellenza, “la madre di tutte le merci” come l’ha definita Sergio Bologna, cioè esattamente il lavoro. Processo che si sta traducendo in un’esplosione esponenziale della dinamica dello sfruttamento che si scarica sugli esseri viventi e sulle risorse naturali, con creazione di profitti smisurati che non generano alcuno sviluppo per il pianeta e i suoi abitanti ma solo il dilagare della diseguaglianza e della sofferenza.
A partire da storie esemplari e da dati statistici che maneggia con sapienza, Marta Fana descrive l’asprezza di un paesaggio dove prevalgono l’assenza di tutele e di stabilità lavorativa e il male che creano, nelle vite di milioni di persone, l’ingiustizia sociale e la cancellazione di diritti su cui si fonda il neoliberismo, nello smantellamento della funzione regolatrice dello stato sociale. L’autrice parla di una “trasformazione antropologica e culturale del lavoro subordinato mascherato dalle collaborazioni” segnatamente nella “logistica, grande distribuzione e servizi pubblici” ma fa riferimento anche ai “lavoretti della gig economy, il lavoro gratuito, il lavoro a chiamata e il sistema dei buoni lavoro”, scelti quali “esempi più significativi della ristrutturazione del capitalismo dove la frammentazione del lavoro segue la frammentazione del processo produttivo”. All work and no pay, ovvero precarizzazione esistenziale, fondata sullo sfruttamento delle esistenze che sono sostanza dei processi di accumulazione del capitalismo finanziario, declino della società del lavoro salariato e generalizzazione della remunerazione simbolica che, da sempre, è income della riproduzione sociale, direi nel mio linguaggio.
In un testo di San Precario, pubblicato alla fine del 2013, si sottolinea la negligenza con cui la sinistra politica e sindacale, ma anche la maggior parte dei cosiddetti movimenti, hanno avvicinato il fenomeno della precarietà: “I movimenti più organizzati hanno adottato la retorica della precarietà apportando semplicemente correzioni contestuali o terminologiche senza cambiare la struttura del proprio agire e neanche investendo davvero sui nuovi soggetti. Si parla di precari, magari, ma si cerca sempre il nuovo proletariato e dietro di esso si prova a scorgere la classe operaia”. Si tratta di un atteggiamento non nuovo “a sinistra”, che ha spesso avuto la tendenza a selezionare alcuni settori della “classe” come soggetti rivoluzionari, relegando altri (per esempio le donne) al mero ruolo di supporto per le lotte che questi settori portavano avanti. L’oggetto della questione – si aggiunge – vale a dire la precarietà è stato nominato da tutti ma il soggetto precario mai veramente visto.
Un libro come quello di Fana ha il grande merito di tornare ad aggirarsi nei dintorni della giungla precaria. Lei parla piuttosto di “una discesa agli inferi” tra vaucher, lavoro a chiamata e lavoro intermittente. Fornisce un’immagine nitida e perciò terribile del lavoro povero e del “furto quotidiano di diritti e salari”, con una denuncia precisa delle responsabilità politiche dello stratificarsi delle forme dell’esclusione, all’interno del laboratorio italiano che per primo, in Europa, ha proceduto a riforme strutturali volte alla liberalizzazione del mercato del lavoro.

Tuttavia, anche in questo caso il riferimento rischia di essere più alle difficoltà del modello del lavoro salariato (legato al modello produttivo industriale) che ai problemi contemporanei della esperienza precaria e delle nuove frontiere della valorizzazione postfordista. Lavoro e produzione non hanno più rapporti reciprocamente definiti e riconosciuti, poiché non si danno più nelle esatte forme fissate nel fordismo. La produttività e i tassi di attività possono essere misurati nelle forme tradizionali e convenzionali? Non solo in Occidente ma in tutti i contesti del pianeta, non esclusi la Cina o il Rwanda, si allarga il peso del capitale sociale, culturale, simbolico, mentre l’intoppo del ciclo tradizionale di crescita è dovuto alla concomitanza di più cause: ruolo delle tecnologie; contrazione del tempo di lavoro necessario; crisi degli apparati industriali tradizionali; saturazione dei mercati. La barriera tra lavoro/non lavoro, occupazione/disoccupazione, incardinata sul rapporto salariale, si è seriamente incrinata, e non si tratta di camouflage ma, appunto, di un processo di profonda ristrutturazione del capitale e dei suoi assetti organizzativi che hanno innescato lo sgretolamento della società salariale e dei suoi assi principali (lavoro, famiglia, welfare). Dunque né l’etica del lavoro, né il salario come misura del valore, né lo Stato-nazione come luogo topico del “pubblico” e dell’“universale” mi paiono reggere l’urto a cui sono stati sottoposti drasticamente con la fine del Novecento.
Si è reso del tutto manifesto l’inserimento nelle catene del valore di atti fino a ieri non catalogati sotto la nozione di lavoro (riprodurre, curare, consumare, informare, formarsi, relazionarsi, interagire). La trasformazione del paradigma produttivo, fondato su una nuova convenzione tecnologica, fa sì che agendo nelle connessioni nel mondo digitale – generiamo dati, “produciamo” contenuti – venga creato valore di scambio (profitto), cambiando di segno al valore d’uso. Per tale ragione, ritengo che, a questo punto della storia, le ispirazioni femministe sul ruolo della riproduzione non possano mai essere dimenticate e anche che possano dialogare efficacemente con le teorie del capitalismo biocognitivo e relazionale, a differenza di altri chiavi di lettura che si mantengono pervicacemente dicotomiche.
Il lavoro, insomma, non ha una sostanza, un significato, un contenuto e un senso univoco, omogeneo, e identico, in tutti i tempi e in tutti i luoghi e dobbiamo finalmente considerare la possibile varietà dei lavori (manufatti; artefatti; mentifatti), di donne e di uomini, che si è fatta esplicita. Le forme abbozzate (e del tutto inadeguate) di salarizzazione della riproduzione, si innestano sul tramonto di un modello di società occidentale basata sul lavoro produttivo maschile.
Non v’è dubbio che tale panorama ci ponga di fronte a un più largo spettro di una rinnovata rapina, nell’arroganza di un potere economico che sembra non conoscere limiti e di un potere politico che ha accondisceso a disarmare tutte e tutti, smontando forme di assicurazione collettiva frutto di decenni di lotte. Fana coglie con passione la gravità del problema. Per uscire dai gorghi del liberismo che ha favorito le sorti dei “nemici della classe lavoratrice”, l’autrice illustra una serie di proposte, che vanno dalla messa al bando di tutte le forme di lavoro gratuito e precario, a partire dalle leggi che le hanno prodotte, dal Pacchetto Treu al Jobs Act, a una battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro accompagnata da un aumento delle retribuzioni più basse, alla introduzione per legge di un salario minimo. Ad esse si accompagnano idee relative alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore pubblico e nei servizi alla persona. Ha ragione quando afferma “non si esce vivi dalla precarietà. Non si esce vivi da soli”, ma, per le ragioni succintamente esposte sopra, vedo davvero poco adeguata alla sfida una battaglia per tornare alla “subordinazione del lavoro”.
Porrei grande attenzione al rischio di ribadire ancora un collegamento naturale tra la dazione di un diritto e il lavoro e con ciò all’aggiunto pericolo di favorire involontariamente forme di workfare che oggi sempre più spesso condizionano esplicitamente gli aiuti sociali all’obbligo di lavorare. Per fare un esempio, un recente articolo di Nathalie Shure pubblicato su Jacobin nota come negli Stati Uniti le donne siano state sempre le più svantaggiate da una carente copertura sanitaria solo collegata all’impiego.
Abbiamo bisogno di nuove forme del diritto, del riconoscimento, di nuovi modelli di assicurazione sociale collettivi, cioè di nuovi modelli di welfare, adeguati alla riproduzione-produttiva e dunque abbiamo necessità di nuovi sistemi distributivi, di un’idea di sviluppo ecocompatibile, capace di affrontare lo snodo dell’esigenza (e delle potenzialità) di meno lavoro tradizionalmente inteso, più sapere circolante, più connessioni, più articolazioni delle scelte e delle forme di vita. Questi anni di terribile crisi hanno impattato sui livelli di reddito e generato crescente impoverimento ma ciò non deve indurci a rimpianti e passatismi, rinunciando a continuare a concepire maggiore libertà, più diritto all’autodeterminazione, più tempo, più ampie espressioni del desiderio.
L’immenso problema di generazioni che, per la prima volta nella storia, vivono condizioni materiali peggiori dei loro genitori non può essere eluso ma bisogna pure accennare alla differenza che si avverte nel confronto tra la catena di produzione dell’era fordista, con le sue mansioni standardizzate e i suoi ruoli, a quella che inserisce manifestamente fattori relazionali e cognitivi, sessualità e socialità, nei contenuti della prestazione lavorativa. Liberare l’umanità in nome dell’eguaglianza ha un significato diverso dal ripensare eternamente alla classe “come motore della storia” e al rischio di ricondurci a omogeneità. Non c’è libertà senza differenza e da questo punto di vista debbo ammettere di temere, con Silvia Federici e Nicole Cox (Contropiano dalle cucine, 1975), che la lotta che, ancora una volta, si promette a chi è “senza salario”, ai “sottosviluppati”, finisca per essere “una lotta […] per uno sfruttamento più razionale e produttivo. Ci offrono non solo il diritto al lavoro (questo lo offrono a ogni lavoratore) ma il diritto a lavorare di più, il diritto a essere maggiormente sfruttate”.
Ricordo qui l’ultima parte di un saggio di Deborah Ardilli che, proprio a partire da Federici e da Contropiano dalle cucine, arriva alle vite precarie di Judith Butler e al livello strategico rappresentato dalla riproduzione sociale: “Le lotte per trasformare il campo sociale della sessualità acquistano importanza economico-politica non soltanto perché possono essere direttamente collegate alla questione dello sfruttamento e del lavoro non pagato, ma anche perché non si lasciano nemmeno decifrare senza includere nella comprensione della sfera economica tanto la riproduzione di merci quanto la riproduzione sociale di persone”. Detto in altri termini, abbiamo oggi l’occasione di ripensare il politico “a partire dalle condizioni precontrattuali, mai espressamente stipulate, della relazione sociale: che cosa c’è dietro la svalorizzazione e la distribuzione differenziale della precarietà?”.
Che cosa c’è dietro, quale valutazione politica aggiungere? L’obbligo politicamente vitale di affrontare il tema del reddito di base incondizionato, andando oltre l’istituto del salario: ai sindacati va semmai domandato un responsabile impegno in tal senso, più dirimente di quello di ammettere il salario minimo – che comunque al reddito va accompagnato. Si cerca di prendere per fame, con povertà e debito, la soggettività precaria, raccontata solamente come disgraziata proprio per comprimerne e frustrarne l’autonomia. Né può più essere quel lavoro per pochi, darwinianamente inteso nella società della prestazione, l’unica forma di salvezza e insieme di validazione del valore e della dignità dell’essere umano, l’unico veicolo della “cittadinanza” e dell’inclusione nello spazio pubblico. Va rifiutata l’immaginazione di un mondo che si configura senza fine sul suo carattere sessista, tende a tralasciare le forme di lavoro non alienato (il lavoro riproduttivo e le altre attività liberamente scelte) e abbandona il concetto di libertà dal lavoro che ha ottenuto un posto rilevante nelle epoche precedenti.
Come nota Alex Foti, saggista, tra i fondatori del collettivo Chainworkers e dell’EuroMayDay, in un libro estremamente interessante da poco pubblicato in inglese, General Theory of the Precariat. Great Recession, Revolution, Reaction (liberamente scaricabile su Network Cultures), la soggettività precaria è tutt’altro che imbelle, ma la si guardi seriamente, davvero: è stata in grado di organizzare battaglie globali che hanno rimbalzato negli Stati Uniti, in Europa, nel Nord Africa, in Turchia: “Il precariato è stato l’avanguardia del 21esimo secolo, nelle Primavere Arabe, nel maggio spagnolo nel movimento Occupy e Blockcupy”.
Non tutto ha funzionato, perché il liberismo ha scatenato contro tali generosi e innovativi tentativi, una Grande Recessione e violente forme di populismo nazionalista, ma è in avanti che bisogna guardare. La soggettività precaria non costituisce una classe di ritorno né collima con le tassonomie di area anglofona (Great British Class Survey, 2013) che finiscono per rappresentarla come la più povera ed emarginata. “Dal punto di vista della divisione tecnica del lavoro”, scrive Foti, “il precario comprende per la maggior parte giovani che lavorano nell’informazione, nella cultura, nella formazione e nei servizi, dove trovano lavori intermittenti e subiscono il combinato ostile di oligopolio e oligarchia. Per quanto riguarda la composizione sociale del lavoro il precariato è composto da giovani, donne e migranti che si muovono in ambienti multiculturali, multigender e metropolitani”. Il cambio è in atto, dai blue collar ai pink collar: concordo con Foti, i salariati rischiano di rappresentare una retroguardia mentre, semmai, è il soggetto donna, paradigma incarnato delle vite precarie, ad aprire visioni. Contro lo sfruttamento delle nostre vite, può aprirsi l’era della cooperazione del soggetto imprevisto?