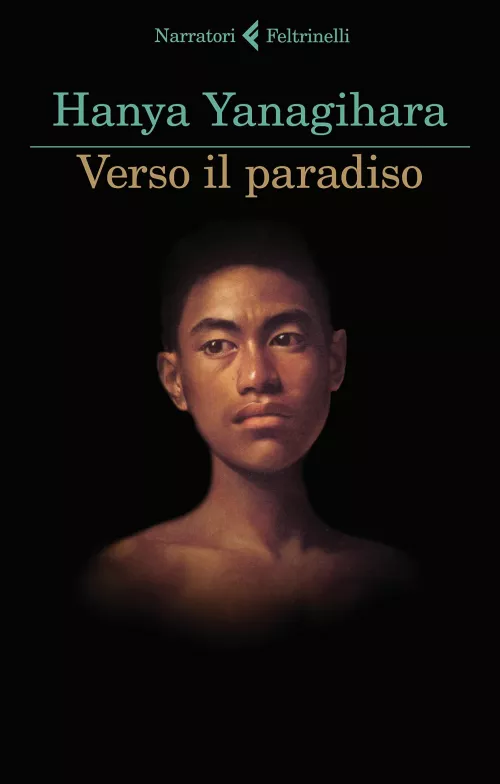Hanya Yanagihara / Verso il paradiso
Leggere Hanya Yanagihara in Italia è come leggere Lolita a Teheran: gli universi di cui si parla in quei libri non combaciano perfettamente con la cultura cattolica romana né con quella islamica. Sarà per questo che alla fine delle 768 pagine di Verso il paradiso (Feltrinelli 2022, traduzione di Francesco Pacifico), pur ammirati per l'accortezza con cui la scrittrice americana ha dipanato le tre storie che formano il volume (Washington Square, Lipo-wao-nahele e Zona Otto), si resta perplessi. Un romanzo dove il matrimonio tra omosessuali è "normale" fin dalla fine dell'800 (anzi, da prima: "Ecco un'incisione del 1793, che ritrae il matrimonio di Edmund con l'uomo con cui aveva vissuto fin dalla morte per parto di sua moglie, tre anni prima"), dove non esistono madri ma solo nonni, dove le unioni gay risentono della cultura degli stereotipi tanto che, leggendo, si ha sempre la sensazione che, nelle coppie, uno dei due uomini faccia la parte della donna, produce un suono falso, come quello di una campana rotta.
Nel 1800 usciva Washington square di Henry James, il racconto perfetto a cui Yanagihara sembra essersi ispirata, fin dal titolo, nella prima parte. Lì c'era una ragazza di buona famiglia che si innamora di un giovane, amore ostacolato dal padre che vede in lui un profittatore. Qui è uno scapolo vicino ai trenta che si innamora, nel 1893, di un ragazzo e chi mette i bastoni tra le ruote è suo nonno. Bisogna rimuovere dalla mente il meraviglioso racconto di Henry James (ma anche approfittare dell'occasione per rileggerlo), altrimenti la storia di David Bingham che il nonno ricco vorrebbe maritare all'altrettanto ricco vedovo Charles Griffith, mentre lui si innamora del musicista spiantato e sospetto parassita Edward, sembra una irresistibile parodia. La letteratura, come il cinema, ha questo di bello: può far sembrare vera qualunque storia e non è colpa nostra se qui facciamo fatica a credere al personaggio di David, corteggiato all'antica da uno più anziano di lui mentre, che so, rimaniamo totalmente invischiati nella veridicità di Midnight in Paris di Woody Allen, a proposito di salti di epoche, e ci pare perfettamente plausibile che Owen Wilson, ai giorni nostri, venga caricato da Hemingway su un vecchio macinino e portato a una festa dove incontra Picasso e Gertrude Stein.
Non si deve mai confondere la biografia di uno scrittore con la sua opera, è risaputo, ma di Hanya Yanagihara sappiamo troppe cose che, a noi smaliziati europei, provocano subito cortocircuiti rivelatori: per esempio, sappiamo che vive a New York, dove dirige il supplemento Moda & Design del New York Times e ce la immaginiamo circondata, tutti i santi giorni, da quella community intelligentissima e assertiva di gay che decretano cosa va e cosa non va, cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa bisogna mettersi, cosa si deve mangiare, dove bisogna andare. Forse anche cosa è meglio scrivere. Nella più assoluta buona fede, forse scambiando quel mondo autoriferito per la vita vera, Yanagihara si è assunta il ruolo di portavoce di questa minoranza, visto che la letteratura americana che oggi va per la maggiore, quella dei Philip Roth, dei De Lillo e dei Franzen sembra noiosamente eterosessuale.
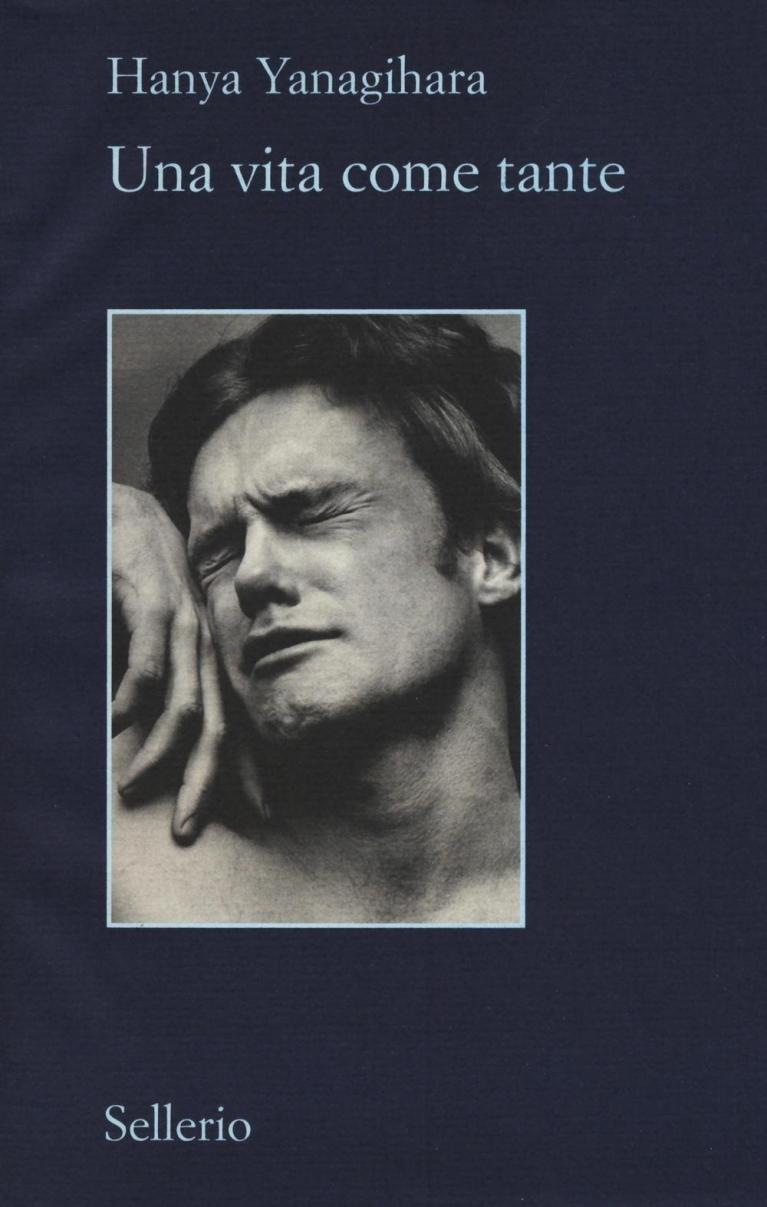
Così ha iniziato a scrivere la sua Recherche: Gli uomini degli alberi (2003), il suo primo libro, parlava di un medico accusato di molestie nei confronti dei figli adottivi; ma è stato con il secondo Una vita come tante (2015), la storia di un uomo abusato da piccolo e dei suoi tre amici gay, tutti ricchi, tutti di New York, che ha raggiunto il successo planetario e infatti a questo Verso il paradiso è stato riservato il trattamento vip: uscita contemporanea in America e in Europa, tour promozionali covid permettendo, edizioni multiple all'arrembaggio (questa di Feltrinelli è punteggiata da frettolosi piccoli refusi).
Se si vive nella megalopoli americana, in belle case piene di libri, se si esce poco la sera e solo per andare a cena in posti gourmet o in attici nell'upper east side, protetti da una confortevole ideologia woke, è naturale stare all'erta verso tutte le ingiustizie e prendersi in carico il fardello di rappresentarle. Hanya Yanagihara lo fa con grande impegno: in questo libro la parte che ci insegna qualcosa, che invece la critica ha trascurato, è quella in cui si parla delle Hawaii. Lei è nata a Los Angeles da una famiglia che aveva vissuto nelle isole per tre generazioni, ma non è di sangue hawaiano, essendo metà giapponese e metà coreana. Nel racconto Lipo-wao-nahele alcuni movimenti separatisti rivendicano le isole, contro l'annessione americana, per loro una "secessione". "Lo sapevo che parlavano di me e di casa mia: le palme di cartone, le felci legate in goffi mazzetti alle caviglie e ai polsi del selvaggio, il lei fatto di cannucce di plastica ritagliate e di fiori di carta di giornale. Era un costume alla buona, offensivo nella sua ridicolaggine. È questo che pensano di me, mi resi conto, la prima volta che Edward mi parlò di Lipo-wao-nahele". Come se l'io nascosto della scrittrice si facesse largo tra le righe (qui nel personaggio di un David: perché i nomi, David, Charles, Edward ricorrono nel romanzo associati a persone diverse, in tre diverse epoche, il 1893, il 1993 e il 2093) e dicesse finalmente la sua verità, che il politically correct genderless e antirazzista le ha imposto di nascondere, nel giochino degli stereotipi all'incontrario che infestano questo libro, controllato fino all'ultima riga.
La casa downtown del Bigham discendente della famiglia reale hawaiana sarebbe piaciuta a Susan Sontag per il suo saggio sul camp, piena com'è di artigianato e arte hawaiana, che diventano pretesto di un discorso più ampio sulla cosiddetta "etica della protezione", su chi decide cosa è meglio per le persone e per le culture, trasformando l'antropologia in superficiale intrattenimento e ridicolizzando le spinte di autoaffermazione dei popoli. Le tre parti sono una sorta di vortice che gira su se stesso, con i nomi dei personaggi ripetuti in ruoli differenti, così un David prima bianco poi lo ritroviamo nero, nell'attenzione reiterata di non offendere nessuno. Capita così che si dica, sempre di un David, che è "marxista" per ritrovarlo poi (forse) autore di un attentato terroristico dove resta ucciso insieme a uno dei suoi due padri (l'altro crederà o farà finta di credere che invece era entrato nel drugstore dove stava per esplodere la bomba, per urlare al genitore di fuggire).
Sono queste e altre semplificazioni che somigliano molto ai piatti della cucina internazionale serviti negli alberghi, che non soddisferanno mai un palato abituato alle infinite variazioni delle specialità regionali. Il sapore che resta in bocca è infatti inequivocabilmente wasp, per usare un acronimo di moda qualche anno fa, dove la sapienza dell'intreccio e l'invenzione felice dei personaggi che si susseguono rubandosi le identità sono indebolite dall'ingenuità, tratto poco perdonabile a uno scrittore: come se Yanagihara si facesse carico di salvare a tutti costi il mondo a colpi di buone intenzioni. C'era già in Una vita come tante, questo lato salvifico, questo senso di colpa, questo desiderio masochistico di espiazione senza Dio (qui traslati nella descrizione di lunghissime e molto punitive ondate di pandemie distopiche, proiettate alla fine di questo secolo, ma che somigliano a quella che stiamo vivendo) nel personaggio di Jude, l'avvocato gay che, dopo una vita passata a tagliarsi, alla fine delle 1091 pagine dell'edizione Sellerio, si uccide, smettendo finalmente di soffrire, come i più cinici tra i lettori hanno rilevato, tirando un sospiro di sollievo.