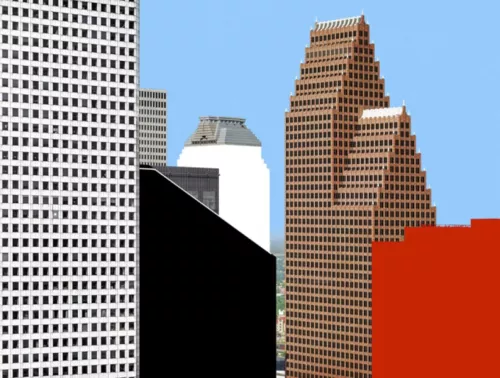Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo? / I paesaggi della nostra vita

Olivo Barbieri.
Paesaggio è una parola femminile o, almeno, al femminile. Non per la grammatica, ma per la vita e per la nostra appartenenza al nostro spazio di vita. Come il codice materno, il paesaggio ci contiene, è vulnerabile, ci accoglie e ci genera, se non lo consideriamo lo sfondo, il decoro o la cartolina, o se non lo collochiamo nell’impensabile, dandolo per scontato. L’equivoco della parola “ambiente” si mostra oggi in tutta la sua evidenza. Non è, infatti, qualcosa che sta là fuori, intorno a noi, ma è noi stessi.
Svetlana Aleksievic, Nobel per la letteratura 2015, parlando della letteratura e del genere letterario che predilige, scrive qualcosa che dice molto di più di quanto si possa immaginare, a proposito del paesaggio come linguaggio di cui siamo parte.
“A lungo ho cercato un genere letterario che corrispondesse al mio modo di vedere il mondo (…) E ho scelto quello delle voci degli uomini. Nei miei libri l’uomo ordinario parla in prima persona di se stesso. I miei libri li osservo, li ascolto per le strade, dietro alle finestre. A volte posso stare seduta tutto il giorno con la stessa persona. Per me è importante cogliere la parola al volo, sul nascere. Senza lasciarmi sfuggire quella parte discorsiva della vita che trattiamo con noncuranza e distrazione, e che poi scompare nella frenesia del quotidiano, nell’oscurità del tempo. Che tutto ciò possa diventare letteratura può sembrare singolare. Ma io vorrei che tutto quello che costituisce la nostra vita diventasse letteratura. Anche le parole del quotidiano” (la Repubblica, 25 aprile 2017).
Il paesaggio è un racconto che chi lo vive fa ad un altro giungendo a non trattare come scontato, con noncuranza e distrazione, l’aria, l’acqua, il suolo, il sistema vivente di cui è parte costitutiva. Il paesaggio è frutto della nostra considerazione, dell’accorgersi di esistere fermandosi a guardare, a respirare, a sentire, a pensare, camminando. Il paesaggio nasce dalle voci degli esseri umani che ne fanno parte.
A lungo abbiamo pensato che fosse solo un fatto di traduzione simbolica: che i luoghi fossero la fonte di una mediazione simbolica operata dalla mente umana che in tal modo generasse l’idea di paesaggio. Alla base di questo orientamento vi era e ancora vi è una concezione della percezione separata dall’azione e dal movimento, unitamente al primato della visione. Oltre al nostro andare fieri ed eretti, convinti come eravamo di essere sopra le parti e superiori al resto del vivente: tutto il resto era l’intorno, il panorama, la veduta, il contorno.
Abbiamo sufficienti elementi di verifica per sostenere l’ipotesi che le cose non stiano così.
Da non poco tempo gli artisti c’erano arrivati, anticipando – loro che vivono da poeti al di sopra della proprie possibilità – la ricerca scientifica.
Si consideri ad esempio Forme uniche della continuità nello spazio, l’opera di Umberto Boccioni del 1913, custodita al The Israel Museum di Gerusalemme, la celebre scultura icona della plastica cosiddetta futurista.

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913.
Azione e percezione nel rapporto con l’opera sono indistinguibili: lo sono nella contingenza emergente nell’esperienza di accoppiamento strutturale tra la dinamica della forma impressa dall’artista e l’azione del ripercorrere quella dinamica nella simulazione incarnata che vive il fruitore. Ognuno di noi di fronte all’opera sente di muoversi nella dinamica dell’opera stessa e agisce e percepisce allo stesso tempo. Ognuno vive allo stesso tempo un processo di modulazione intenzionale con le ombre e le luci delle forme e si scompone e ricompone in sintonia con esse.
L’azione non è un effetto collaterale della percezione e il movimento non è una conseguenza della cognizione, semmai azione e movimento precedono la cognizione e la traduzione simbolica, che ne sono profondamente informate. Ciò appare sempre più evidente anche a proposito delle probabili origini del linguaggio. Siccome pare che non vi sia continuità tra vocalizzi e linguaggio umano articolato, allora attendibile sembra la tesi di Noam Chomsky, in base alla quale la facoltà di parlare sarebbe sorta all’improvviso. E non come strumento di comunicazione ma come mezzo di autocoscienza (N. Chomsky, R.C. Berwick, Perché solo noi?, Bollati Boringhieri, Torino 2016). L’origine del linguaggio appare comprensibile in termini darwiniani se si considera la sua evoluzione non a partire dal porre al centro le sole aree cerebrali della comunicazione, ma considerando il ruolo e le funzioni delle aree senso-motorie. A livello neurofisiologico, il modo in cui si impara a produrre un manufatto è simile a quello con cui si impara a formulare una frase. L’utensile si crea a partire da una catena di operazioni, la frase a partire da una catena di parole: queste due attività condividono un medesimo sistema di regole, che viene appreso e gestito dalle stesse aree cerebrali. Lo stesso sistema senso-motorio pare essere coinvolto nella gestione del movimento nello spazio e, quindi, nella creazione del paesaggio e delle sue narrazioni.
È stato il primato della visione, ovvero la presunzione di quel primato, a nutrire la concezione del paesaggio come strettamente connesso al vedere. Franco Farinelli non si stanca di evidenziare gli effetti sulla nostra storia e sul nostro modo di concepirci e sentirci nel mondo derivanti dall’invenzione della prospettiva. La Terra ce la siamo inventata noi e dobbiamo reinventarcela. Seguendo il viaggio andata e ritorno tra mente e mondo in cui Farinelli ci conduce, abbiamo non poche possibilità di comprendere come vi sia una stretta connessione tra movimento e paesaggio.
Vi siete mai chiesti come si fa a farsi un’idea di una cosa che, per le sue dimensioni, non si riesce a vedere per intero? Si accettano le condizioni della conoscenza per noi esseri umani: “che noi non possiamo conoscere le cose per davvero, ma soltanto in figura, alla lettera geograficamente” (F. Farinelli, L’invenzione della Terra, Sellerio, Palermo 2016; p. 51).
Ma allora viviamo nella cosiddetta realtà o in una delle sue possibili e molteplici rappresentazioni? Se, come ci mostra con finezza di analisi Farinelli, Anassimandro, il filosofo greco del sesto secolo avanti Cristo, è stato il primo a creare una rappresentazione della Terra, facendolo egli ha operato il gesto proprio di ogni conoscenza scientifica. “La sicura via della scienza”, scrive Farinelli, “consiste non nel seguire le tracce di quel che si vede in una figura, ma al contrario nel trar fuori di essa quel che noi stessi vi abbiamo messo” (F. Farinelli). Se ci chiediamo come ce lo abbiamo messo, la risposta può essere trovata sostenendo che lo abbiamo fatto attraverso un’azione simulata: muovendoci e percorrendo i movimenti di chi ha creato la figura o modellato e curato il paesaggio. La ragione, infatti, mostra di scorgere solo ciò che essa stessa produce secondo il suo disegno.
Anassimandro, creando una metafora cartografica della Terra, riduce la Terra stessa al suo “cadavere grafico”. Sarà poi un altro filosofo, secondo Farinelli, il Kant della Critica della ragion pura, a riconoscere implicitamente la priorità di tale cadavere rispetto al corpo vivo della Terra, e a far dipendere la conoscenza stessa della Terra dalle regole della rappresentazione che noi stessi ci diamo. Una perdita? Possiamo considerare una perdita quella che produciamo con la messa a punto di una rappresentazione conoscitiva del mondo? Una perdita della presa diretta sul mondo? Con la conoscenza e la riflessione produciamo copie del mondo che, come mostra Iacono, “sognano” di essere l’originale senza riuscirci: intanto noi soggetti conoscenti siamo finiti in uno scarto e viviamo la malinconia e il dubbio che ogni conoscenza comporta, fonti allo sesso tempo della nostra mancanza e della nostra generatività.
Conoscendo abbiamo l’illusione di prendere il mondo, ma “una riflessione produce il senso di uno scarto, quello inevitabile e ineluttabile tra conoscenza e vita e quello doloroso tra il sé e l’altro” (A. M. Iacono, Il sogno di una cosa. Del doppio, del dubbio, della malinconia, Guerini e associati, Milano 2016; p. 18).
Su un terreno affine si muove Steiner, ponendosi la questione del dolore del pensiero. Mentre l’impulso a domandare genera la civiltà umana, le sue scienze, le sue arti, le sue religioni, noi animali umani che “possiamo trattenere il respiro, ma non possiamo trattenere il pensiero”, nel “venire dell’essere all’essere”, facciamo un’esperienza di malinconia e allo stesso tempo della capacità vitale e creativa di superarla. “Un velo di tristezza (tristitia), è steso sul passaggio dall’homo all’homo sapiens” (G. Steiner, Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero, Garzanti, Milano 2007; p. 12).

Gabriele Basilico.
È stato T. S. Eliot, grande poeta, a chiedersi con i suoi versi: “Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo? Dov’è la sapienza che abbiamo perduto nell’informazione? I cicli del Cielo in venti secoli ci portano più lontani da Dio e più vicini alla polvere”. Farinelli assesta una sottile e quanto mai opportuna critica alla cosiddetta filosofia della post-modernità, allorquando essa pretende di individuare una differenza tra moderno e postmoderno nel fatto che mentre nella modernità la mappa è la copia del territorio, nella postmodernità il rapporto sarebbe rovesciato: per la prima volta il simulacro (la tavola, la rappresentazione geografica) precederebbe il territorio. Farinelli commenta: “Come dire allora che già Kant sarebbe postmoderno, per tacere di Anassimandro”. Se così fosse “il più postmoderno di tutti sarebbe Cristoforo Colombo: così tra l’inizio della modernità e la postmodernità non vi sarebbe più nessuna differenza, la prima sarebbe la seconda e viceversa. Con Colombo, infatti, la rappresentazione geografica (la tavola, la mappa) prende il posto del mondo, ricomprende ed assorbe tutto ciò che esiste: la carta, cioè lo spazio, il primo degli strumenti della modernità, che proprio con Colombo si afferma” (Farinelli).
Come già si può intuire, quello di Farinelli non è solo un rigoroso argomentare geografico: siamo di fronte a un pensiero, il suo, che non si piega alla mortificazione dei confini disciplinari né al rigor mortis degli steccati accademici. Intervengono nella sua narrazione arcipelaghi di punti di vista, geografie affettive e dati oggettivi, epistemologia e psicologia dell’osservatore, per condurre il lettore in una vera e propria esplorazione, fino al punto di far pensare alla geografia come un viaggio infinito andata e ritorno tra mente e mondo. Noi, spesso, siamo come i marinai di Colombo, che sono nella condizione di credere “di vedere terra soltanto perché sono convinti della sua esistenza in quel punto, e sono convinti dell’esistenza della terra in quel punto soltanto perché l’hanno vista sulla carta, soltanto perché è la carta a dirlo” (Farinelli). Se si vuole comprendere qualcosa di chi siamo e come vediamo il mondo bisogna leggere, soprattutto, il capitolo dieci del libro di Farinelli e sognare che l’autore possa accompagnarci in un luogo guidandoci con la sua prosa ammaliante. Il luogo è il Portico dell’Ospedale degli Innocenti, la prima architettura costruita secondo il principio prospettico moderno da Brunelleschi. Scrive Farinelli: “Se noi crediamo che più le cose sono lontane e più sono piccole, più sono vicine e più sono grandi, è soltanto perché siamo moderni, e soltanto perché vi sono stati un secolo e una città (il Quattrocento e Firenze) che hanno inventato un modello terribile, pervasivo, onnicomprensivo, il quale in epoca moderna avvolgerà tutto il globo: la prospettiva lineare, cioè il punto di vista spaziale…” (Farinelli) “E davvero è straordinario come alla fine, tutto sommato, la storia della conoscenza del mondo è una storia in cui due globi, due palle, due sfere (quella della terra e quella del nostro occhio), facciano tanta fatica a riconoscersi, a mettersi in contatto, per così dire, e a guardarsi come davvero sono”.
Da allora l’occhio diventa autonomo e quel divorzio tra gli occhi e gli altri sensi diventa sempre più insanabile. Abbiamo per quella via colonizzato il mondo e il modo in cui ce lo immaginiamo. Almeno dall’età di Pericle in avanti, colonizzare significa non solo occupare materialmente una porzione di Terra, ma anche colonizzare a distanza tramite i modelli mentali che adoperiamo. Il formidabile modello mentale della prospettiva è divenuto il modello con cui inventiamo la Terra: “il più completo e totalitario che esiste, proprio perché è insieme un modello di costruzione del mondo, di percezione del mondo, di rappresentazione del mondo. Di qui la sua straordinaria potenza” (Farinelli). Condotti per questa via narrativa avvolgente giungiamo con Farinelli fino alla globalizzazione. Qualunque cosa significhi globalizzazione, dice l’autore, vuol dire che non possiamo, oggi, più contare sulla mediazione cartografica, perché le direzioni non corrispondono più a relazioni fisse tra una parte e l’altra e siamo oggi nella condizione di dover urgentemente iniziare a reinventare la Terra stessa “attraverso altre logiche e altri modelli, anche se oggi è molto più difficile orientarsi nel pensare in nome di tutti gli esseri umani che tenendosi per mano continuano a girare in tondo e sono l’umanità” (Farinelli).
Anche la “camera ottica”, raccomandata dall’esponente dell’illuminismo veneziano Francesco Algarotti come strumento educativo nelle Accademie di Pittura, divenne a un certo punto il “vero modo” di vedere il mondo: “quel medesimo uso che fanno gli astronomi del cannocchiale e i fisici del microscopio, dovrebbero fare della camera ottica i pittori. Conducono ugualmente tutti codesti ordigni a meglio conoscere e rappresentare la natura” (Opere scelte, 1823; p. 126).

Farinelli.
Il modello di rappresentazione della natura mediato dalla visione avrebbe assunto una dimensione standard duratura nel tempo.
Che i luoghi siano la fonte della traduzione in paesaggio, la base dell’apertura verso il significato simbolico del mondo, è un fatto. Con questa analisi si intende esplorare il modo in cui lo diventano e avviene la traduzione in significato. Interessa quello che accade nel registro dell’accoppiamento strutturale tra corpo-mente e mondo, in cui la combinazione tra azione e percezione propone al pensiero di cogliersi nella sua dimensione di macchina linguistica e mitopoietica, che a sua volta produce una sorta di surrealtà a partire da esperienze concrete e storicamente situate. In quel processo appare evidente come sia l’immaginazione il mediatore tra mondo interno e mondo esterno nella creazione dell’esperienza e del costrutto che chiamiamo paesaggio. La traduzione dei luoghi in paesaggio mette in immagine la realtà grazie a un’attività che prima di essere simbolica riguarda il sistema senso-motorio e il movimento nello spazio, per cui nella contingenza di una situazione emerge, nello stesso momento, la realtà naturale e la sua traduzione in artefatto: ed ecco il paesaggio. Il visibile e l’invisibile vanno a comporre un’immagine che, narrata mediante il linguaggio, diventa paesaggio. Stimolata dal luogo, il movimento e l’immaginazione diventano una macchina in grado di mettere in moto una lettura e una traduzione generative, che danno vita all’esperienza di fruizione degli spazi della nostra vita, che noi stessi narriamo come paesaggi. Il paesaggio è, perciò, inscindibile dal movimento e dal linguaggio; è e diviene nel linguaggio; è linguaggio e, forse, non necessita neppure della traduzione essendo in noi e divenendo con noi quello che a un certo momento dell’esperienza effettivamente è.
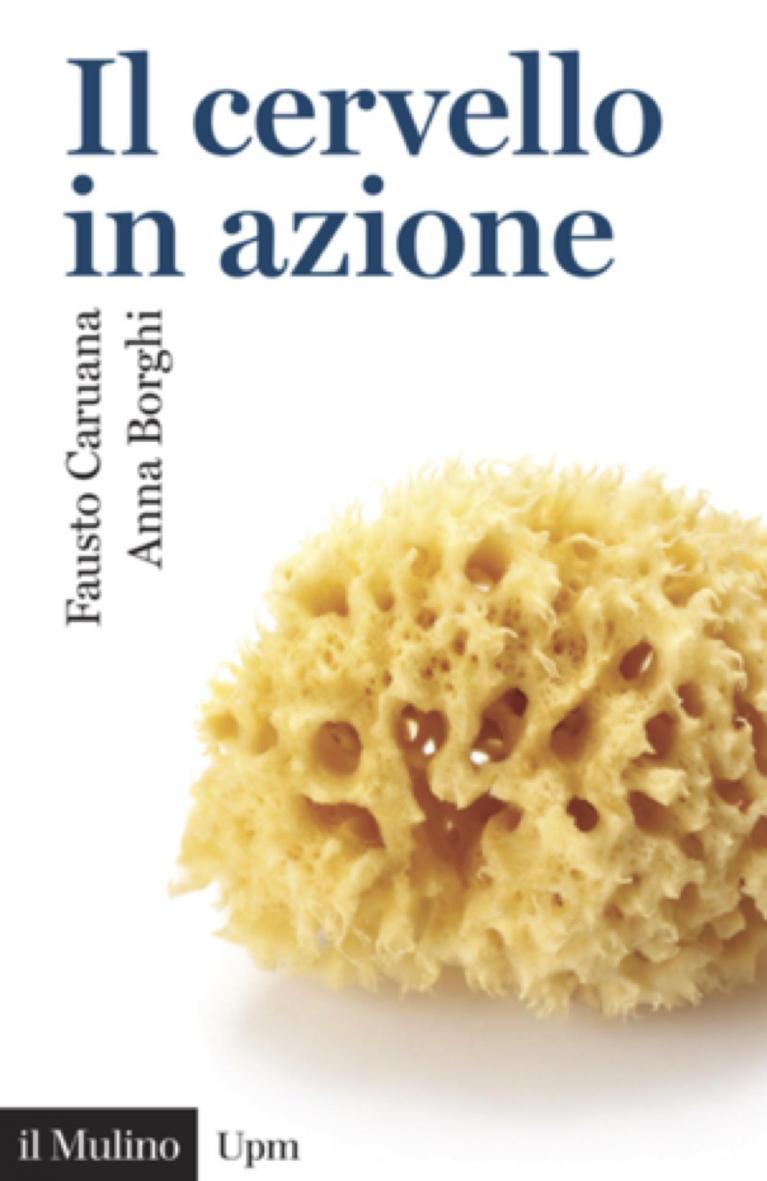
Caruana.
Sia la cognizione incarnata che il sistema senso-motorio coinvolti nella nostra conoscenza del mondo, ci mostrano che, qualora i simboli non siano ancorati a un referente, non si può che approdare a un circolo vizioso (A. Cangelosi, and S. Harnad, (2001). The adaptive advantage of symbolic theft over sensorimotor toil: Grounding language in perceptual categories., “Evolution of Communication” 4(1) 117-142).
Il paesaggio della mente contiene il paesaggio esterno esplorandolo e muovendosi in esso, e mentre si muove ne emerge a sua volta costruito da quel paesaggio esterno (S. S. Clark, Exploring the Landscape of the Mind. Understanding Human Thought and Behaviour, Thinkstock, New York, 2016).
La percezione delle direzioni cardinali del corpo, destra-sinistra, alto-basso, avanti-indietro, che appare fondamentale per l'organizzazione del comportamento può, infatti, essere modificata. È stato dimostrato che una prolungata percezione distorta dell'orientamento degli assi del corpo può essere una conseguenza di segnali sensori-motori disordinati. Una distorsione di lunga durata della percezione dello spazio personale può anche essere indotta da un compito definito indotto nel sistema ecologico del soggetto (E. Dupierrix , M. Gresty, T. Ohlmann, S. Chokron, Long Lasting Egocentric Disorientation Induced by Normal Sensori-Motor Spatial Interaction, “PlosOne”, February 12, 2009).
Alla ricerca di un approccio embodied e grounded al paesaggio, la concezione del paesaggio può essere definita come riattivazione del pattern di attivazione neurale che si ha quando si esperiscono gli oggetti e le entità del mondo esterno. In questa prospettiva il concetto diventa multimodale e corrisponde all’attivazione di una rete distribuita di diverse modalità (visiva, tattile, eccetera), secondo le indicazioni provenienti dagli studi e dalle ricerche di V. Gallese e G. Lakoff.
Tutto ciò comporta la messa in discussione della riduzione del significato a simboli linguistici. Scrivono, in proposito, Caruana e Borghi:
“Possiamo continuare all’infinito a parlare di elefanti grigi, ma se non abbiamo visto almeno una volta qualcosa di grigio e un’immagine di un elefante, riusciremo difficilmente a rappresentarceli. In contrasto con le teorie tradizionali e con quelle distribuzionali del significato, le teorie embodied hanno cercato di mettere in luce che la relazione che connetteva concetto e referente non era arbitraria, e che sentire, leggere o anche pronunciare la parola portava ad attivare gli stessi sistemi attivati durante l’attivazione con il suo referente. Questa concezione del significato, che potremmo chiamare ‘referenziale’, ha avuto indubbi meriti, anche se oggi si può pensare che sia limitata perché rischia di ridurre il significato delle parole, senza cogliere il fatto che le parole possono compiere azioni, estendere il nostro spazio peripersonale e le nostre capacità cognitive” ( F. Caruana, A. Borghi, Il cervello in azione, Il Mulino 2016; pp. 171-172).
Nel momento in cui emerge l’ipotesi della simulazione, a Parma con V. Gallese e G. Rizzolatti, alla Emory University con L. W. Barsalou (L. W. Barsalou, Perceptions of perceptual symbols, in “Behavioral and Brain Sciences”, 22, 4, 1999; pp. 637–660), a Berkeley con G. Lakoff, si comprende che i concetti non sono simboli astratti ma simboli percettivi: per formarci i concetti non è necessario tradurre l’esperienza di oggetti ed entità in un formato diverso, ma semplicemente riattivare l’esperienza.
I concetti concreti attivano i sistemi senso-motori e si originano nell’embodied cognition e nel movimento e nell’azione.
“È sempre tramite simulazione che comprendiamo il significato delle parole. È così che, quando leggiamo la parola ‘calciare’, attiviamo il piede e la gamba: perché programmiamo quell’azione” (F. Caruana, A. Borghi, op. cit., p. 172).
Come è evidente, per l’origine del concetto di paesaggio, non solo entra in crisi, come era già accaduto, ogni forma e possibilità di analisi basata sull’osservazione a distanza di un luogo o di un ambiente che sarebbe esterno all’osservatore e mero oggetto di contemplazione, ma si tratta di cercare di andare oltre la stessa ipotesi della traduzione simbolica dei luoghi in paesaggi mediante simboli astratti dalla realtà, appunto. Il concetto di paesaggio si propone come pattern di azioni possibili in uno spazio, emergendo all’interno del nesso tra concetti, parole, azioni, ed evoca simulazioni, in quanto, quando usiamo un concetto di paesaggio, rievochiamo l’esperienza del paesaggio a cui quel concetto si riferisce.