Trenta poesie famigliari / Il Pascoli di Garboli
Rileggo un libro da me molto amato, appassionante e divertentissimo; e sono un po’ sulle spine. L’editrice Quodlibet, che con merito ha tra le sue vocazioni anche quella di riproporre testi importanti eppure dimenticati o introvabili sul mercato, ha da poco riproposto le Trenta poesie famigliari di Cesare Garboli (con una introduzione di Emanuele Trevi, Quodlibet, Compagnia extra, 2020, 20 €). Uscì per la prima volta nel 1985 nella collana economica dei classici Mondadori, e Garboli figurava come curatore del manipolo di poesie pascoliane. Cinque anni dopo, ricomparve nella Nuova Universale Einaudi con un sorprendente cambio d’intestazione: il curatore che assurgeva al ruolo di autore.
Quello che poteva sembrare un colpo di mano, o meglio un coup de théâtre in flagrante stile garboliano, altro non era che la presa in carico di un dato di fatto. Come dichiarato da Garboli medesimo nella prefazione a questa seconda edizione, a petto di una risicata antologia di testi, e neppure tra i maggiori, l’ipertrofica mole delle pagine della nota al lettore e della cronologia finivano per fagocitare le 30 poesie, tutte per giunta dotate di glosse e cappelli introduttivi a larghe tese. Insomma, esattamente il contrario di ciò che ci si augura per un’antologia che miri a lasciare spazio al lettore. Questa sembrava portare all’estremo i vizi dei florilegi che gli studenti si trovano tra le mani sui banchi del liceo. Ma: magari le antologie scolastiche fossero così piene di verve, e ci dessero un ritratto d’autore travolgente, libero da gessi e bende d’imbalsamazione come questo garboliano. Pascoli – temo – sia nella scuola ancora un “poeta da maestre” d’antan: il poeta delle piccole cose, dei buoni sentimenti, di fiorellini e uccellini, di orfani, mendichi e pellegrini.
Spero non faccia aggio su questa mia impressione un amaro ricordo personale di quando, all’esame di maturità, nel commento al Gelsomino notturno scrissi di una postura del poeta, escluso dalla felicità nuziale dell’amico, che aveva qualcosa di voyeuristico. Apriti cielo! Il professore, un esterno un po’ sbracato somigliante un po’ al Giovannino solerte frequentatore dell’osteria sotto casa, mi chiese di che cosa m’ero fatta (erano gli anni Settanta), e ne uscii con le ossa rotte. Metteteci pure lo scherno dei compagni per la predilezione accordata a un poeta di rondini e cavalline, ciaramelle, zirli e trilli, e capirete perché, con questi precedenti, quando incontrai il libro di Garboli fu per me una festa.
Certo è che, da allora, non mi è più capitato di ridere tanto con un libro dotto, filologicamente imbastito con poco più dei ritagli di sartoria di un grande poeta che troppo scrisse, con ciò arrecando danno al suo pur notevole repertorio di punta. Così, dovendo rileggerlo a distanza di tanti anni, non vorrei incappare in una delusione.
Mi dico: magari capita a me l’inverso di quel che successe a Garboli quando, vent’anni dopo, tornò sulla Storia di Elsa Morante e s’accorse che il romanzo in molte pagine piegava al comico. Tratto di cui neppure lui, sodale di Elsa e assai esposto difensore dell’opera, s’accorse in quell’estate incendiata dalle polemiche. Quel «romanzone» del 1974, infatti, con la lunga teoria delle morti – soccombe alla cruda sorte sia l’intera famigliola protagonista sia la cerchia dei personaggi comprimari – e la passio del bambinello epilettico (temi quanto mai pascoleggianti), sciolse le cataratte lacrimali d’una gran massa d’italiani. Come fece notare Luigi Baldacci, ascrivendola a merito di Morante e pronto a riscattare il patetico tanto bistrattato, fu un’impresa emotiva e letteraria riuscita in precedenza al solo romagnolo (ma, ancor prima, a De Amicis).
Invece no. Quella mia prima impressione di lettura esce da questa seconda prova per nulla sgualcita, anzi rinvigorita. Lo smalto della prosa di Garboli è intatto, il ritratto di Zvanì, con tutte le sue fanciullaggini, viltà, miserie, che tuttavia non intaccano la figura d’un uomo di buon animo dalla schiena dritta né la sua grandezza di poeta, torna a farmi sorridere senza mai far sentire in colpa, i commenti ci raccontano un sistema di trucchi, di presidii espressivi, di convenzioni letterarie che non riescono a censurare il nudo messaggio inconfessabile e qui messo a nudo, anzi. Così decifrati, divengono un lasciapassare e sbalzano in vivo una figura di destino.
La poesia di Pascoli può benissimo essere goduta in sé, per lo splendore del virtuosismo tecnico, per l’incanto delle scene campagnole, per l’ossessiva ricorrenza del tema funebre, per l’oro lasciato in eredità e che continua a brillare anche nei poeti delle ultime generazioni. E per molto altro ancora. Ma leggere Pascoli così, in modo asettico, resecando il bubbone di quell’appiccicoso imbroglio di affetti famigliari, rischia di consegnarcelo come un’oleografia, un santino da collezione o, appunto, un virtuoso miniaturista, un lagnoso cantore dei propri morti, o un erudito antiquario.
Non indulgo in simpatie per una critica che fruga nell’intimità degli scrittori, propensa come sono a credere che l’opera basti. Ma ci sono casi, e Pascoli è uno di questi, in cui l’opera è così invischiata con la vita vissuta che se letta alla luce diretta della biografia si apre a scenari interpretativi impensati con relativo surplus di piacere estetico-intellettuale.
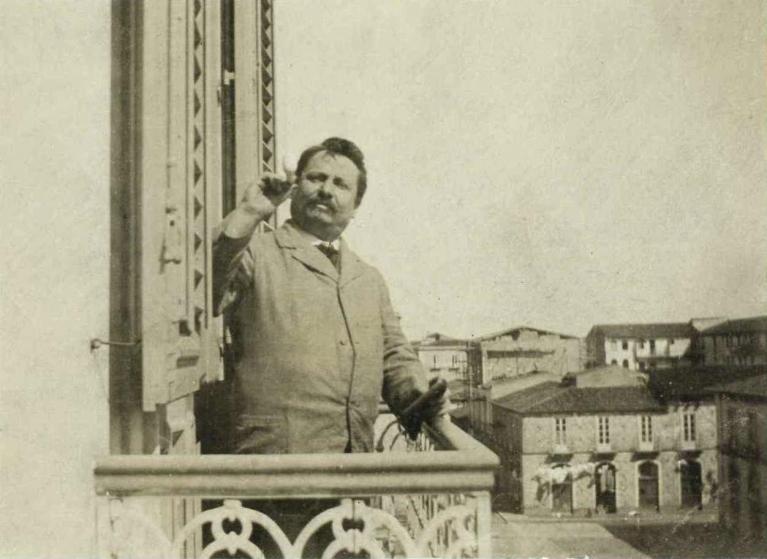
Specie se questa lettura ai raggi x è condotta dalla penna e dal talento di Garboli. Perché in Pascoli il lettore Garboli trova un soggetto a lui assai congeniale, degno dei lunghi anni di studio profusi a strappare segreti e cartigli dall’archivio della Caprona e dall’epistolario di casa per mettere in scacco questo genio dell’espiazione e della rimozione, questo estremo censore del desiderio. L’analogia con quell’altro campione dell’animo umano, Molière, a cui pure Garboli lavorò indefesso fino alla fine della sua esistenza, scatta immediata. Un’analogia a rovescio: Molière ride di se stesso ma nulla vi è di comico nella sua vita, Pascoli non fa che prendersi sul serio inconsapevole di quanto le confessioni d’una sincerità sconcertante, rivelate dai retroscena privati, lo possano mettere in ridicolo agli occhi di chi è esterno al triangolo affettivo e castrante con le due sorelle, Mariù, la bruna fedele, e Ida, la bionda traditrice. Un perfetto personaggio molieriano, glossa Garboli, e il perfetto personaggio di «un romanzo famigliare dai tratti patologici raccontato da uno che non lo riconosce per tale».
Ma Pascoli smuove la curiosità diagnostica, o meglio in questo caso etnologica, di Garboli anche su un altro versante al centro dei suoi interessi: nell’intima essenza dell’uomo Pascoli che cancella la propria virilità, nell’«infezione» che lo consuma, nell’imbroglio tra ipocrisia e sublimazione, egli trova una delle radici del carattere italiano, il «marchio di fabbrica fascista (o protofascista), il ‘distintivo’ scintillante con orgoglio sul petto del figlio del fattore, del bravo figlio del popolo». Un Pascoli che, alla maniera tragicomica dei personaggi di Alberto Sordi, incarna senza una precisa avvertenza ideologica, le meschinerie e le velleità dell’italiano medio. Si esce da questo libro su un uomo costantemente in bilico tra commedia e tragedia ridendo e piangendo insieme, con la consapevolezza che, purtroppo, questo Pascoli ben ci rappresenta.
Un gran libro, dunque. E non si deve dar poi credito a Garboli quando gigioneggia definendolo un «brogliaccio», un libro «senza forma» che parrebbe diviso in due stanze all’apparenza separate: quella maggiore della Cronologia, riversata pari pari in quell’altro lavoro monstre sortito nei due volumi dei Meridiani Mondadori, e preceduta dall’apostrofe Al lettore, un saggio critico in verità che, come un aperitivo, predispone al plat de résistance. L’altra, in minore, cioè l’effettiva antologia dei testi pascoliani. Tuttavia, non si dà l’una senza l’altra. Il ritratto stilato nella Cronologia si completa e si arricchisce con i cappelli introduttivi ai testi. Le date, sosteneva Garboli, «parlano chiaro», le date «sono idee». E queste idee suggerite dagli anni e dai mesi messi in ordine trovano le pezze d’appoggio, i puntelli di sostegno nel commento critico-filologico. Basta scorrere quello, bellissimo, al Pellegrino, posto in apertura d’antologia, per capire quanto queste due parti siano in colloquio costante. Vi si trova pure una di quelle immagini, forse l’immagine per eccellenza, che rivela insieme a Pascoli anche Garboli, o per meglio dire, rivela la cifra che muove tutto il suo fare critico.
Garboli infatti è attratto proprio da quella «striscia di nessuno» (p. 195), da quella marca o paese di frontiera, da quell’«intervallo tra due realtà» com’ebbe a definirlo in un suo intervento sul maestro Roberto Longhi, che si estende tra l’opera e la presenza fisica dell’autore. Da qui viene la sua attenzione alle energie artistiche disperse, agli embrioni o agli aborti testuali, compulsati per riportare in chiaro il segreto capace, riverberandosi sulle poesie accreditate, di immetterci lungo nuove piste interpretative. Da qui, dunque, l’interesse per il Pascoli meno noto o mal noto, le infrazioni ai limiti della legalità letteraria (o a quelle considerate tali dall’accademia) quale lo smontaggio, pezzo a pezzo, del tabernacolo-pagoda delle Myricae proposto nell’antologia dei Meridiani.
Un gran libro che ci consegna un Garboli in gran forma, una scrittura al suo meglio dove studiatissima è la scelta dei tempi narrativi e sintattici, tra brusche apodissi e ritmi conversevoli, sapiente la calibratura di ironia e suspense, abile il montaggio delle citazioni che fa dir loro più di quanto vogliano, in modo che sprigionino scintille al cozzo, spassose certe similitudini, volutamente provocatorie alcune immagini (ah, quelle «gambe troppo nude della Lia Bianchi»! di p. 71).
Anticonvenzionale, tagliente, irriverente, talora estremo, Garboli è divisivo: si ama o si odia. Molti accademici non lo sopportano. Molti dei libri di questi accademici, però, sono noiosi quanto il Pascoli proposto a scuola o nei profili di certi manuali. Trovo strepitoso, giusto per usare un aggettivo pascoliano, che un libro pieno di note e apparati si legga d’un fiato, ridendo e imparando.
Muovo un solo appunto a questa benemerita riedizione che mi consentirà di tenere alle future maestre un corso su Pascoli (ma non quello delle maestre). Perché non riportare anche il risvolto di copertina di mano di Garboli, e togliere al lettore il migliore vademecum a questo libro? È questo un vizio ormai invalso nelle case editrici, ma deprecabile.
Ah, dimenticavo: oltre ad ammirare Garboli, sono tra quei pochi che «mandano giù come un’aranciata i Primi poemetti».
Cesare Garboli, Trenta poesie famigliari di Giovanni Pascoli, Quodlibet 2020.









