Kafka, sempre
Si sta lentamente avvicinando il centenario della morte di Franz Kafka (3 giugno 2024) ed ecco qui due importanti volumi dedicati al grande Praghese, semisconosciuto in vita, si sa, ma molto celebrato dopo la morte, si sa anche questo.
Kafka: il testo a più voci (undici per l'esattezza), curato da Riccardo Panattoni e Rocco Ronchi per l'editore Mimesis, è bensì una miscellanea, ma i vari saggi dialogano tra loro e si rimandano l'un l'altro.
Questi dieci saggi (più un'appendice) non di kafkologi o germanisti, ma di scrittori, poeti e filosofi, nascono non tanto con l'intento di dichiarare di che sia segno l'opera kafkiana, quanto piuttosto di precisare, se possibile, come funziona essa, quale sensibilità attivi nel lettore, come agisca in lui. Rispondono a un quesito pragmatico, quindi, più che teoretico.
Albinati segnala la sorprendente e inesausta adesione al mondano del Nostro. Kafka non è un veggente o un visionario; o, meglio, lo è in quanto la sua accettazione dell'esistente è integrale. Egli è fattuale, fisico, sensuale, attivo, e lo è in modo implacabile.
È un veggente o visionario di ciò che c'è. Per questo Calasso, nel suo saggio di più di vent'anni fa (K., Adelphi, 2002), poteva addirittura avanzare, per Kafka, un “sospetto costante di verismo”.
Per questo, in lui, troviamo inscindibilmente mescolati stile protocollare e fenomeni assurdi, imperturbabilità totale nella narrazione di fatti del tutto perturbanti.
Anche Ronchi indica il campo d'azione dell'algoritmo K come quello dell'“immanenza assoluta”. Gli effetti sensibili generati da esso sono: densità del continuo, assenza di relazione congiuntiva, esaurimento del possibile, claustrofobia del fuori.
Iniziamo dall'ultimo punto: tutti gli eroi kafkiani sono “chiusi fuori”, aspettano davanti a una delle innumerevoli porte che “si aprono” in una chiusura perenne nelle sue pagine. Essi non riescono mai a entrare in contatto con ciò cui aspirano: le distanze sono incolmabili. Gli antichi paradossi di Zenone e Diodoro Crono sull'impossibilità del movimento conoscono un'inaspettata riattivazione nelle loro vicende. Infinitum in actu pertransire nequit è un motto medievale che può adattarsi sia a K. nel Castello che al cacciatore Gracco sulle scale che portano all'Aldilà. L'erranza è illimitata.
La macchina amministrativa che incombe nei testi kafkiani non è simbolo dello stritolamento del singolo nelle maglie impassibili della struttura impersonale, come è stato spesso ipotizzato, bensì solo concrezione figurale di un infinito impossibile da attraversare.
Analogamente Fiori giunge a sostenere che il motivo della “distanza” in Kafka assurge a dimensione “ontologica”. La Legge non è come la Dea che tendeva dolcemente la mano a Parmenide (per restare nell'ambito dei Sapienti greci), essa oppone a chi vuole entrare in lei il silenzio del suo remoto splendore.
L'agrimensore K. è chiamato (o meno) a misurare l'incommensurabile.
Panattoni nel delineare il diagramma Kafka, che fa evidentemente il paio con l'algoritmo K., evidenzia come esso si costituisce sempre all'interno di due movimenti simultanei. Ma, soprattutto, come esso presupponga un diagramma precedente e preluda a un diagramma successivo, in una continua serie di concatenazioni che però non configurano nessuno sviluppo possibile, avanzando unicamente sul proprio piano d'immanenza.
Allo stesso modo Leoni tratteggiando la “forma del Processo” ne individua due aspetti: uno più generale e uno più ristretto. Entrambi hanno però identico nome: processo appunto, dato che ogni processo è un processo, nel senso che ogni divenire comporta la costruzione di una componente giuridica e la messa in opera di una macchina giudicante. Il processo in quanto macchina giudicante è anche macchina scritturale, che produce testualità, tracce scritte che sono sempre e solo tracce di tracce, secondo il ritmo di un'ininterrotta auto-duplicazione e auto-diffrazione grafica.
Anedda cita al proposito le continue introduzioni e i prologhi che si susseguono ai prologhi degli Stadi sul cammino della vita di Kierkegaard come ipotetico modello “per leggere e scrivere di Kafka”.
Il saggio di Bonazzi sugli scarabocchi di Kafka, assai simili alle performance di calligrafia giapponese all'aria aperta, dove la traccia scritta evapora mentre la si distende al suolo caldo del paesaggio assolato, e dove è detto che nel Nostro il massimo della materialità si annoda al massimo della vacuità, rimanda alla frase di Scholem secondo cui “l'assolutamente concreto è precisamente l'impraticabile”. Frase contenuta nel saggio di Solla sul brevissimo Desiderio di diventare un indiano. Qui il desiderio è una forza centrifuga che sottopone le parti di cui siamo fatti a una spinta che le disassembla. Il cavallo su cui sta l'indiano (o su cui starebbe) si decompone mentre viene evocato, come la macchina della Colonia penale è rappresentata nel suo stesso andare in pezzi. E così l'indiano è e non è un indiano. Il suo viaggio è un viaggio immobile, come quello del messaggero dell'imperatore, uno dei tanti “intermediari assoluti” dell'opera kafkiana, perché non riescono mai a mettere in relazione gli enti e le persone che dovrebbero collegare.
Il mondo di Kafka è, come voleva Benjamin, un “inesauribile mondo intermedio”.
Quello stesso in cui si muove il Cacciatore Gracco. Le affinità tra questo personaggio e il protagonista del film mai realizzato da Fellini, Il viaggio di G. Mastorna, sono analizzate da Carrera. Il violoncellista Giuseppe Mastorna, a differenza dell'antico cacciatore, pare aver raggiunto il paradiso per sempre negato a Gracco. Eppure anche lui, come Antigone secondo Lacan, pare mantenersi in una posizione che è entre-deux-morts, “tra le due morti”. Forse tutti i personaggi di Fellini lo sono. E tutta la sua opera cinematografica è sotto il segno di un “complesso di Mastorna”, ecco perché il film in questione non l'ha mai portato a termine.
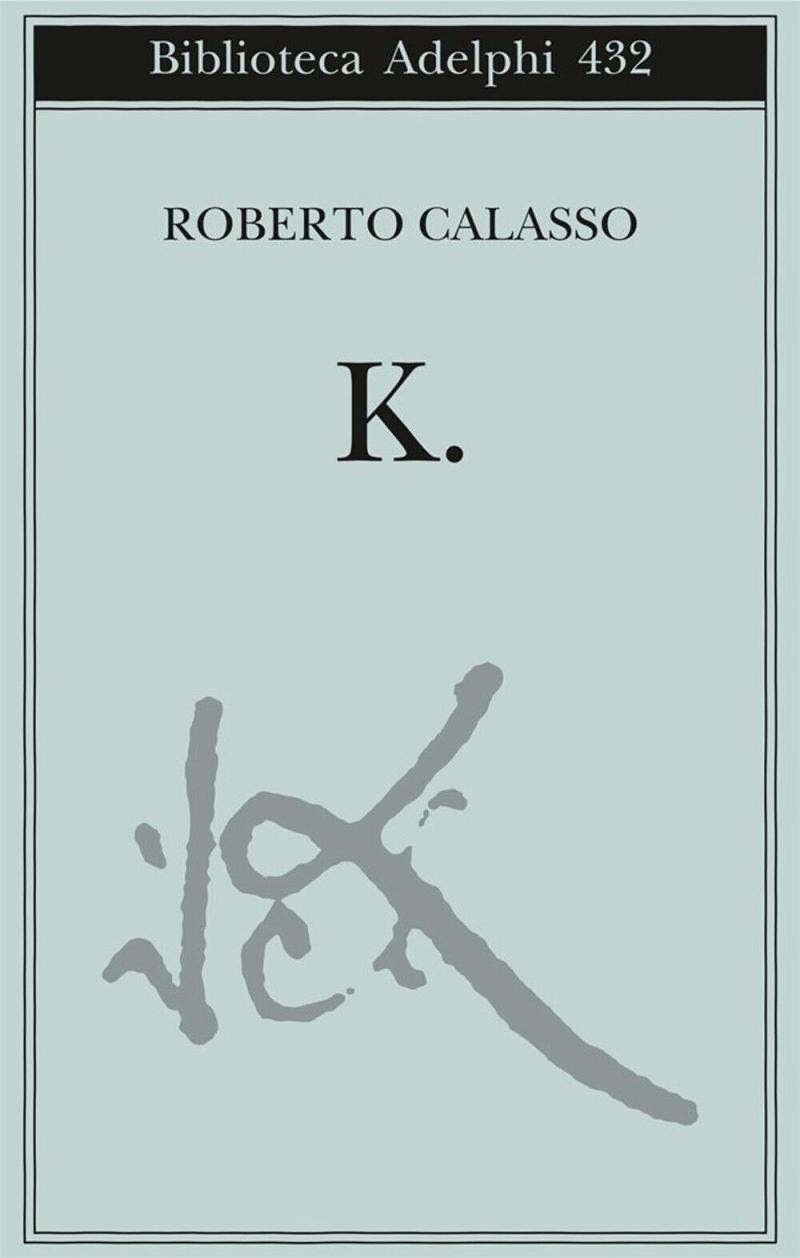
Chiude il volume uno scritto di Vizzardelli, che parte dal ruolo della musica nei testi kafkiani, pura materia sonora, secondo Deluze e Guattari, exemplum di un fenomeno di derealizzazione secondo Vizzardelli. E qui si nota come la derealizzazione, appunto, nonché la depersonalizzazione vengano promossi dall'ingombrante posizione di “disturbi psichici” al rango di “descrizione di un'esperienza estetica”. Kafka guarda il mondo come da una finestra o da un oblò. Soffre di mal di mare in terraferma. Il suo distacco da se stesso, dal suo corpo, dall'ambiente è premessa di una visione del mondo unica e della conseguente originale, inimitabile produzione testuale.
L'undicesimo autore della silloge, Cavalli, che ha curato un'appendice al saggio di Albinati, ci consente di passare ad occuparci del libro di Calasso appena uscito per la Piccola Biblioteca Adelphi.
Cavalli dialoga con Albinati a volte con sue annotazioni, altre volte semplicemente con citazioni di traduzioni diverse da quelle allegate dal narratore romano. Anche solo questo fatto è in grado di generare fenomeni di spaesamento, o maggior comprensione, nel lettore.
Il titolo di questo ulteriore libro postumo di Roberto Calasso è in effetti L'animale della foresta. Viene da una delle ultime lettere a Milena di Kafka, quella del 14 settembre 1920, lettera che è citata ampiamente da Calasso in chiusura di volume (pp. 132-133). Lettera piuttosto nota agli amanti di Kafka. Qui egli si paragona a un “animale della foresta” per l'appunto, che viveva in una lurida fossa, finché non vide, fuori dalla fossa, nell'aria libera, lei, Milena, la cosa più bella che avesse mai visto fin allora, le si avvicinò timidamente, si accucciò accanto a lei eccetera.
Solo che “l'animale della foresta” non era noto ai lettori come tale, bensì, nella collaudata traduzione di Ervino Pocar, come “bestia silvestre”. Dall'originale “Waldtier” si possono dunque diramare o la tradizionale “bestia silvestre” o questo nuovo “animale della foresta”.
Chiarito questo punto, passiamo al dettaglio.
Così come nell'altro volume postumo su Baudelaire del 2021, Ciò che si trova solo in Baudelaire, è utile il confronto con l'assai più corposo La folie Baudelaire del 2008, anche con questo Animale della foresta può essere indicato il confronto con il K. del 2002.
L'agile volumetto odierno si occupa di tre racconti degli ultimi anni di Kafka, ossia, nell'ordine, Ricerche di un cane (di passata notiamo anche qui la traduzione diversa rispetto al consueto Indagini di un cane, di contro al tedesco Forschungen eines Hundes), Josefine, la cantante o Il popolo dei topi e La tana.
Pietro Citati nel suo Kafka aveva consacrato un intero capitolo al tema dello “scrittore come animale”, e qui Calasso, in un dialogo a distanza fra defunti, pare inverare quello spunto.
Le Ricerche di un cane sono, secondo Calasso, nell'avvio, la cosa più prossima a uno scritto autobiografico che Kafka ci abbia lasciato. Del resto anche in K. si affermava lo stesso a proposito della Tana (è come se Kafka dicesse: se volete sapere qual era davvero la mia vita, leggete questo racconto, p.179).
Il cane non appartiene più alla comunità canina. Si sente un estraneo. Non è più un compagno, ma una vittima. Tutta l'opera kafkiana non è che una variazione sul tema dell'estraneità. Il cane comincia a sentire la propria estraneità a partire dall'incontro con sette cani musicanti. Anche Josefine la cantante si sente estranea al popolo dei topi. Non capita. Non abbastanza apprezzata. La sua musica è solo un fischio, eppure meriterebbe maggior riconoscimento.
Per Calasso questo di Josefine è il testo più disperato dell'intera produzione kafkiana. In esso si rispecchierebbe il senso dell'insufficienza non solo dell'arte del fischiare o della musica, ma dell'arte in genere.
La tana, in tedesco Bau (anche “costruzione”), racconto incompiuto in cui un misterioso nemico (reale o immaginario) riesce a farsi sentire, tramite fischi, sibili o rumori, entro le labirintiche volute della tana di un animale non meglio identificato, rappresenta per Calasso il rapporto tra ciò che si costruisce nel visibile e ciò che si costruisce nell'invisibile.
In K. ciò era espresso da una coppia di concetti vedici, il legame tra vyakta e avyakta, ciò che è manifesto e ciò che è immanifesto.
Ma se il cane apparteneva a una specie, qui l'animale nella tana è senza nome. Conta solo il suo scavare.
La tana è la sua fortezza.
Nei diari, nel 1920, Kafka aveva annotato: “la mia cella di prigioniero, la mia fortezza” (meine Gefängniszelle, meine Festung).
La tana è “un altro mondo”. “Può donare pace solo a chi si apre a lei interamente”.
Kafka passò la vita intera sulla “terra di confine tra solitudine e comunità”, cane tra i cani e, anche, animale senza nome nella tana.
Quella terra di confine potrebbe essere, come sostiene Calasso, il mondo del bar-do, stato intermedio tra la vita e la morte, che il Libro tibetano dei Morti insegna ad attraversare.
Due volumi assai diversi nell'impostazione, questi di cui abbiamo presentato alcuni aspetti, entrambi ricchi di implicazioni e stimoli.
Eppure, sia che si affronti Kafka secondo un'ottica pragmatica, ma sulla scia di suggerimenti lacaniani, deleuziani e di altri ancora, sia che la si affronti accostandole antiche dottrine esoteriche, rimane da ricordare la frase del cappellano del carcere nel penultimo capitolo del Processo: “Lo scritto è immutabile e le interpretazioni sono spesso solo espressione della disperazione che ne deriva” (Die Schrift ist unveränderlich, und die Meinungen sind oft nur ein Usdruck der Verzweiflung darüber). Ciò vale non solo per la parabola Davanti alla Legge, ma per tutta l'opera di Kafka. E lui lo sapeva bene.
Leggi anche
Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna
Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka
Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni
Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza
Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione
Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...
Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino
Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.









