La bella estinzione
Raccontare l’estinzione è semplice. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: liste funebri di mammiferi o di uccelli, morie di simpatici anfibi o d’indispensabili insetti impollinatori; meteoriti titaniche o funghi microscopici, DDT o CO2; frammenti genetici da resuscitare o arche-bunker alla deriva verso un domani incerto; sensi di colpa di specie o autoassoluzioni possibiliste. E poi antagonisti, mandanti, aiutanti; danneggiamenti, persecuzioni, salvataggi. Lo stile british essay è d’obbligo: il viaggio in prima persona sulla scena del delitto, le note di colore da reportage turistico, lo scienziato-macchietta da intervistare, la battuta ironica per allentare la stretta d’angoscia, la strizzatina d’occhio sull’orlo dell’abisso, il compendio narrativo di un paio di articoli di Science. Raccontare l’estinzione è semplice. Pensare l’estinzione è complicato. È complicato perché l’estinzione non è mai solo la scomparsa di una specie fragile o la zoo-biografia di un endling in qualche malinconica gabbia metropolitana, non è solo un genere letterario dell’Antropocene narratologico o una vacca da latte per l’ultima moda editoriale. È una pelle multistabile, l’estinzione, che avvolge il sistema-Terra e ne riflette fisiologie oscure e patologie profonde. È qualcosa che ci stiamo abituando a leggere come compianto, memento, premonizione, e che invece dovremmo poter leggere come lacune e lezioni corrotte nel De rerum natura del Pianeta. Ci vorrebbe più filologia immaginante e meno filmografia distopica. Ci vorrebbe un’attitudine analitica capace di incorporare il mistero e il senso del sacro, pensando l’estinzione non come un megacrime ma come un’ontologia negativa, come il suono del Vuoto.
Il rumore di fondo, quello che invece governa le narrazioni della Sesta Estinzione, nasce da un’intuizione-scorciatoia fin troppo affascinante: Homo sapiens è “catastrofe”, “virus”, “specie infestante”. Certo, dubitarne sarebbe rendersi complici del disastro, ma è anche vero che nei processi per direttissima si asfaltano lacune e si piallano complessità. Ad esempio, il racconto di Sapiens sapiens che fa estinguere Neanderthal, come Pizarro con gli Inca o come l’Uomo Bianco con il Pellerossa, una specie di macchina narrativa soggiacente che funziona facendo leva sul dramma a tinte forti, sulla psicologia da cronaca nera. Immaginare i Neanderthal sterminati da nuovi invasori portatori di malattie ignote, di tecnologie evolute, di abilità cognitive superiori è un déjà vu cinematografico che tutti possono capire. Non importa che, quando i Neanderthal si estinsero, i Sapiens sapiens fossero 330.000 in tutta Europa, cioè poco più della metà degli abitanti della provincia di Modena, o che dal loro arrivo i Neanderthal ci misero appena 8000 anni ad estinguersi, cioè quattro volte la storia del Cristianesimo. Non importa che per Neanderthal le chance di incrociare un Sapiens sapiens, e di subirne la competizione ecologica o la persecuzione, fossero abbastanza ridotte in un territorio di 10 milioni di chilometri quadrati di tundra, foreste e deserti freddi, o che alla fine a ucciderlo sia stato probabilmente il suo metabolismo, bisognoso di 5500 calorie al giorno, piuttosto difficili da raggranellare in un ecosistema glaciale estremo. Non importa. La storia del genocidio è apparecchiata e funziona mille volte meglio delle più caute speculazioni scientifiche.

Lo stesso vale per l’estinzione della megafauna. Siamo indotti a immaginare orde di Sapiens sapiens sanguinari a caccia in lungo e in largo degli ultimi mammut, quando pare che solo qualche piccolo gruppo dell’Europa orientale li mangiasse, e non pensiamo alla fine dell’Era glaciale, ai nuovi caldi, alla trasformazione radicale della flora che sostentava i pachidermi. Ci pare inglorioso vederli collassare per choc termico, carestie ed epidemie da zoonosi piuttosto che vittime di carneficine indiscriminate. Sì, Sapiens sapiens, la sua arroganza cognitiva, deve averci messo il carico con Neanderthal, bradipi giganti e mammut, ma l’imperativo romanzesco non ama gli scenari desaturati, ci vuole il dramma, e il dramma è invariabilmente lo stesso: il forte ha la meglio sul debole, il sangue deve tingere il latte, il caos genera tabula rasa. Sic transit gloria mundi, insomma. Ma già alcuni anni fa Telmo Pievani ci ricordava che noi umani siamo i figli dell’estinzione degli altri, siamo qui perché prima di noi ci sono state cinque estinzioni di massa che hanno prodotto la fine di vari mondi rimescolando le carte biologiche del Pianeta. In cosa è diversa allora la Sesta Estinzione (Neri Pozza 2024, nuova edizione ampliata) che ci racconta il premio Pulitzer Elizabeth Kolbert? Qual è la “storia innaturale” annunciata nel sottotitolo? Sensi di colpa o meno, guasto faustiano o responsabilità di specie, il quadro finale è chiaro: “Una popolazione modesta è sempre vulnerabile, e le forze su vasta scala che hanno messo a rischio specie come il martin pescatore di Guam e il potoroo di Gilbert sono ancora molto attive. Modificare il corso dell’attuale estinzione richiederebbe cambiamenti paragonabili a quelli dell’Antropocene. L’unico modo per bloccare la diffusione di specie invasive, per esempio, consisterebbe nell’eliminare i viaggi e il commercio globali, ma anche così non si riuscirebbe a fermare gli invasori, come il serpente bruno arboricolo, che stanno già causando gravi danni. Salvare l’Amazzonia implicherebbe porre fine alla deforestazione e stabilizzare il clima. E, a sua volta, stabilizzare il clima significherebbe interrompere l’utilizzo dei combustibili fossili, Per il bene nostro e di milioni di altre specie con cui condividiamo il pianeta, dovremmo adottare tutte le misure appena elencate. Ma non mi sembra che siamo pronti a farlo”.
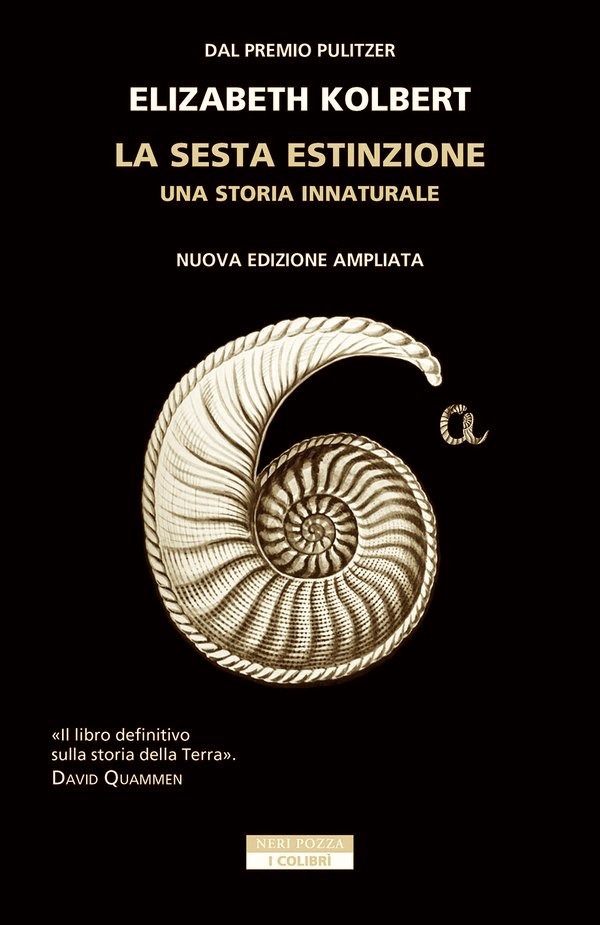
Simple as that. Per non parlare del fatto che anche Kolbert sdogana la versione romanzesca dei nuovi Sapiens come predatori dal cervello faustiano e dalla pancia senza fondo. Allora, a cosa può servire leggere un libro voluminoso, documentato, assolutamente brillante, ma il cui messaggio d’allarme è dichiaratamente in ritardo? Che cosa possiamo fare? chiedono all’autrice lettori e scolaresche, e Kolbert non trova molto di meglio da dire se non che dovremmo cogliere “la straordinaria peculiarità del momento che stiamo vivendo” (p. 12). La storia innaturale della Sesta Estinzione è multipla: certo, mammut e pinguini, ma anche la scomparsa altrettanto macroscopica e raccapricciante di vaste tessere del mosaico vegetale terrestre, di interi ecosistemi complessi vaporizzati dall’oggi al domani, di paesaggi spazzati via come città di baracche da un tornado. L’exemplum animale ha una lunga tradizione letteraria, ci tocca empaticamente per prossimità biologica, è più facile da raccontare e da fare immaginare rispetto a Ganarake scalaris o Lobaria amplissima. In più, si potrebbe dire, l’estinzione è a tutti gli effetti un iperoggetto, non tanto per l’effetto domino che una singola “caduta” genera in tutto l’ecosistema, ma perché ogni specie si ramifica nello spazio e nel tempo in maniera così articolata e imprevedibile che è impossibile coglierla e studiarla come entità concreta. Possiamo seguire le tracce finali di un’ammonite o di un rinoceronte indiano, ma l’ammonite e il rinoceronte indiano saranno nel racconto dei semplici personaggi, delle funzioni narrative astratte travestite, grazie alle parole, di concretezza animale. Ovviamente, il libro di Kolbert è molto più di questo: “La storia scientifica dell’estinzione può essere raccontata come una sequenza di cambi di paradigma. Sino alla fine del XVIII secolo, la categoria stessa di estinzione in quanto tale non esisteva. Man mano che venivano dissotterrati i reperti ossei più strani – di mammut, di Megatherium, di mosasauro –, i naturalisti dovevano spremersi le meningi per riuscire a inserirli all’interno di una struttura concettuale che fosse loro familiare. E lo fecero per davvero: le ossa gigantesche appartenevano a elefanti trasportati dall’acqua verso nord, o a ippopotami che si erano smarriti in Oriente, o a balene con musi minacciosi. Quando Cuvier arrivò a Parigi, si accorse che il molare del mastodonte non era in alcun modo compatibile con la cornice concettuale preesistente; ci fu un momento di crisi che lo portò a mettere a punto una modalità del tutto nuova di guardare a quei reperti. La vita, Cuvier fu il primo a riconoscerlo, aveva una storia, e questa storia era segnata da perdite e costellata da eventi troppo terribili perché la mente umana potesse anche solo immaginarli. «Nonostante il mondo non cambi con un cambio di paradigma, dopo che esso si verifica lo scienziato lavora in un mondo nuovo» per usare le parole di Kuhn”.
La Sesta Estinzione di Elizabeth Kolbert ha due velocità. La prima, in corsia preferenziale, avalla la narrazione vulgata dell’estinzione come cardine del lutto antropocenico. La seconda, più problematica e controintuitiva, lavora per estrarre dalla Babele biologica un nuovo paradigma in grado di guardare questo fenomeno come un fatto anche culturale, cioè come nodo epistemologico della scienza e come grumo psicologico della mente contemporanea. Questo “secondo libro”, questo libro nel libro, va estratto accantonando una serie di pregiudizi e narrazioni che la stessa autrice è incline a cavalcare. Ma è appunto nelle zone meno giornalistiche che vediamo emergere la complessità bifronte dell’estinzione, in bilico tra “logoramento biotico” e “orrore” apocalittico, tra “esplosioni di panico” “in lunghi periodi di monotonia” e “cambi di paradigma”. Accettare la vulgata della colpa, ora come ora, significa ritardare il salto della faglia che i nuovi tempi ci chiedono. Produrre e sfogliare album di fotografie post mortem è un’azione che oscilla tra esercizio compulsivo della memoria e voyerismo macabro, ma se è vero che quando così tante vite animali e vegetali si perdono “è come se fosse stata incendiata una biblioteca”, allora il cambio di paradigma è dato: non si tratta di collezionare santini funebri ma di far parlare le specie scomparse come i rotoli di Ercolano o i palinsesti della Biblioteca Vaticana, non personaggi di un racconto antropocentrico/antropocenico, ma testi alieni e misteriosi da traghettare nel nostro qui come quel 2-4 % di geni di Neanderthal che molti umani moderni hanno scoperto di avere in sé.

Stiamo vivendo un momento peculiare, è vero. Probabilmente la nostra specie, come Sansone e i Filistei, sta per lasciarsi schiacciare dal peso delle sue stesse costruzioni tecno-retoriche, oppure, se troveremo un’improbabile e dolorosa via d’uscita, sarà come passare dall’Orto Botanico di Palermo al Molo Trapezoidale, da un’architettura vegetale carnivora e barocca a un arredo surmoderno elitista e veg. In quale delle due finzioni (perché entrambe lo sono) ci traghetta il discorso sull’estinzione ai tempi dell’Antropocene? Il malinconico planctus per uno zoo immaginario alla Rowling o l’arroganza demiurgica di un’Archistar del Post-Urbano-Urbanizzato che vede bellezza in foreste normalizzate in prati da golf e in animali normalizzati in piatti gourmet? Difficile non riconoscere anche qui una certa estetica del disastro che diventa estetica senza disastro, una cronicizzazione del lutto senza più il lutto, addirittura una tragicomica schizofrenia tra Sade e von Masoch al coro di “meritate/meritiamo l’estinzione!”. Davvero non c’è altro? Pensiamo invece a un tilacino, ai brevi filmati dei primi del Novecento che lo catturano per una manciata di secondi e che somigliano a un film di Murnau con gli effetti speciali di Giger. Quello che vediamo non è un endling, quello che la sua morte lascia non è il buco di un’intera famiglia linneiana. Quello che il corpo così alieno del tilacino sembra offrire, al contrario, è un sample di biologia postumana. Come sarà la vita sulla Terra senza di noi? Non importa. Noi saremo le ammoniti e i mammut di qualcun altro. E questo è tutto il mistero che ci serve per pensare il presente e il tornado biologico che abbiamo scatenato.









