I died for Beauty / La bellezza è una domanda
Quando Josif Brodskij, in occasione del conferimento del premio Nobel per la poesia e la letteratura, sostenne che uno dei principali problemi del nostro tempo è la volgarità, e che solo la bellezza avrebbe potuto salvarci, non avevamo forse compreso fino in fondo quanto fosse nel giusto. Ma si sa, è dei poeti vivere al di sopra delle proprie possibilità, come diceva sempre Luigi Pagliarani. Brodskij poi aggiunse che l’estetica è la madre dell’etica, perché la contiene, completando una diagnosi e un progetto per cambiare la nostra vita. Non l’abbiamo ascoltato. La volgarità, e non la bruttezza, si propone nel nostro tempo come il contrario della bellezza; così come l’indifferenza, e non l’odio, è il contrario dell’amore. Se il bello è passione e distacco; se è perfino un certo livello di disinteresse che separa il bello da altre forme di passione, anche il brutto è passione e richiede di essere capito e giustificato, come ha sostenuto Umberto Eco in un testo sul brutto, ora contenuto in Sulle spalle dei giganti, La nave di Teseo, Milano 2017. Ci rendiamo subito conto che siamo sulla soglia di noi stessi, al margine generativo del possibile, dove si profilano le condizioni per estendere e aumentare il nostro mondo interno e le frontiere del sensibile. È lì che si combinano la generatività creativa umana e la bellezza come estensione della capacità e delle possibilità di accedere al mondo e sentirlo, proprio per il distacco appassionato che ci coinvolge e, a volte, travolge.
Della creatività poetica di Osip Mandel’stam è stato scritto:
“Per lui non c’è distanza tra impulso e azione…”.
Guardando Mandel’stam “sembra di spiare il concreto lavoro fisiologico della creazione”, come si legge in Osip M. Mandel’stam, Quasi leggera morte. Ottave, a cura di Serena Vitale, Adelphi, Milano 2017.

Sempre Eco in Il nome della rosa aveva scritto: “tre dita tengono la penna, ma il corpo intero lavora. E dolora…”.
La bellezza rivela quello che senza la sua esperienza non avremmo sentito e incontrato, e allo stesso tempo, per farlo, ri-vela, pone un nuovo velo, una nuova soglia, una nuova domanda che prima di quella esperienza non saremmo stati in grado di porci. La bellezza non si lascia ricondurre a uno stato cristallizzato perpetuamente nella propria fissità. L’evento o l’avvento della bellezza, il suo emergere, è sempre un processo, una tensione: quest’ultima è, probabilmente, lo stesso modo di essere della bellezza. Con la bellezza siamo di fronte a uno slancio continuamente ripetuto, che ogni volta si presenta come nuovo. In quanto unici e capaci di presenza, cioè di esserci e di sapere di esserci, noi esseri umani tendiamo alla pienezza della nostra espressione e siamo virtualmente abitati dalla capacità di creazione e di bellezza, soprattutto dal desiderio di bellezza. Siamo in grado di trascenderci tendendo all’oltre rispetto a quello che siamo già e che c’è già: siamo in grado di interrogarci e di manifestare la dimensione esclamativa dell’aperto. Quella provvisoria e relativa socchiusura del dominio di senso e dell’universo dei significati, ci porta sulla soglia dell’inedito e a un’estensione di noi stessi e ha a che fare con l’accessibilità alla bellezza. È, parafrasando Coleridge – che ha cantato la lanterna di poppa, che diventa traccia del viaggio del marinaio – che possiamo immaginare una lanterna di prua in grado di illuminare e indicare la via dell’accessibilità al possibile che abbiamo davanti. La bellezza sembra essere frutto di una vista superiore alla vista sensibile, l’epopteia, cioè la capacità di vedere più in là. Ciò ci porta oltre il primato dell’occhio e della visione come fondamenti dell’esperienza di bellezza. Se l’esperienza di bellezza è connessa a quella estetica, non può essere ridotta alla visione e al piano sensibile, ma esige il coinvolgimento corporeo emozionale. Sono proprio l’assenza di distanza tra “impulso” e “azione” e “il concreto lavoro fisiologico della creazione” che interessano, nel momento in cui ci troviamo a cercare di comprendere cosa si possa intendere per bellezza.
Se non ci consegniamo alla riduzione del concetto alla cosmesi, all’esteriorità o alla classica isola che si staglia dallo sfondo configurando uno stato di eccezionalità, allora è nei labili confini tra la creatività, l’esperienza estetica e l’immaginazione che dobbiamo provare a cercare. Certo, la creatività si propone come una distinzione specie-specifica di homo sapiens ed è strettamente connessa alla nostra competenza simbolica e al nostro linguaggio verbale articolato. Essa può essere definita come la capacità di comporre e ricomporre in modo almeno in parte originale i repertori disponibili del mondo. È dipendente dalla discontinuità e dalla elaborazione di break-down che interrompono la consuetudine e sospendono almeno temporaneamente i domini di senso. Sporgersi sulla soglia e intravedere quello che prima non c’era è un processo correlato all’esperienza di bellezza, così come è correlato alle esperienze di terrore. Tra bellezza e terrore vi è una forte tangenza ed entrambi hanno a che fare con l’esperienza estetica, se l’estetica non è ridotta a qualche canone dominante ma comunque provvisorio. L’estetica, infatti, riguarda la struttura che connette e le sensazioni (aisthanomai) che emergono da quelle connessioni in grado di indicare una ulteriorità di senso, di tendere oltre. L’esperienza estetica emerge, infatti, da una tensione rinviante che attiva la propensione all’eccedenza e alla trascendenza dei domini di senso vigenti, una tensione che rinvia ad altri sensi e ad altri significati che senza quella tensione non sarebbero emersi [cfr. U. Morelli, Mente e bellezza. Arte, creatività e innovazione, Allemandi & C, Torino 2010; post-fazione di Vittorio Gallese]. L’esperienza di bellezza esige la complessa interdipendenza di queste dinamiche e non può essere confusa con l’esteriorità o con la riduzione a un canone dominante.
Una comprensione della bellezza da un punto di vista evolutivo, richiede di collocarla nelle espressioni emergenti dell’evoluzione umana e di connetterla al rapporto tra corpo-cervello-mente e mondo. Richiede, inoltre, di collocarla nell’intersoggettività come fondamento e base dell’individuazione e dei comportamenti, essendo la bellezza e l’emergenza estetica che la genera un’esperienza sociale.
A partire da queste considerazioni la bellezza può essere riconosciuta come un’esperienza di risonanza particolarmente rilevante con gli altri e il mondo, tale da estendere il modello e il sentimento di sé. Così come un’esperienza di terrore genera una minorizzazione di quello stesso sentimento di sé.
Se si assume questa prospettiva evolutiva e neurofenomenologica nel tentativo di comprendere la bellezza, risulta difficile condividere le considerazioni che ritengono che “per ciò che riguarda la bellezza si è semplicemente spettatori, si è passivi, ci si trova in uno stato di stupore, di meraviglia”, come sostiene Umberto Galimberti, in Il mistero della bellezza, Orthotes, Napoli-Salerno 2016.
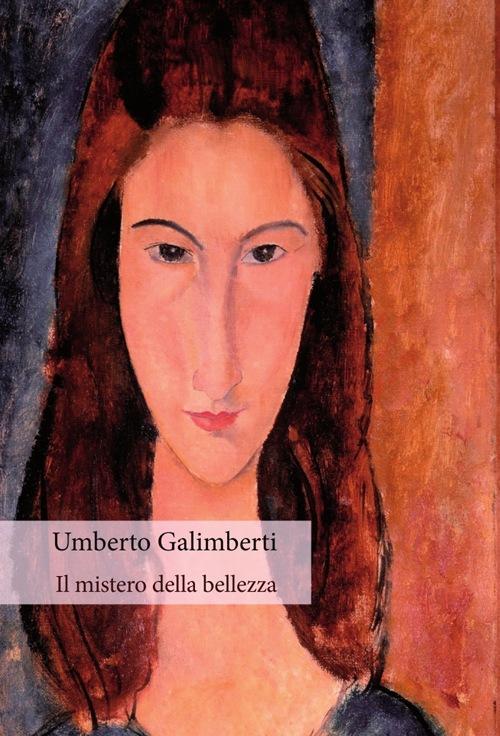
Sia la prevalente attenzione alla visione che la riconduzione della bellezza a un canone richiedono una riconsiderazione della bellezza e della sua esperienza e funzione nella nostra vita. Un’eco del canone, connessa alla relatività dell’esperienza del bello la troviamo, con la consueta ironia, nel Dizionario filosofico di Voltaire:
“Chiedete a un rospo che cosa è la bellezza, il vero bello, il to kalòn. Vi risponderà che consiste nella sua femmina, coi suoi due begli occhioni rotondi che sporgono dalla piccola testa, la gola larga e piatta, il ventre giallo e il dorso bruno. Interrogate un negro della Guinea: il bello consiste per lui nella pelle nera e oleosa, gli occhi infossati, il naso schiacciato. Interrogate il diavolo: vi dirà che il bello è un paio di corna, quattro zampe a grinfia, e una coda”.
Ancora una volta dominano in queste note sarcastiche e straordinarie la visione e il canone. Come se fossimo solo occhi e avessimo un solo punto di vista. Siamo invece un corpo con un sistema sensori-motorio che esprime emozioni alla base della nostra cognizione. Siamo homo sapiens sapiens e disponiamo di competenza simbolica e linguaggio verbale, oltre che di un sistema corpo-cervello-mente neuroplastico che è alla base della nostra intersoggettività costitutiva. Per confrontarsi con la bellezza pare perciò necessario uscire da quella che Umberto Curi definisce “una prospettiva vagamente soggettivistica, o addirittura soggettivistica di gusto”, nel piccolo e importante libro Il tempo della bellezza, Orthotes, Napoli-Salerno 2017. Curi si mette nelle mani di Simon Weil che in uno dei Quaderni redatto a Londra poche settimane prima della morte nel 1942, affrontando il tema della bellezza, scrive: “Tutte le volte che si riflette sul bello, si è arrestati da un muro. Tutto ciò che è stato scritto al riguardo è miserabilmente ed evidentemente insufficiente” [S. Weil, Quaderni, IV, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1993; p. 371]. Non solo, ma valorizzando come sempre i classici, Curi richiama la concezione Plotiniana del bello e il legame tra to kalòn e thàmbos, cioè tra l’apparire del bello e quella forma di páthos che è lo sgomento. In tal modo la bellezza è sottratta ad ogni forma privilegiata o canonica; non risulta riconducibile a un calcolo geometrico della proporzione, né si identifica con la perfetta simmetria degli elementi che la costituiscono, ma, secondo Curi, si associa all’Armonia, vivendo della tensione inesauribile fra la forza distruttiva di pólemos e il dinamismo che congiunge dell’éros. Pur trovando criticabile l’associazione della bellezza con l’integrità, la compiutezza e l’armonia, in quanto, come lo stesso Curi riconosce, il thámbos è un sentimento fatto allo stesso tempo di timore e meraviglia, di stupore e paura, possiamo riconoscere come la bellezza non sia affatto una questione di “gusto”, come abbiamo già in parte sostenuto, ma appartenga “a un piano in cui può accadere che all’improvviso lampeggi l’essere”, non come pacifica manifestazione, ma come un evento capace di suscitare sentimenti basati su emozioni di base che contengono simultaneamente desiderio e paura, ricerca, curiosità e tensione, sgomento e meraviglia.
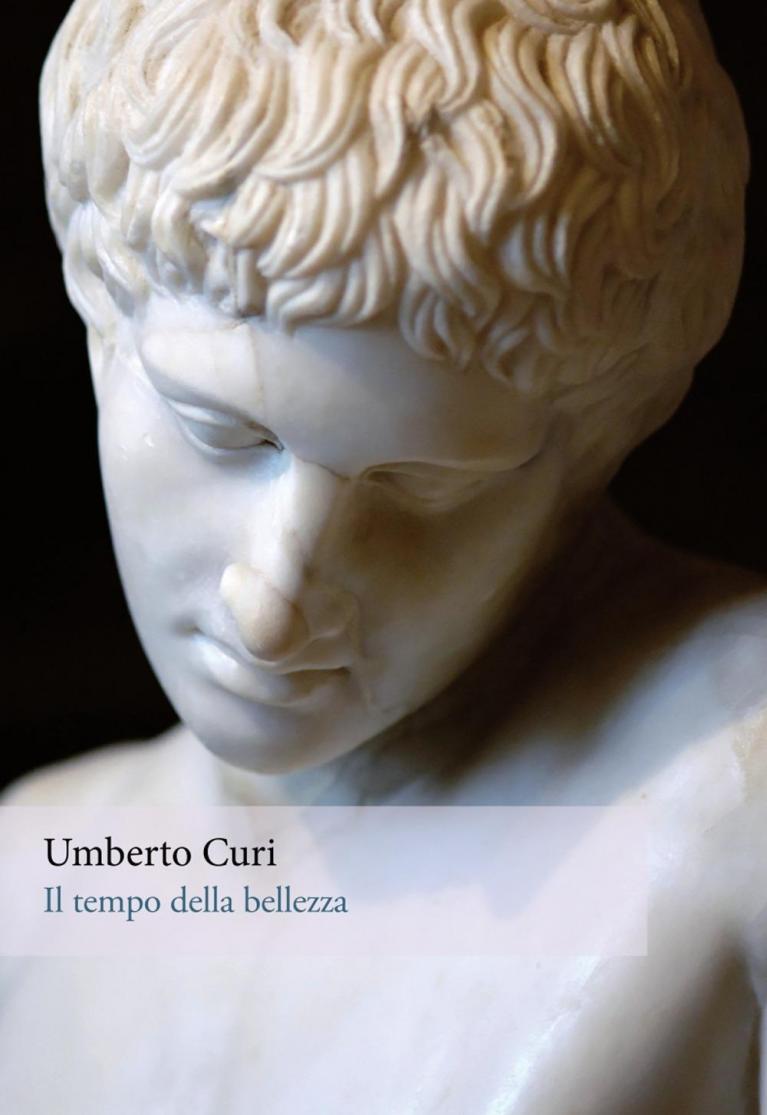
Allora quel muro che Simone Weil aveva indicato, può forse essere affrontato accogliendo i suoi stessi suggerimenti, quando sostiene in un quaderno del 1941 che “il bello è l’apparenza manifesta del reale. Il reale è essenzialmente la contraddizione”. […] “L’essenza del bello è contraddizione, scandalo e in nessun caso mera convenienza, pacifico accordo. È scandalo che si impone e colma di gioia”. La contraddizione pare che stia tra il consueto dominio di senso in cui tendiamo ad abitare e la ricerca e il rimando a una ulteriorità di significato, sporgendosi sulla soglia del sentire possibile. Come ha scritto Daniele Del Giudice: “nel lavoro di creare conta tutto quanto eccede il progetto”. Quando la realtà, qualunque essa sia, riesce, accoppiandosi con noi, a rivelare un’eccedenza di significato rispetto al significato che consuetamente le attribuiamo, ci porta a un lampo nel buio della continuità, facendoci vivere una tensione rinviante verso una ulteriorità di senso, come lo stesso Galimberti tende a riconoscere verso la fine del suo contributo prima considerato.
Se pensiamo a una particolare manifestazione della bellezza, quella che riguarda il pensare e l’agire politico inteso come tensione verso il quadro del possibile oltre l’esistente, dove si muovono sia il linguaggio poetico che quello filosofico, possiamo riconoscere che “la bellezza aspira ad un oltre ed è al contempo segnata dalla caducità e dalla morte”, come scrive Franco Rella in Quale bellezza, Orthotes, Napoli-Salerno 2017; p. 7. Oggi, in particolare, è necessario pensare la libertà e ripensare la politica. Il possibile accessibile e permesso rende impotenti politicamente, nella maggior parte dei casi: la via sta nel pensare l’impossibile. È per ciò stesso necessario continuare a parlarsi. Sfidando la domanda posta da Daniele Del Giudice in una conversazione: “con chi parli?”, riconoscendo che la principale difficoltà è nel parlarsi [D. Del Giudice, Lezione magistrale, Scuola di scrittura creativa, Trentino School of Management, Trento, 2009]. Le possibilità di creare democrazia sono connesse alla parola condivisa, magari conflittualmente. In questo sta, secondo Del Giudice, il rapporto tra estetica ed etica della scrittura. Ma anche, viene da aggiungere, della creazione artistica e dell’innovazione sociale tout-court; non per assimilarle ma per riconoscere le comuni dinamiche che sottendono alla possibilità degli esseri umani di vivere la vita come un progetto e un’invenzione. L’istituzione immaginaria della società e il processo istituente, secondo C. Castoriadis, sono la via per la quale cercare di divenire liberi e uguali [Cornelius Castoriadis, Psicanalisi e immaginazione radicale del soggetto, intervista, 7 maggio 1994, Enciclopedia Filosofica Multimediale]. L’istituzione immaginaria è un atto creativo, in grado di connettere l’immaginazione alla creatività, appunto. È qui che si situa il valore decisivo del rapporto tra bellezza e vita individuale e sociale: nella possibilità di portare la ricerca dell’espressione di sé oltre il consueto e l’esistente, verso l’inedito e la creazione di quello che prima non c’era. Nel rapporto di tensione tra regole e libertà, tra istituito e istituente, la possibilità di estensione di sé e di creazione dell’innovazione, la possibilità di esprimere esperienze estetiche e creative, è decisiva per la progettualità sociale e la democrazia. Emerge quindi una responsabilità a esercitare l’immaginazione e l’estetica della creazione come imperativo etico per la democrazia.
In tal senso si muove il contributo di grande rilevanza di Cora Diamond, nel momento in cui pone in relazione l’immaginazione e la vita morale [C. Diamond, L’immaginazione e la vita morale, Carocci, Roma 2006]. In proposito Del Giudice mette in tensione la capacità di fare vuoto dentro di sé e le possibilità dell’immaginazione: “Le cose accadono se tu sei capace di essere vuoto; e qualche volta arriva un’immagine, un suono…”. La letteratura, continua lo scrittore, non è una cosa che deve essere costruita, “le cose arrivano se sei capace di guardare, di entrare dalle cucine, di essere una spugna; devi farti attraversare”. Nella sua “conversazione sull’animale parlante” Del Giudice sostiene che “nel lavoro di creare conta tutto quanto eccede il progetto”; non per niente egli racconta che il suo rapporto con la scrittura si evolve quando si trova di fronte all’affermazione di Roberto (Bobi) Balzen: “Io non scrivo letteratura ma note al testo”. “Adesso ti vengo a cercare” si è detto lo scrittore, di fronte a quella affermazione. Henri Poincaré ha sostenuto che “creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili”. È, forse, proprio l’utilità il parametro che può consentire di distinguere la creatività nella progettualità sociale, nel lavoro, nella politica, nell’educazione, nella formazione e nella vita quotidiana, dalla creatività che, su una stessa linea di continuità ma con intensità diversa, agisce nell’esperienza estetica e nella produzione artistica. In ogni caso c’è un conflitto con il consueto e l’abitudinario, con il conforme, e con il linguaggio. Quel conflitto implica la ricerca per tendere a mettere in luce la parte in ombra del linguaggio, ma anche per custodire quella stessa parte in ombra. Si può dire solo una parola alla volta quando se ne vorrebbero dire due o più contemporaneamente e allora è decisivo confliggere e farsi guidare dalla dinamica emergente, riconoscendo che “l’autore è solo il primo lettore di un testo narrativo”, come sostiene Del Giudice. Oltre alla vanificazione del progetto per lasciare emergere la creatività, il racconto e la bellezza, in letteratura come nella vita le cose più importanti nella relazione con l’altro, dove l’altro con noi lavora, stanno nella zona d’ombra. Diviene necessario e fondativo, quindi, affrontare la crisi del legame sociale, oggi, e l’incapacità di vivere con gli altri, reinventando la capacità e la possibilità di parlarsi.
La bellezza e lo splendore del segreto delle cose non può essere catturato, così come non abbiamo accesso alla completezza che pure siamo in grado di concepire. Possiamo farci penetrare dalla bellezza e dallo splendore goccia dopo goccia e nel momento in cui ci sembrerà di essere riconosciuti e accolti dalle cose stesse, allora insieme ad esse potremo forse cantarne qualche aspetto; potremo forse essere dalle cose stesse cantati. “Bello è quel che dà a chi guarda la misteriosa certezza di essere riconosciuto e accolto”, scrive John Berger. Nello Zohar, il libro dello splendore, il cuore della mistica ebraica, è indicata la via per andare al di là della conoscenza: “Il mio occhio ha visto ciò che non avevo visto mai e mi sono levato come non avrei mai creduto” [Zohar. Il libro dello splendore, Einaudi, Torino 2008]. Andare al di là della conoscenza è tutt’altro che un cammino a tentoni nel buio, o un consegnarsi a qualche forma di magia. Il segreto delle cose è luce nelle sue inesauribili rifrazioni di colore. È soprattutto un atto spirituale che mantiene sull’orlo della catastrofe del fallimento mentre si continua a cercare, non potendo smettere di farlo. Dipinge, scrive, scolpisce, cerca, chi non può far altro che farsi attraversare dall’infinito delle cose e dalla loro prorompente invasione, prestando se stessi a filtrare il mondo e a flirtare con esso. Chi accoglie la propria finitudine non come una fonte di ansia e disperazione che porterebbe al delirio di onnipotenza, ma chi si sa riconoscersi transeunte, errante e passeggero, e per questo suo essere vulnerabile si dissolve nei mondi che incontra per farsi uguale ad essi e poterli, alfine, raccontare col colore, con la parola, con il suono. Quel racconto ci avrà così restituito una luce nel caos del reale e ci avrà fatto cogliere quello che da soli non avremmo visto, pur essendo stati sempre lì. In fondo avremo così avuto la possibilità di comprendere che il solo modo per vivere il tempo è partecipare del suo scorrere o, magari, della sua eterna immobilità.
Cercando la via per una riunificazione, in un quadro naturalistico e critico, dello studio della mente relazionale e della cultura, l’esperienza estetica può essere un campo di ricerca effettivamente propizio. Cercando, inoltre, di comprendere il vertice della creatività e della bellezza sarà forse possibile riconoscere qualcosa di più delle ragioni del conformismo e della tensione all’inedito e all’innovazione che, quotidianamente, tutti sperimentiamo nella nostra vita.
È viva la sensazione e la constatazione che ripensare la politica e la libertà non sia possibile senza l’attraversamento di conflitti profondi e diffusi. Il conflitto più impegnativo è forse proprio quello estetico, anche per quanto riguarda la politica. Quanto più è necessaria, oggi, una sua ri-figurazione, tanto più è urgente la bellezza di un progetto capace di affrontare le contraddizioni del presente, sollevandosi dalla saturazione dei linguaggi e delle pratiche presenti [sulla saturazione si veda U. Morelli, Verso il sesto assunto di base. Horror vacui, horror pleni (di alcuni conflitti psicoculturali) nella vita dei gruppi. Uno studio su conformismo e saturazione, Educazione sentimentale, 11, 2009].
Quello che appare sempre più necessario è un pensiero la cui potenza di illuminazione sia capace di crescere in proporzione ai conflitti e all’indignazione etica che molti aspetti del presente suscitano.
Ad essere necessario è un pensiero che si sviluppi lungo una piega capace di muovere la sensibilità e l’intelligenza a incontrare il punto di vista dell’altro. Sia che l’altro si presenti come il debole e l’ultimo, sia che proponga il volto mellifluo e inafferrabile dell’indifferenza e della fungibilità delle relazioni.
Necessaria è una svolta anche sconcertante, capace di generare discontinuità al limite dello scandalo. Di questo la bellezza è capace. Come accadde a Duchamp in occasione del suo primo viaggio a New York, dove arrivò con un’ampolla di vetro contenente aria di Parigi. L’incontro con Picabia e Man Ray generò il gruppo del dada americano e in quella circostanza Duchamp espose il primo ready made, Fountain, l’orinatorio rovesciato, creato nel 1917 e rifiutato dalla Society of Indipendent Artists.
Fountain, com’è noto, finirà al MoMa. Allo stesso tempo sarà Pierre Pinoncelli, esponente del cosiddetto “happening di strada”, a finire in prigione per un mese per aver riportato la Fontana di Duchamp alla sua primitiva funzione, mettendo a segno il suo colpo più ambito nel corso di un’esposizione al Carré des Arts di Nimes, il 24 agosto 1993. Come mai Pinoncelli finisce in prigione e la sentenza del 20 novembre 1998 stabilisce un’ammenda a suo carico pari a circa novanta milioni di vecchie lire, dopo che il Centre Pompidou e la compagnia di assicurazioni Axa si erano costituiti parte civile contro di lui? Perché la performance di Pinoncelli non è ritenuta un’opera d’arte? Avrebbe potuto diventarlo se fosse stata filmata? L’esperienza estetica è un’esperienza storica e sociale e ci mostra, tra l’altro, che l’innovazione e la discontinuità sono possibili. Mentre ce ne rendiamo conto, scopriamo che il cambiamento è una costante e non si identifica con l’innovazione. L’innovazione è possibile e può affermarsi anche quando comporta trasformazioni di elevata discontinuità, ma richiede investimento in bellezza e dedizione. La democrazia è, per molti aspetti, un processo di continua creazione e discontinuità di equilibri instabili e soluzioni sub-ottime; è una forma di governo alla ricerca dell’eccedenza di se stessa nell’incertezza, più che un governo dell’incertezza.
Per questo riteniamo di non poterci limitare a considerare la bellezza come “ciò che ci piace, ciò che noi vediamo e ci colpisce immediatamente, perché alla vista appare in possesso di una bella forma”, come sostengono M. Bettetini e S. Poggi, in La bellezza è quella cosa…, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.
Un modo per riconoscere le possibilità della bellezza, il suo essere una tensione e una domanda che connette i nostri sistemi emozionali col mondo intorno a noi, è riflettere su quello che a tutti gli effetti possiamo ritenere uno dei suoi contrari: il fanatismo. Nel suo ultimo libro, Shalom Laqanaim. Cari fanatici, Feltrinelli, Milano 2017, da par suo, Amos Oz ci fornisce una straordinaria riflessione sul fanatismo e l’integralismo, riconducendoli a quello che egli chiama “un cervello ben lavato”, intriso di mortificazione e riduzione, e contrapponendoli alla bellezza e all’umorismo, generativi di estensione e amplificazione: a un “primo accenno di femminile compassione”. Il fanatismo e l’integralismo sono, secondo Oz, “risposte fatte di una sola frase” [p. 15]. Con essi “la salvezza si definisce facilmente con uno slogan di due o tre frasette” [p. 17]. “I fanatici definiscono traditore chiunque abbia il coraggio di cambiare” [p. 18]. Fanatismo e integralismo danno l’illusione di soddisfare “la sete sempre più incalzante di soluzioni semplici e categoriche, di una salvezza pronta all’uso” [p. 19].

La bellezza, invece, può essere intesa come un investimento continuo “contro l’irreversibile” [p. 104]; contro quella tendenza che Elena Pulcini, in Specchio, specchio delle mie brame… Bellezza e invidia, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, denuncia come una tendenza in atto che pregiudica o distrugge la bellezza, “in cui Stendhal vedeva una promessa di felicità e Dostoevskij la capacità di salvare il mondo, Emily Dickinson ciò per cui, come la verità, si è disposti a morire (I died for Beauty), e Oscar Wilde ciò che regna sovrana per diritto divino…” [pp. 86-87].
Fino a quando la bellezza rimarrà identificata con un canone esteriore, non riusciremo a sentirla agire in noi per quello che effettivamente può fare: estendere e aumentare le nostre possibilità, le nostre azioni e la concezione di noi stessi.
La bellezza, quindi, è una domanda infinita che può generare l’oltre. Ce lo conferma la poesia e, in particolare, una poetessa come Agi Mishol:
“Il cuore forse è infranto ma non vedermi
così e con tutto il rispetto per il Rebbe di Kotzk
vi è qualcosa di più integro di quello
poiché sono una poetessa e so
come una formica
scendere agli inferi con una pagliuzza
e risalirne con un chicco di grano”.









