Diagnosi / La malattia e i suoi nomi
Mia nonna materna è morta di cancro nella Jugoslavia degli anni sessanta del secolo scorso, ma il termine non era contemplato, né in pubblico né in privato. Nemmeno “brutto male” si diceva. Si moriva e basta, si alzavano gli occhi al cielo o si puntavano a terra, il perché della dipartita era un mistero che ai bambini appariva ancora più grande. Non ci si doveva pensare, l’uomo nuovo socialista non era previsto si ammalasse, fosse vulnerabile, perché questo ricordava la sua ineluttabile condizione umana dove la sorte collettiva si declina al singolare. Infatti, a Praga come a Dresda, tra tutti i libri vietati dell’epoca, proibitissimo era Riflessioni su Christa T. di Christa Wolf, la storia di una giovane donna malata, che tiene un diario e racconta la sua lotta con la leucemia.
Ogni periodo storico e ogni cultura si possono studiare, e forse un po’ capire, dalle modalità sempre diverse di dire e rappresentare, di chiamare la malattia, di definirla. Dunque, dalla sua diagnosi. L’annuncio dipende dai toni e dagli umori, dalla formazione e dalla postura del medico. Tra paziente e diagnosi si instaura un rapporto dialettico, ma non sempre il medico riesce ad essere farmaco.
È questa relazione triangolare, che tutti ci riguarda, il tema di Diagnosi e destino (Einaudi), dove Vittorio Lingardi, a partire anche dai suoi ricordi di vita e dalla sua esperienza di clinico, scrive un testo veloce, che si legge d’un fiato, mentre intreccia testimonianze, testi letterari e storie mediche. Davanti a una diagnosi più o meno nefasta ritorniamo, per usare un’espressione di Elvio Fachinelli, come “i nostri arcaici”, siamo tentati di ricorrere a riti scaramantici e a pratiche magiche, abbiamo bisogno di tempo per collocare quanto ci sta capitando in un orizzonte di senso che permetta al nostro io di non perdere la sua centralità. La malattia fa gerarchia, interrompe la routine, rimette in riga affetti e valori, costringe a pensare al percorso di vita, alla relazione con le origini – in previsione del matrimonio molte coppie ora si regalano il test per stabilire il dna, per conoscere il codice genetico di un futuro erede, per rassicurarsi sull’identità e sull’eredità, per prevedere possibili malattie.
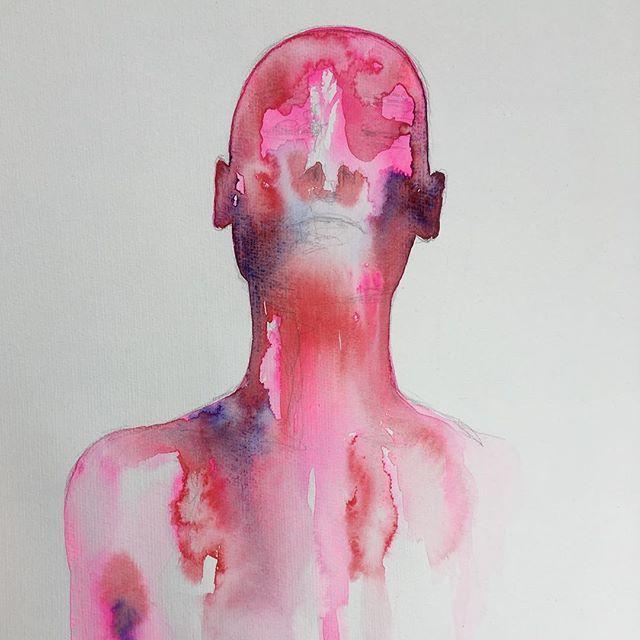
Opera di Wiebke Kackenmester.
Nel suo argomentare Lingiardi fa dialogare le esperienze e le riflessioni diverse di Susan Sontag e Virginia Woolf. Nel pamphlet, Malattia come metafora, uscito nel 1978, quando ribellarsi pareva la strada per cambiare anche il modo di vivere la malattia, per strapparla al senso di colpa di origine religiosa che l’accompagnava, per liberarla dallo stigma sociale che trattava il malato come un appestato, Sontag scrive “non c’è niente di più primitivo che attribuire a una malattia un significato”. Sarà un concetto che poi amplierà in L’Aids e le sue metafore e, anni dopo, a chi le chiede come fare senza risponde: “Si vive. Partecipi al tuo trattamento, hai speranza. Metafora è una parola in codice per falsa rappresentazione, sciocchezza. Idea sbagliata. Senza metafore la gente starebbe meglio”. Per lei metafora è una sofferenza aggiuntiva, un fattore di stress, qualcosa, si direbbe oggi, che rischia di diminuire, invece di accrescere, la nostra immunità.
Nello scritto di Virginia Woolf, Dell’essere malati (1930), la malattia è invece “il grande confessionale”, l’occasione di una ricerca, dove il corpo schiavizza la mente e la letteratura può esplorare un nuovo spazio. “(…) spesso la malattia prende le sembianze dell’amore, e gioca sempre gli stessi vecchi trucchi, investe certe facce di divinità, ci fa aspettare, ora dopo ora, con le orecchie tese allo scricchiolio della scala, adorna le facce degli assenti (abbastanza normali quando in salute) di nuovi significati, mentre la mente imbastisce su di loro migliaia di leggende e romanzi, per cui non ha né tempo né libertà in salute”.
Dimensione culturale e sociale e senso individuale rendono tuttora cruciali entrambi i testi. Perché la riflessione di Susan Sontag può aiutare il malato, gravato dalla richiesta continua di performance, dove anche al morente viene chiesto di reagire, a non sentirsi in colpa per essersi ammalato. A non vivere il suo stato come un deficit dovuto a qualche mancanza – non ho smesso di bere, fumare, tradire, mangiare –, perché l’odierna abitudine al controllo e alla cura del corpo, investe il soggetto della colpevolezza della sua fragilità. E quella di Virginia Woolf, che insiste sulla trasformazione del linguaggio, sulla necessità di dare spazio e tempo e parola al tema della malattia, accresce il potere del soggetto nel momento in cui rischia di diventare solo un oggetto. E lo invita a cercare e dare un significato intimo e privato al cambiamento imprevisto. Perché ognuno si confronta in modo diverso con la propria mortalità. Che deve integrare da solo.
Lo stesso concetto di privatezza è legato alle modalità di comunicare una diagnosi: una volta davanti al malato si taceva, oggi gli si snocciolano probabilità statistiche di sopravvivenza. Tutti dobbiamo firmare fogli incomprensibili al profano che la legge sulla privacy fa terminare con la domanda fatidica “a chi volete sia comunicato quanto vi capita”, con risvolti ben noti e drammatici quando la vita relazionale non è conforme alla norma sociale. Si proclama un approccio olistico, ma i medici di base, che potrebbero e dovrebbero riunire in un file solo la biografia medica del paziente, sono in via di sparizione.
La malattia si trasmette attraverso il suo racconto. Il nostro bisogno di storie, di farci storie, nei momenti difficili non diminuisce ma aumenta. In una dimensione dove la soggettività, come ben indica la medicina narrativa, regna sovranissima nelle oscillazioni tra detto e non detto, bisogno di spiegazioni scientifiche, consolazioni e coccole. Questo è il compito difficile per il medico che ricerca un’alleanza terapeutica: utilizzare il meglio di quanto mette a disposizione la tecnica insieme all’ascolto di un altro, impaurito e denudato. Il chirurgo fiero del suo robottino che seziona con precisione millimetrica è la stessa figura che i parenti attendono in corridoio come messaggero di notizie, mentre la lunga formazione, seppure in modificazione per le giovani generazioni, non prevede nemmeno un esame dove si impara e fare un colloquio (in proposito tutti abbiamo aneddoti tragicomici).
Lingiardi ripercorre lo slittamento semantico da cancro a neoplasia, che scorre in parallelo alla possibilità di passare dalla vergogna all’accettazione individuale e collettiva − “negli Stati Uniti dei primi anni Cinquanta il “New York Times” rifiutò di pubblicare l‘annuncio a pagamento di un gruppo di sostegno per malate di cancro al seno. Le parole cancro e seno furono considerate impubblicabili (tanto che un giornalista suggerì di sostituirle con l’espressione disturbi alla gabbia toracica)”. Fa la storia di altre parole chiave – isteria, ipocondria, trauma, omosessualità – che hanno viaggiato insieme ai passaggi d’epoca mutando di significato.
Quando a dover essere definita è la salute mentale di un individuo, il dibattito rimane aperto e interseca in parte la differenza di posizionamento tra psichiatria e psicoanalisi. Lingiardi, che nella sua esperienza professionale incrocia entrambi i ruoli, crede nella possibilità di inquadrare il paziente alla luce di categorie più generali senza dimenticare la sua unicità. Per questo ha recentemente curato, con la collega americana Nancy McWiliams, un manuale diagnostico, il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2), non tanto una “tassonomia di disturbi” quanto “una tassonomia di individui che presentano un disturbo”.
E in Diagnosi e destino è Lingiardi stesso a inseguire una sintesi tra classificazioni diagnostiche e intermittenze poetiche.









