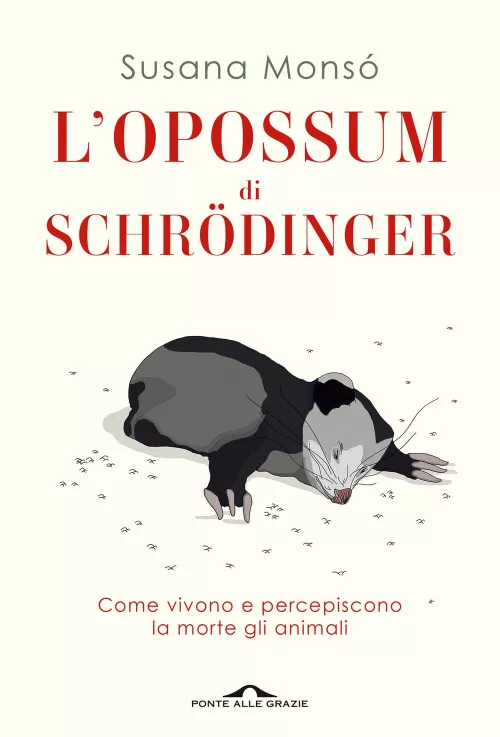L’opossum di Schrödinger
L’opossum è un marsupiale originario del continente americano. Ha l’aspetto di un roditore, una via di mezzo tra un sorcio e un procione. Il capitano John Smith, all’inizio del Seicento, lo descrisse come un animale con “testa di maiale, coda di ratto e dimensioni di gatto”. Una fisionomia del tutto inusuale, che però passa in secondo piano di fronte alla trasformazione che l’opossum compie quando si sente minacciato.
Se non vede vie di fuga, infatti, si paralizza, si sdraia su un fianco in posizione fetale, arrotola la coda, spalanca occhi e bocca estraendo la lingua, che da rosa diventa azzurrognola. Quindi comincia a salivare, orinare e defecare, mentre dalle ghiandole anali rilascia un liquido verde maleodorante. Nello stesso tempo riduce la temperatura corporea, il ritmo cardiaco e la respirazione. E non reagisce a nessuna sollecitazione esterna, nemmeno al taglio della coda. Morto. O meglio, perfettamente identico a un cadavere. Vivo e morto, contemporaneamente.
È riflettendo su questa straordinaria metamorfosi – in un libro, L’opossum di Schrödinger (tradotto da Elisa Tramontin ed edito da Ponte alle Grazie) che nel titolo si richiama alla paradossale condizione del gatto vivo e morto descritta dal fisico viennese – che la filosofa spagnola Susana Monsó, interrogandosi sul rapporto tra gli animali e la morte, trova la conferma di cui è alla ricerca. La scelta dell’opossum è, con tutta evidenza, una risposta alla pressione selettiva: il curioso animale fa (o diventa) quello che i suoi predatori ritengono sia un cadavere. L’opossum – la categoria di animali esperti della cosiddetta tanatosi è però lunga e trasversale tra le specie – è dunque la prova, indiretta ma convincente, che gli animali possiedono un concetto della morte, ovvero sanno cosa sia, ne hanno percezione.
La questione è ovviamente tra le più spinose e complesse, perché, più che qualsiasi altra, chiama in causa il nucleo costitutivo dell’essere uomini. La morte, per noi, è tutto. È inevitabile allora che il principale ostacolo alla comprensione di come gli animali si rapportino alla morte sia rappresentato dall’antropocentrismo, declinato nelle sue due fisionomie, intellettuale ed emozionale. Gran parte del libro di Monsó è dedicato proprio al tentativo di liberarsi – fin dove è possibile – dai lacci di una visione orientata esclusivamente sulla nostra idea della morte. Perché, se non si fa questo sforzo, appare evidente che difficilmente si possa arrivare ad ammettere che gli animali ne abbiano una. Il nostro modo di affrontare la morte è unico e permeato di intellettualismo.
Il culto e i rituali che le associamo, la reazione emotiva che ne discende nella fase del lutto (segno di un legame affettivo col defunto, non di un’idea della morte) non hanno paralleli tra gli animali non umani. Ma non per questo si può pensare che solo noi sapiens possediamo il concetto della morte. Semplicemente, come Monsó spiega, gli animali lo possiedono in altre forme (l’antropocentrismo intellettuale conduce alla logica binaria dell’o tutto o niente, ma ci possono benissimo essere gradi diversi di percezione) e lo manifestano con le reazioni emotive più disparate, che noi possiamo cogliere e comprendere soltanto in minima parte, anche per via dei limiti connaturati a una fase sperimentale affidata alla raccolta casuale e aneddotica di informazioni.
Senza dimenticare però che talvolta – soprattutto tra i primati, alcuni cetacei e gli elefanti, per i quali possiamo parlare di comportamenti affiliativi verso i morenti e di cordoglio verso i morti – le reazioni si avvicinano alle nostre. In tal caso bisogna evitare di commettere un altro errore, quello che è stato definito antropectomia, determinato dal negare che qualsiasi comportamento degli animali non umani possa essere sovrapponibile – essere simile nelle cause e nei fini – al comportamento degli umani.

A rendere ostico l’approccio al tema del rapporto tra gli animali e la morte è, in definitiva, ciò che noi vi vediamo annesso: il dover ammettere la caduta dell’ennesimo baluardo costruito nei secoli per distinguere sapiens dagli altri viventi. Come scrive l’autrice, infatti, se “né l’uso di strumenti, né la cultura, né la morale, né la razionalità sono un’esclusiva dell’essere umano”, anche il concetto della morte rientra tra le prerogative comuni. Il nostro rientro tra le specie viventi, la caduta degli dei, da Darwin in avanti si fa ogni giorno più evidente. E, forse, è intollerabile per chi si pensa ancora vertice di qualcosa o soggetto ontologicamente differenziato (leggasi superiore) dagli altri viventi.
Il libro di Monsò, a ben vedere, è una sorta di manuale. Traccia la strada che si deve seguire per abbandonare posizioni calcificate dall’abitudine e acquisire un’altra prospettiva (perché di questo si tratta, guardare da un altro punto di osservazione quanto ci sta attorno). Ebbene, per ridurre le distanze tra la nostra percezione della morte e quella propria delle altre specie (che è comunque pericoloso intendere come un blocco compatto, senza differenziazioni) il primo passo da compiere consiste nel separarsi dall’astrattezza.
In che modo? Per gli uomini, soprattutto contemporanei e occidentali, il contatto con la morte è contrassegnato dall’assenza. Il morto è colui che non incontriamo più. Secondo la nostra prospettiva, la morte avviene sempre altrove e di lei si annullano rapidamente le tracce. Essere morto significa di conseguenza entrare in una condizione di separatezza che ormai è diventata dominante ad ogni livello, si pensi alla trasformazione che subiscono i corpi degli animali destinati a diventare cibo, che giungono sui banchi dei supermercati privi di forma e ripuliti da ogni traccia di quella vita che hanno pur avuto. Ebbene, per avvicinare il concetto animale della morte, bisogna sbarazzarsi di questo grande vuoto inodore e deterso.
Per gli animali i morti sono “corpi rotti” e “irreparabili”. Per rendersene conto, andando oltre le reazioni stereotipiche, come quelle delle formiche che trasferiscono il corpo dei morti richiamati dall’odore dell’acido oleico che questi emanano, non è necessaria una particolare complessità cognitiva. Guidati dalla cognizione, dall’esperienza e dall’emozione – la Santissima Trinità, scherza Monsó – , gli animali che possiedono l’idea di un corpo che smette di funzionare e della irreversibilità della sua condizione (niente potrà ridare a quel corpo la condizione in cui si trovava in precedenza) sono quelli in grado di avere un concetto minimo della morte.
Non è un’impresa improba raggiungerlo. Per poterlo elaborare l’animale deve aver capito cosa significhi essere vivo. E ci sono buone ragioni per credere che molte specie ne abbiano un’idea e che questa abbia a che fare innanzitutto con la capacità di percepire il movimento. Ciò che è vivo si muove e per l’osservatore può rappresentare un rischio (un predatore) o un’opportunità (una preda), da cui scaturisce la doppia opzione di imitare l’inanimato (come l’insetto stecco) e di mimetizzarsi per evitare i pericoli. Il corpo morto è dunque quello che ha perso e non potrà più ritrovare la possibilità di muoversi.
Da questa consapevolezza derivano alcune delle reazioni degli animali di fronte ai morti: l’aggressione ai corpi, registrata anche tra i cani a danno del loro padrone deceduto, la necrofilia (frequente tra i cetacei che cercano l’accoppiamento con i cadaveri), le ispezioni olfattive. L’animale raccoglie informazioni sulle mancate risposte, si accerta dei motivi per cui è cessato il movimento. Ora, se questo è il presupposto dell’idea di non funzionalità, quella di irreversibilità chiama in causa un’ulteriore competenza cognitiva alla portata del cervello di numerosi animali non umani, la possibilità di spostare la mente nel tempo.
È dimostrato che alcuni animali sono in grado di farlo, come per esempio rivelano gli studi sulle ghiandaie californiane, note per la straordinaria capacità di ricordare i luoghi in cui viene nascosto il cibo. Ma, d’altra parte, non è probabilmente necessario avere la capacità di saper fare ragionamenti complessi sul futuro per acquisire l’idea di irreversibilità. Collocare l’animale tra i morti in fondo significa soltanto spostarlo da una categoria all’altra, dalla classe degli individui che manifestano le funzioni tipiche della specie “alla classe degli individui dai quali non ci si aspetta queste funzioni”.
Alla luce di quanto detto, non è difficile pensare che gli animali in grado di capire la morte siano molti di più di quanti si immagini. Certo si può ipotizzare che per arrivare ad avere una percezione della morte entrino in gioco anche altre nozioni. Alcuni animali, per esempio, potrebbero, almeno in parte, possedere l’idea di causalità e di universalità, che dipendono da due meccanismi di apprendimento molto diffusi in natura: l’associazione, che porta a legare due avvenimenti che si verificano con tempi ravvicinati – e la generalizzazione induttiva, cioè la capacità di fare predizioni andando oltre il singolo caso (quello che è capitato a lui potrebbe capitare anche a me). Più complesso, ma non impossibile, è pensare che alcuni animali possiedano la nozione di mortalità personale. Nella lista di coloro che potrebbero esserne in possesso ci sono certamente i delfini, per i quali si è arrivati a sostenere addirittura la possibilità del suicidio.
Quanto appare evidente è che le occasioni che hanno gli animali non umani – ad esclusione dei pet – per confrontarsi con la morte sono decisamente più numerose rispetto a quelle in cui si imbattono i sapiens. La morte è, in fondo, la normalità per gli animali, che, senza dubbio, vivono un’esistenza molto più drammatica di quella di molti umani. Tra di loro non è facile superare le prime fasi di vita – l’infanticidio è più che frequente – e nemmeno invecchiare, stretti come sono nella morsa della predazione e degli attacchi che i gruppi sferrano contro gli individui isolati. Che alla fine significa una sola cosa: conoscere la morte è la più comune delle esperienze.