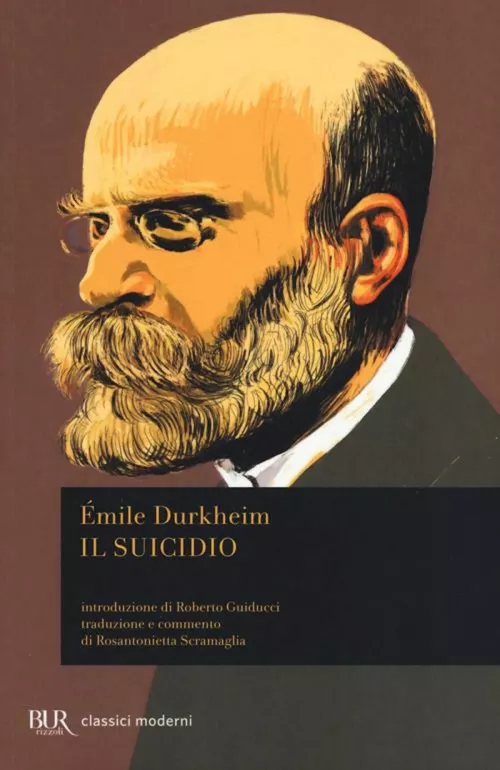15 novembre 1917. Perché leggere ancora Durkheim? / Non finiremo di ammalarci d’infinito
Émile Durkheim, il padre nobile e fondatore della sociologia come scienza e disciplina accademica, meglio noto come l’autore de Il suicidio, moriva cento anni fa, nel novembre 1917, quando, da alcuni mesi, era sbarcata la prima divisione americana in Francia e, da una settimana, i bolscevichi avevano assaltato il Palazzo d’Inverno. Una guerra maledetta, la Grande Guerra, perché gli aveva strappato l’affetto più caro, nel dicembre 1915: il figlio André, promettente studente di filosofia alla Normale di Parigi. E, a causa del dolore, Durkheim, in preda ormai alla depressione, non gli sopravvivrà oltre un paio di anni. Sono molte le grandi correnti culturali nel Novecento nelle quali è facile rinvenire un debito o un’ispirazione nei confronti del suo imponente lascito teorico e concettuale, al di là del solco positivista in cui esso è maturato: la sociologia funzionalista di Merton e Parsons, la linguistica di Saussure, la psicoanalisi di Lacan, l’antropologia culturale di Mauss e di Lévi-Strauss. Perché leggere ancora Durkheim, allora? Per almeno due ragioni.
In primo luogo, ci fa capire la natura fondamentalmente sociale di tante angosce, ansie, apatie o stati di eccitazione, di noi uomini moderni, che spesso vediamo solo sotto la lente psicologica. In secondo luogo, Durkheim coglie, da subito, il tratto principale della società moderna, cioè il suo carattere individualistico, come catalizzatore di tutti i dilemmi e i problemi che “premono” sulle nostre esistenze quotidiane e che oggi sono acuiti nel passaggio alla società liquida, che in fondo è una società ipermoderna. Il suicidio, a cui Durkheim consacra il suo capolavoro nel 1895 e che è anche un “classico” della ricerca sociale empirica, ne è la cartina di tornasole, oltre che il cuneo più drammatico e senza ritorno in cui tali problemi fanno precipitare l’individuo. Ciò che semmai risulta obsoleto in tante sue pagine, va comunque detto, è l’insistenza sul carattere benefico in sé della società, delle sue regole, tolte le quali l’individuo resterebbe in balìa di un coacervo animalesco di istinti e desideri instabili, come se la società fosse un’entità indipendente dagli individui che la compongono e la moralità solo la conseguenza della sua misteriosa forza demiurgica. In fondo, Durkheim paga questo prezzo sull’altare dello sforzo che sta compiendo per dare cittadinanza nella comunità scientifica e accademica alla sociologia, in un momento nel quale i “fatti sociali” appaiono un fenomeno troppo spurio, aleatorio, intersoggettivo, per costituire l’oggetto nuovo di una scienza nuova e, d’altra parte, s’illude di fugare lo spettro del nichilismo sostituendo il Dio morto di Nietzsche con l’“autorità” morale della società, una volta che si sono dissolti gli appoggi religiosi e metafisici che sostenevano la società di ancien régime e ne legittimavano le gerarchie interne: “Tra Dio e la società – scrive – bisogna scegliere. Non esaminerò qui le ragioni che possono militare a favore dell’una o dell’altra soluzione, che sono entrambe coerenti; aggiungo che dal mio punto di vista questa scelta mi lascia abbastanza indifferente, perché nella divinità altro non scorgo che la società trasfigurata e pensata simbolicamente” (Sociologia e filosofia, 1925, postumo).
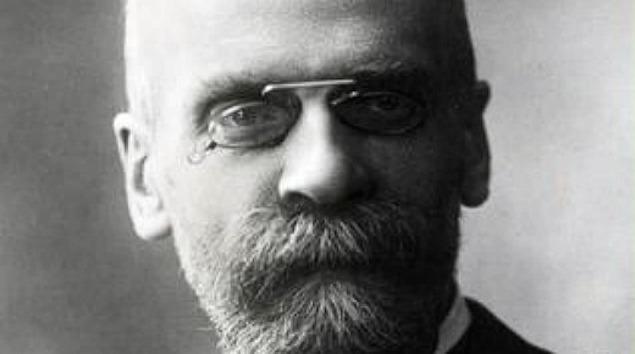
Allora, la cosa migliore da cui conviene partire per non annegare nella produzione sterminata di ricerche, saggi, articoli, recensioni di Durkheim, è un pamphlet del 1898, intitolato L’individualismo e gli intellettuali, con il quale, mentre in Francia infuria l’affaire Dreyfus, l’ormai sociologo e accademico scende in campo e risponde agli attacchi degli antidreyfusardi contro gli “intellettuali”, che, in nome dell’“individualismo”, ovvero dell’uso libero e critico della ragione, si rifiutano di piegarsi alla parola d’onore di un generale dell’esercito, che garantisce sulla colpevolezza di Dreyfus. Durkheim, prendendo nettamente le difese di Zola e degli altri intellectuels, precisa che, come tutte le società, affinché sia coesa, anche la società industriale moderna ha bisogno di una “religione”, cioè di un sistema di credenze e pratiche collettive dotate di autorevolezza e prestigio morale, e l’unica a poter assicurare la coesione di una società moderna è ormai proprio la “religione dell’individualismo”. È un individualismo che non significa arbitrio o anarchia e nemmeno esaltazione dell’homo oeconomicus, egoista, calcolatore, ma che si fonda sulla valorizzazione quasi sacra di quell’umanità rimasta comune ai membri di una società fortemente differenziata dal punto di vista professionale e culturale: “Chiunque attenti – scrive Durkheim – alla vita di un uomo, alla libertà di un uomo, all’onore di un uomo, ci ispira un sentimento d’orrore, del tutto analogo a quello che prova il credente che vede profanare il suo idolo. Una tale morale non è, dunque, semplicemente una disciplina igienica o una saggia economia dell’esistenza: è una religione di cui l’uomo è, contemporaneamente, il fedele e il dio”. È il motivo per il quale, aveva detto alcuni anni prima nel Suicidio, anche l’atto di un suicida, che sembra compiere un torto solo a se stesso e non alla società, in verità genera sgomento e riprovazione collettiva, fino alla possibilità di proibire ex lege il suicidio.

Tuttavia, la morale individualista nasconde una sorta di “cortocircuito” che non tarda a manifestarsi nella vita concreta degli individui: da una parte, gli uomini solidarizzano in nome di un amore comune per l’umanità; dall’altra parte, l’impegno socialmente prescritto alla realizzazione di sé e della propria unicità, l’obbligo sociale ad individualizzare la propria esistenza, li espone al rischio di diventare o individui egoisti e acquisitivi o individui indifferenti e narcisisti, sempre divorati dalle passioni della distinzione. Il «giusto mezzo» sarebbe, per un individuo, una situazione in cui è sufficientemente integrato, ma non troppo, e in cui è sufficientemente costretto e limitato da regole. L’impossibilità che si dia nelle società moderne questo «giusto mezzo» trova riscontro nel malessere che provoca i suicidi e specialmente in due tipologie di suicidio. Prima di tutto, il suicidio egoistico, che risulta da una individualizzazione troppo spinta e, quindi, una scarsa integrazione; poi, il suicidio anomico, che, come si registra nei periodi di cambiamenti rapidi (crisi o prosperità economica), si spiega con l’assenza o la perdita di efficacia di regole o norme. In entrambi i casi, gli individui soffrono dello stesso male, che si chiama il male dell’infinito (espressione che Durkheim mutua da René de Chateaubriand) e che assume due forme: gli uni si perdono nell’«infinito del sogno», gli altri sprofondano nell’«infinito del desiderio». Entrambi soffrono il loro “isolamento” dalla società. Apatia, venata da malinconia o da freddo scetticismo, divora il suicida egoista; delusione, irritazione, disgusto, che si traduce in recriminazioni violente sia contro la vita in generale sia contro persone in particolare, avvolgono, invece, la scena tragica del suicida anomico.
E qui s’incontra uno dei “concetti” forgiati da Durkheim che ha avuto più fortuna nella sociologia del Novecento: anomia. Per Durkheim l’anomia è una medaglia a due facce: il venir meno dell’autorità morale della società, nella capacità di moderare e limitare gli individui nelle loro aspirazioni e di adeguarne le aspettative ai mezzi a disposizione, da una lato; l’insaziabilità dei desideri umani non più adeguatamente contenuti da alcuna regola sociale, con lo stato d’insoddisfazione che ne deriva per l’individuo, dall’altro lato. Ma, la società moderna individualista è per l’individuo, allo stesso tempo, una forza di limitazione e d’illimitazione dei suoi desideri. Con una mossa analitica geniale, Durkheim spiega nel Suicidio che “dove il progresso è e deve essere rapido, le norme che contengono gli individui debbono essere sufficientemente flessibili e malleabili perché se conservassero la rigidità immutabile che hanno nelle società primitive, l’evoluzione, così intralciata, non potrebbe avvenire con la debita prontezza. È allora inevitabile che desideri e ambizioni, meno fortemente trattenuti, scavalchino tumultuosamente gli argini in vari punti. Inculcando agli individui il precetto che il progresso è per loro un dovere, è più difficile farne dei rassegnati e l’accrescersi del numero degli scontenti e degli irrequieti si fa inevitabile. Ogni morale del progresso e del perfezionamento è inseparabile da un certo grado di anomia”.
Al suo tempo, Durkheim è più preoccupato dalla virulenza delle correnti “anomiche” che dall’ambivalenza delle correnti “egoiste”, più dagli avidi che dai sognatori, che tratta con maggiore accondiscendenza. Tra Max Nordau, lo psichiatra autore di Dégénérescence del 1894, che vede nella decadenza artistica di fine secolo della Francia il sintomo di una degenerazione nazionale, che spiegherebbe anche l’aumento della criminalità e dei suicidi, e Baudelaire, che vede nella melanconia e nella nevrastenia una fonte di creatività, Durkheim tende a convergere con il secondo.
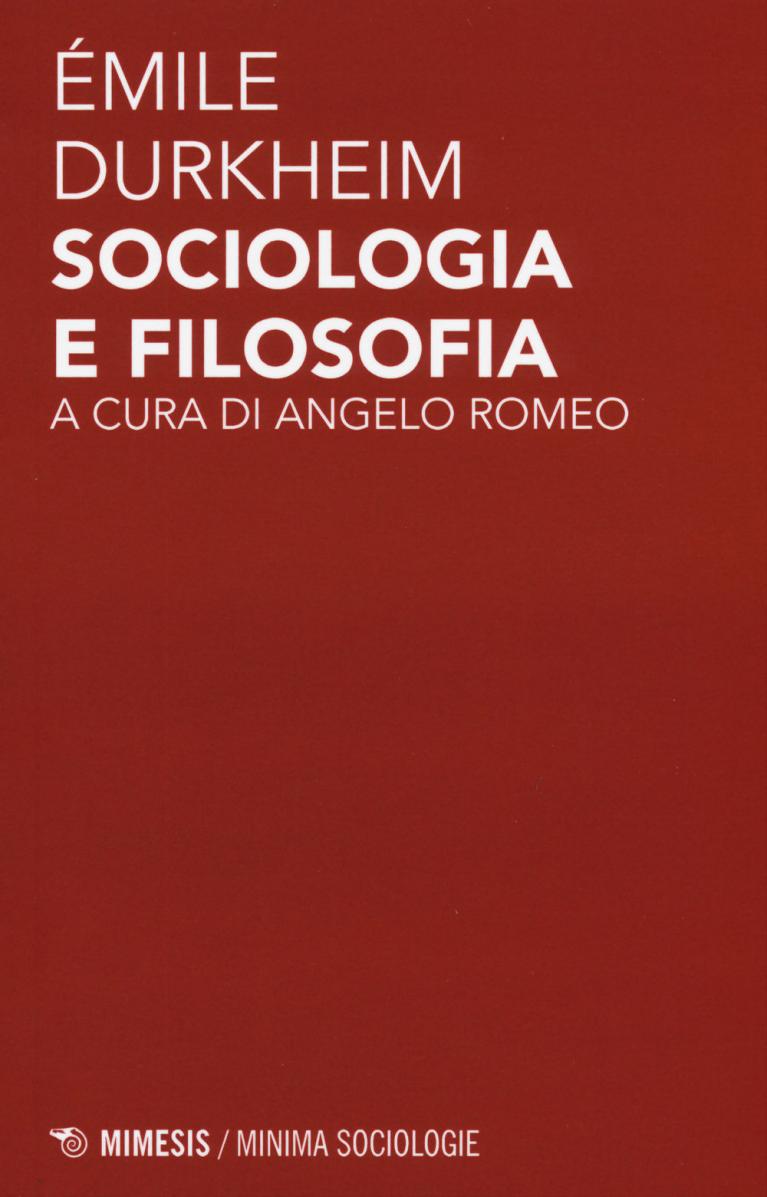
Nelle pagine conclusive del Suicidio, infatti, afferma: “È erroneo credere che la gioia pura sia lo stato normale della sensibilità. L’uomo non potrebbe vivere se fosse completamente refrattario alla tristezza. Tanti dolori vi sono, cui ci si adatta solo amandoli e il piacere che vi si trova ha necessariamente qualcosa di malinconico. La malinconia è patologica soltanto quando prende troppo posto nella vita, ma è pure patologico che essa ne sia completamente esclusa… Ciò che è patologico per gli individui può essere normale per la società. La nevrastenia è una malattia dal punto di vista della fisiologia individuale; ma cosa sarebbe una società senza nevrastenici e malinconici? Essi hanno un ruolo sociale da svolgere.” In una società “mobile” e “civilizzata”, che obbliga ad essere se stessi, “i nervi a fior di pelle”, l’ipersensibilità e la tendenza all’immaginazione solitaria, possono accompagnare il gusto per la novità e la riuscita personale. Certamente, una loro manifestazione intensa può, però, predisporre al suicidio.
Insomma, l’individualismo opera allo stesso tempo come cemento e ruggine della società moderna e da questo non sembra che si possa sfuggire, a meno di non ricadere in società “oliste”, che chiedono la sottomissione dell’individuo, come quelle tradizionali o primitive (pensiamo alle religioni arcaiche che richiedevano sacrifici umani) o quelle moderne autoritarie o totalitarie del secolo scorso (pensiamo alla parabola tragica ed aberrante del nazismo).
Proprio il compianto Zygmunt Bauman ha di recente riassunto splendidamente e attualizzato il punto di vista e le preoccupazioni di Durkheim, scrivendo: “L’individualità, in quanto atto di emancipazione personale e di autoaffermazione, appare gravata da una aporia congenita, da una contraddizione insanabile. Essa ha bisogno della società sia come culla che come punto di arrivo. Chiunque cerchi la propria individualità dimenticando, respingendo o sottovalutando tale sobria/oscura verità si candida a una condizione di frustrazione. L’individualità è un compito che la società degli individui assegna ai suoi membri – un compito individuale, da svolgere individualmente, sulla base delle proprie risorse individuali. E tuttavia questo compito è auto-contraddittorio e votato alla sconfitta: anzi, impossibile da svolgere” (Vita liquida, Laterza 2006). Né l’individuo moderno alle soglie del Novecento, né l’attuale individuo ipermoderno, attratto dalle sirene dell’eccesso di consumi, attività, godimento, sollecitazioni, possono dimenticare che è impossibile vivere senza legami, senza solidarietà, senza società. Senza rapporti con gli altri, la creatività diventa vertigine, il piacere s’inaridisce e diventa distruttività. Probabilmente, Nietzsche-Zarathustra avrebbe catalogato tra i vituperati “ultimi uomini” questo professore francese borghese, repubblicano, laico, di fine Ottocento, che richiamava alla necessità dell’“autorità” morale della società, a un individualismo “morale” e sostenibile, a una felicità equilibrata. Ma viene da chiedersi se il suo “superuomo”, con il suo sentire totalizzante e “aristocratico” che non sopporta sfumature, mediazioni, rinunzie, compromessi, inevitabili nella vita con gli altri, non sia, invece, ancora un’espressione di quel “male dell’infinito” di cui ci parla Durkheim, piuttosto che il rimedio della crisi.