Speciale
Pel di Carota
Nell’ultimo film di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire, in quella che forse è la scena più emblematica e interessante, Giovanni, il regista protagonista della storia, prende possesso del set di un film altrui, paralizzandolo per ore. Lo sta girando un giovane ed entusiasta regista, alle prese con la scena finale. In essa due uomini si fronteggiano. Uno, armato, si appresta a sparare addosso all’altro inginocchiato e disarmato. Indignato, alterato, inquieto, Giovanni interviene a bloccare l’azione, come fosse vera. Spiega che la morte in un film non può sopravvenire in semplice funzione spettacolare, rapida e asettica, suggerendo allo spettatore che la violenza appartiene a un ordine ‘normale’ delle cose. Alla troupe sopraffatta dallo stupore per l’invadenza e l’enfasi oratoria dell’anziano regista, Giovanni porta a esempio Breve film sull'uccidere di Krzysztof Kieślowski, versione estesa del 1988 del quinto episodio del Decalogo, in cui un ragazzo, viene condannato a morte per aver ammazzato un taxista senza motivo. Nel film, dice Giovanni, l’uccisione appare interminabile. Viene eseguita con fatica e in modo particolarmente cruento perché la vittima sembra non voler mai morire, suscitando la rabbia, il terrore, l’incredulità dell’assassino. Lo spettatore, inorridito, non vede l’ora che il taxista muoia così che la scena finisca. In questo modo è costretto ad assistere a una morte violenta per quello che, brutalmente, è: oscena, insopportabile, infame. La scena di Moretti è particolarmente riuscita, perché in essa convivono due registri opposti: da una parte il comportamento di Giovanni è comico, per la pretesa infantile e onnipotente di dare ragione delle cose a se stesso e agli altri, imponendo il proprio punto di vista con sfrontatezza ingenua; dall’altra la questione che il regista porta all’attenzione della troupe e del giovane regista, è serissima, perché è quella, più che mai irrisolta, della rappresentazione della violenza. Giovanni e Kieślowski hanno ragione.

Ho visto il film di Moretti mentre stavo rileggendo quel capolavoro che è Pel di Carota, romanzo di Jules Renard, con illustrazioni di Felix Valloton, che misteriosamente è stato considerato a lungo una lettura per ragazzi. Non che i ragazzi non possano leggerlo, tutt’altro. Ma mi sono ripetutamente chiesta come mai uno dei libri più efferati per crudezza e verità nella narrazione delle dinamiche patologiche familiari potesse essere finito sullo scaffale dei piccoli. È perché il protagonista è un bambino? Perché in queste tetre vicende raccontate senza pathos, con occhio neutro e distaccato, in effetti un ragazzino potrebbe facilmente identificarsi, ritrovando frammenti di crudeltà, di male quotidiano?
In uno dei brevi capitoli che scandiscono il romanzo della tragica infanzia di Pel di Carota, il secondo intitolato Le pernici, si racconta esattamente della fatica di uccidere che si trova nel film di Kieślowski.
Il ragazzo viene assegnato dalla sadica madre all’uccisione di due pernici. Come continuamente accade nella famiglia Lepic, la ragione è presto spiegata: al fratello maggiore tocca segnarne il numero sulla lavagna appesa al muro; alla sorella, spennarle. Pel di Carota deve il privilegio dell’assassinio “alla ben nota durezza del suo arido cuore”.
Il lettore contemporaneo ascolta i dialoghi fra Madame e Monsieur Lepic, e i figli, come uno psicoterapeuta che dietro un vetro segua gli scambi di una famiglia disfunzionale.
Signora Lepic: Che cosa aspetti ad ammazzarle?
Pel di Carota: Mamma, preferirei che mi toccasse segnarle sulla lavagna.
Signora Lepic: La lavagna è troppo alta per te.
Pel di Carota: Allora preferirei spennarle.
Signora Lepic: Non è roba da uomini. Stringile qui, lo sai, al collo, contrappelo.
Con una testa in ogni mano, dietro la schiena, egli incomincia.
Signor Lepic: Non due per volta, animale!
Per di carota: È per fare più presto.
Signora Lepic: Non fare lo svenevole; dentro di te assapori la tua gioia.

I signori Lepic sanno istintivamente come funziona il potere: a chi subisce deve essere chiara la stortura, l’arbitrio va affermato come verità, ordine, regola, ma in modo che la beffa sia vistosa, la messa in scena approssimativa. L’abuso deve essere negato e al tempo stesso conclamato.
Pel di Carota cerca di portare a termine il suo compito. Per non soccombere a un atroce odio di sé, vuole l’approvazione di genitori e fratelli, si industria di essere all’altezza della crudeltà che li domina, della pedagogia nera praticata in famiglia. Ma le due pernici oppongono alla farsa tutte le difficoltà che la realtà oppone. Non si rassegnano a morire: si dibattono con una forsennata resistenza che prolunga le manovre della morte e obbligano il malcapitato a una dose supplementare di efferatezza. Pel di Carota, rabbioso, cerca di tenere fermi due uccelli, vuole finirli per accorciare il proprio tormento. Suda, sbianca, li sbatte, li stritola.
Ernestine e Felix, i fratelli, assistono allo spettacolo mandando grida di giubilo: Oh che boia, che boia!
Il fatto è che lavora di fino. Povere bestie! Non vorrei essere al loro posto fra le sue grinfie, commenta la Madame Lepic, con precisione e godimento, lei sì, di aguzzina, mentre il padre si dà alla fuga, per il disgusto.
In questo breve capitolo si trova lo schema portante, ed esemplare, non solo di tutti i quarantasette episodi successivi, ma di quelle dinamiche familiari che, costrette da un paradigma infernale a una ripetizione infinita, rendono la vita di questo ragazzino un carcere in cui scontare il massimo della pena per il solo fatto di essere nato.
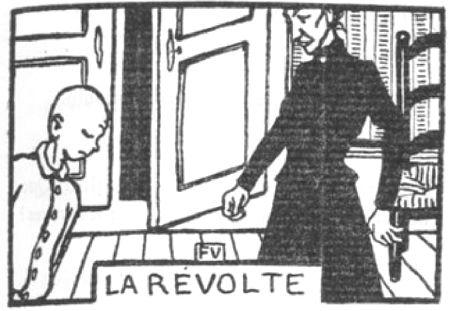
Come Pel di Carota, terzo figlio di una famiglia piccolo borghese e di una madre che lo odiava perché non lo aveva voluto e lo vessò finché lo ebbe in proprio potere, Jules Renard, cercando di spiegare il romanzo che lo rese celebre e che ebbe anche una versione teatrale (nel 1900), affermò: «Presi uno per uno, quest’uomo è un brav’uomo e questa donna è una brava donna, e questi bambini hanno una buona indole. Ma, messi a contatto, non sanno che urtarsi, straziarsi, ferirsi. Sono fragili e non conoscono un modo per toccarsi. Non prendono nessuna delle precauzioni necessarie e maneggiare quell’opera d’arte che è il cuore umano.» Come ricorda Guido Davico Bonino nella Nota biografica dell’edizione Einaudi del romanzo, quando la madre morì annegata in un pozzo, per un incidente, Renard appuntò “con secca, disperata ironia” sul suo Journal: «È un modo piuttosto complicato per rendermi orfano.»
Nel 1894, quando furono pubblicate, queste pagine, che ad alcuni (compreso lo stesso autore, perennemente insoddisfatto di sé), apparvero rozze e mal scritte da quello che fu anche definito un “nemico della famiglia”, descrivevano una brutalità consueta per i tempi e le culture familiari e sociali. Nessuno aveva compreso che, per la capacità di darci conto con esattezza di realtà che ogni giorno tendiamo a dimenticare, costruivano un’opera diversa da tutte le altre. Ovvero un classico.
Leggi anche
Andrea Giardina, Bouvard e Pécuchet
Pino Donghi, Viaggio al termine della notte
Alessandro Banda, Lourdes
Gian Piero Piretto, Il Dottor Živago
Italo Rosato, Il Maestro e Margherita









