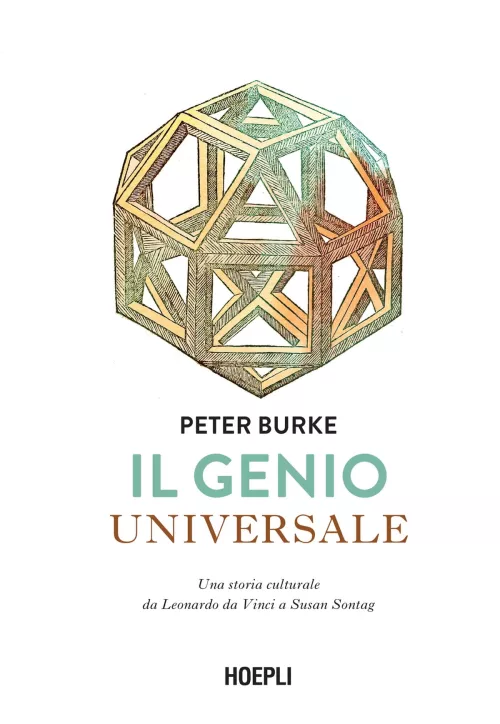Quanti geni!
A metà anni ’90, introducendo alla Statale di Milano la prima delle tre “Lezioni Italiane” di Richard Lewontin – un progetto promosso da Fondazione Sigma-Tau in collaborazione con gli Editori Laterza – Giulio Giorello annunciava che “Dick” avrebbe risposto alle domande del pubblico solo alla fine del terzo giorno: voleva avere modo di esporre l’insieme delle argomentazioni a sostegno del tema che aveva scelto, “Gene, organismo e ambiente”, prima di chiarire eventuali dubbi che l’ascolto di una o due sole lezioni potevano far nascere. Richard Lewontin era professore di biologia e zoologia all’università di Harward, e in quegli anni condivideva con Steve J. Gould (come mi è già capitato di raccontare, anche su queste pagine) un insegnamento sulla teoria dell’evoluzione: a turno, un term a testa, l’uno teneva la lezione e l’altro giocava il ruolo dello studente pierino, quello che fa le domande scomode: si può solo immaginare il privilegio degli studenti che hanno avuto la fortuna di seguire quei corsi. Come promesso, la terza lezione durò poco più di venti minuti, lasciando tutto il tempo possibile per le domande del pubblico in aula magna. Che furono numerosissime. L’ultima riguardava i suoi interessi filosofici, quali autori lo avevano influenzato maggiormente. Rispondendo in inglese (gli studenti potevano, comunque, seguirlo anche in traduzione simultanea), Lewontin illustrò con entusiasmo le posizioni di alcuni giovani filosofi nord-americani; sottolineò, come fosse un riferimento obbligato per chi conosceva la sua biografia intellettuale, la fondamentale influenza che il pensiero di Friedrich Engels aveva avuto in tutta la sua opera e nella sua vita; quindi aggiunse che certo, ovviamente, non poteva negare di aver ceduto al fascino della speculazione di Sir Karl Popper. Quindi si fermò un attimo, come volesse meglio argomentare, e poi, questa volta in un italiano riconoscibilmente accentato, ma con perfetta dizione, scandì: “Fu in sul mio primo giovanil errore, quand’era in parte altr’uom da quel ch’io sono!”. Un attimo di stupore, e poi un applauso scrosciante e lunghissimo confermò che la lezione era finita. Cos’altro aggiungere? Quasi a scusarsi, come preoccupato di essere andato sopra le righe, salutando e ringraziando tutti per l’attenzione dimostrata, aggiunse che amava moltissimo la lingua italiana e che “every now and then”, per tenerla in esercizio, leggeva Petrarca e anche Giacomo Leopardi.
Stephen J. Gould è l’ultimo dei “500 geni universali in Occidente” che corredano, in appendice, Il genio universale. Una storia culturale da Leonardo da Vinci a Susan Sontag, scritto da Peter Burke, professore emerito di storia culturale all’università di Cambridge, pubblicato in originale nel 2020 con il titolo, The Polymath, e di recente tradotto in Italia da Emanuela Braida per l’Editore Hoepli. L’elenco finale, come necessariamente sottolinea Burke, “non intende costituire un canone: sono certo infatti, di aver dimenticato qualche esponente importante”: se potessimo convincere Burke, per una prossima edizione, a rinunciare alla cifra tonda, come 501esimo voteremmo convinti per Richard (Dick) Lewontin.
Dalle stelle dell’accademia a quelle del calcio: a parafrasare la convinzione degli storici francesi Lucien Febvre e Fernand Braudel secondo i quali, come Burke ricorda nella prefazione, si scrive meglio di storia se si oltrepassano, “almeno di tanto in tanto”, i confini della disciplina, potremmo chiamare quel José Mourinho, ritratto in maniera formidabile da Sandro Modeo nel suo L’alieno Mourinho (Isbn, 2010), quando afferma, nel prevedibile sconcerto di molti commentatori da bar sport, che “chi sa solo di calcio non sa niente di calcio”.
In questo testo, Burke racconta del genio universale, e di molti “geni”. Con un limite nell’idea narrativa, la mancanza di un’invenzione letteraria capace di legare le storie individuali. In altre parole, il libro di Burke soffre di un eccesso didascalico-compilativo, come fosse un’appendice all’appendice della lista nuda e cruda, da lui stesso compilata, dei 500 uomini e donne universali attivi in Occidente a partire dal XV secolo. Un elenco dove, alla voce John Stuart Mill, si può leggere che “le sue pubblicazioni includono testi di logica e studi sul governo rappresentativo nonché (insieme alla moglie Harriet Taylor) su temi quali la libertà individuale [corsivo mio, ndr], l’economia politica e la condizione subordinata delle donne”: per l’autore di On liberty, l’understatement definitivo! E anche scrivere che in Il nome della rosa, “la vicenda si svolge nel Medioevo e la soluzione del mistero dipende dalla corretta lettura di un insieme di segni”, beh… riduttivo?
Ciò detto, per onestà della recensione, non per questo ci priveremmo in libreria di un volume buono e utile, specialmente on demand! E nel quale l’autore prova a “individuare alcune tendenze intellettuali e sociali che consentano di rispondere a domande generali sulle forme di organizzazione sociale e sui climi culturali che giocano a favore o a sfavore dell’affermarsi della poliedricità”. Che infatti, periodicamente, è stata anche condannata.
Pur anticipando, già nel sottotitolo, che la storia si dipana tra Leonardo da Vinci e Susan Sontag, che tratta soprattutto dell’Europa e delle americhe, tra il XV e il XXI secolo, non manca un primo capitolo sugli studiosi dall’antica Grecia alla fine del Medioevo, con l’aggiunta di alcune figure del mondo cinese e islamico. Il fuoco, comunque, si concentra su quelle che Burke individua come le due fasi di crisi della conoscenza, nella prima metà del XVII secolo e nella seconda del XIX, entrambe contrassegnate da una proliferazione di libri, per alcuni versi simile a quella in atto, a seguito della rivoluzione digitale. Questa “esplosione” della conoscenza, argomenta l’autore, ha portato e sta portando tanto ad una rapida espansione della conoscenza che a una sua conseguente frammentazione.
Ma tornando allo sviluppo cronologico. “L’uomo del Rinascimento” è sicuramente Leonardo, sicché Jakob Burckhardt, già nel 1860 nel suo La civiltà del Rinascimento in Italia, ne individuava almeno altri tre: Petrarca, Leon Battista Alberti e Giovanni Pico della Mirandola. L’ideale dell’universalità, del saper discutere di filosofia naturale, di etica, astronomia, geometria, armonia, aritmetica e misurazione, si ritroverà nel profilo faustiano, in quel “desiderio insaziabile di conoscenza” che contraddistingueva figure come l’Alberti o Leonardo, appunto, e che sono emblematici di un’età dell’oro della poliedricità, che precede quella del ferro della specializzazione intellettuale e culturale. Il nodo del testo è in questa dicotomia, universalità-specializzazione, che attraversa i secoli, arriva fino a noi, e esalta o condanna l’una o l’altra attitudine, in periodica alternanza. Un’ulteriore dicotomia, quella tra “volpi” e “ricci”, tra il genere “centrifugo” di donna o uomo universali, e quello dei “centripeti”, la si deve ad un uno di loro, Isaiah Berlin, che in una conferenza dedicata a Tolstoi, distingueva i primi, le “volpi” centrifughe, coloro che sanno “molte cose” e accumulano conoscenze senza preoccuparsi delle connessioni, dai “ricci”, gli universali centripeti che cercano sempre di combinare le diverse parti in un grande sistema, che cercano una spiegazione o teoria del tutto, l’unificazione della conoscenza così come la pensava Pico, che non sanno molte cose ma “una cosa grande”. Per inciso, Berlin considerava Tolstoi una volpe che credeva di dover essere un riccio. Tratto comune, la curiosità. Ma, vedremo, non l’unico. “La creatività degli esponenti del periodo che oggi è noto come Rinascimento è stata talvolta spiegata in termini di “decompartimentazione” […] che portò a colmare il divario che aveva separato lo studioso e il pensatore dal praticante”. A quel tempo, in sostanza, un artista o un ingegnere era una specie di uomo universale: Brunelleschi, per esempio. Il XVII secolo invece, secondo Burke, è l’età dei mostri di erudizione. : “ i cento anni compresi tra il 1570 e il 1969 diedero i natali a ben 92 tra gli uomini [e donne] universali elencati in appendice, il doppio dei 39 nati tra il 1470 e il 1569”. Il che meraviglia poco: è il periodo della nascita della scienza moderna, tra Copernico e Newton (nell’elenco dei 500, stilato da Burke, rispettivamente al 16° e 127° posto, in ordine cronologico). Tra le donne è citata Cristina, regina di Svezia; è il periodo in cui vengono inventate le parole per l’attitudine: il “polimath” di cui al titolo originale del libro, descritto come chi “vaga liberamente e a velocità sfrenata per tutti i campi delle discipline”; in Italia, il “virtuoso”, parola che si è diffusa in prestito anche all’inglese; in latino, un intero gruppo di termini, tra cui scientia universalis, pansophia, e polymathia. “Il più famoso esempio di uomo universale del XVII secolo è di certo Gottfried Wilhelm Leibniz”, di solito annoverato tra i filosofi, ma matematico, teologo, linguista (dimostrando le analogie grammaticali tra ungherese e finlandese), e poi giurista, storico, autore di scritti politici, esperto di cose cinesi “… tanto da descrivere se stesso come un ‘ufficio informazioni’ ambulante sull’argomento”. Ma se il ‘600 rappresenta l’apogeo degli studiosi generalisti, “gli anni intorno al 1650 sono rivelatori di quella che viene definita una ‘crisi della coscienza’ o ‘crisi della mente europea’, all’interno di una ‘crisi generale del XVII secolo’, come è stata denominata dagli storici”. Molte le ragioni ma, per il nostro tema, rilevante un aspetto legato all’accresciuta quantità di conoscenza disponibile, “che apportava benefici collettivi ma costituiva anche un motivo di ansia individuale di fronte al troppo sapere […] Si moltiplicavano le lamentele sull’eccessivo numero di libri, nonché le metafore che lo paragonavano a un ‘diluvio’ in cui i lettori temevano di annegare, o a una ‘foresta’ nella quale si sentivano perduti”. Robert Burton, riguardo il gran Caos e confusione di Libri, ebbe a commentare: “Ne siamo oppressi, ci fanno male gli occhi a forza di leggere, le dita a forza di voltare le pagine”. Qualcosa suona familiare? Does it ring any bell? Come si dice in inglese! Per le generazioni successive, si pensò, sarebbe diventato più difficile essere all’altezza dell’ideale di conoscenza universale. Che infatti, per molti, tutto sembrò meno che un ideale, e anzi stigmatizzata come “la sindrome di Leonardo”, a dire di chiunque si atteggiasse a “riccio”, portato a vedere connessioni tra i diversi tipi di conoscenza, ma rivelandosi al più una “volpe”, che non faceva altro che disperdere le proprie energie.
Il testo di Burke si sviluppa di conseguenza, sempre in progressione cronologica, illustrando e argomentando le diverse epoche, da lui definite come “L’età dell’uomo di lettere”, tra il 1700 e il 1850 – e dove, di nuovo, si assiste a un’esplosione e a un sovraccarico di conoscenza, tale da far scrivere a Thomas De Quincey della propria ansia, espressa in “visione di una processione di carri e carretti che non finivano mai di scaricare pile di libri fuori dalla porta di casa” – e “L’età della territorialità” che arriverebbe ai giorni nostri. Specialismo, suddivisione delle istituzioni, nascita dei musei, delle società intellettuali, dei congressi, delle riviste, del “lavoro di squadra”, sono tutti portati dell’età ultima epoca, quella della territorialità. Come sopravvivere, posto che fosse/sia necessario, per l’uomo universale? Magari con una capacità un’attitudine naturale, che caratterizza, secondo Burke, ancora oggi alcuni di loro, quella di “dare contributi originali a discipline per loro secondarie, affrontandole con la forma mentis acquisita nello studio del loro interesse primario”. Questione di metodo, potremmo tradurre. Il “Ritratto di gruppo”, ovvero l’elenco delle caratteristiche sine qua non, comprende: curiosità, concentrazione, memoria, velocità, immaginazione, energia, irrequietezza, lavoro, capacità di amministrare il tempo, competitività e, non ultimo, “il fattore gioco”, la capacità e predisposizione verso una dimensione ludica del sapere e del vivere: tra gli ultimi “giocherelloni”, Alan Turing che amava un gran numero di giochi, insieme a tutti gli eroi della computer science e dell’informatica, e anche il nostro Umberto Eco. C’entra anche l’habitat, a cui è dedicato il settimo capitolo, e dove si affronta anche la rilevanza, più volte sottolineata, dalla “geografia religiosa”, l’importanza, per dire di quella più ovvia, dell’etica protestante, dell’etica del lavoro.
Per concludere, Burke argomenta le ragioni per cui viviamo in un’epoca di coesistenza tra discipline e interdisciplinarietà “o, più esattamente, di convivenza tra le due forme, con l’accento sulla loro interazione piuttosto che sulla semplice esistenza”. E, certo, stiamo vivendo una “terza crisi” la cui data d’inizio corrisponde al 1990 del world wide web: croce e delizia! Croce, specialmente, per i più anziani, che vivono – di nuovo! – nell’ansia da informazione, nella “marea, diluvio, tsunami di informazioni”. Ma, appunto, non è la prima volta, e il libro di Burke ci aiuta a ricordarlo. Così come non siamo i primi a denunciare i rischi che le nuove tecnologie ci instupidiscano, consegnandoci ad un futuro cupo, deprivati di ogni capacità di approfondimento, ignari di ciò che significa coltivare lo spirito critico… una geremiade non originalissima.
Uno stralcio dal Fedro, in particolare dal mito di Theut e Thamus: “Infatti la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nell’anima di chi la imparerà perché, fidandosi della scrittura, egli si abituerà a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da sé medesimo. Dunque tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli solo l’apparenza: infatti divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, essi crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre in realtà non le sapranno, e sarà difficile discorrere con loro, perché saranno diventati conoscitori solo di opinioni, invece che sapienti”.
Leggendo (anche) il libro di Burke, viene da pensare come alcuni problemi cambino di rappresentazione, e certo, di conseguenza, anche nella sostanza… pure un po’ continuando a somigliarsi. Se con una nuova accezione di “uomo universale” si potesse intendere chi, volgendo lo sguardo all’orizzonte, sappia riconoscere anche qualche forma del passato, beh!... “avremmo bisogno di persone così”.