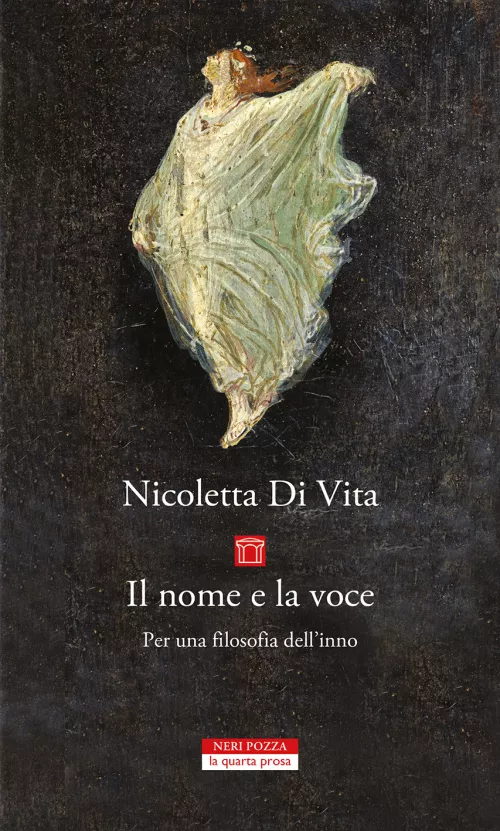Una filosofia dell'inno
Con un’immagine stupenda, tipica del suo stile di intensa metaforicità, nelle Confessioni (XIII 9, 10) Agostino definiva locus […] qui non est locus il Nonluogo dello spirito, il Nondove che solo è davvero «nostro», dove infine trova pace l’inquietudine del continuo ricercare nella regio dissimilitudinis in cui siamo perduti (requies nostra locus noster). Con lo stesso emblema spaziale uno dei più sottili agostiniani laici della contemporaneità, Andrea Zanzotto, dichiarandolo «avverbio» ha chiamato Gnessulògo quel Nonluogo ove dimora la poesia («…e la poesia no l’è in gnessuna lengua / in gnessun logo – fursi»; «Ed è così che ti senti nessunluogo, gnessulógo (avverbio) / […] gnessulógo / mai a gnessulògo è equivalente», Il galateo in bosco, 1978). Il Nonluogo è anche un Nonlógos «veniente di là dove non è scrittura […] né “grammatica”: luogo, allora, di un logos che resta per sempre “erchómenos”, che mai si raggela in un taglio di evento, che rimane quasi “infante” pur nel suo dirsi, che è lontano da ogni trono» (Filò, 1976).
Ciò che Antonio Prete ha battezzato pensiero poetante non prende forma di parola in un “dove” e in un “quando”. Rimane sempre «veniente», erchómenos. È «la parola che non c’è, o non c’è ancora»: questa definizione perfetta viene applicata all’inno, e anche al pensiero, in un libro fra i più originali che la filosofia, la linguistica, l’antropologia, la storia delle idee e della letteratura ci abbiano offerto negli ultimi tempi, l’opera prima della giovanissima Nicoletta Di Vita, apparsa nella collana La quarta prosa di Neri Pozza diretta da Giorgio Agamben. Nella lettura appassionata e aguzza di Il nome e la voce, dove lo stile di pensiero si traduce performativamente in stile di espressione, affilata lama d’acciaio, l’inno è figura della filosofia e della poesia: «apertura prima al dire», «luogo in cui il linguaggio sembra guardare verso se stesso», «luogo dell’emergere della voce». Il flatus vocis si dischiude in cerca della Parola, le dà energia e slancio, come il soffio dell’enthousiasmós divino gonfiandole le vesti solleva la leggerissima Danzatrice di Pompei, in copertina. È la parola «quasi “infante”» di Zanzotto, alito della misteriosa pantera dei bestiari antichi di cui andava a caccia Dante nel De vulgari eloquentia (I 16, 1), redolentem ubique et necubi apparentem: ovunque ne cogliamo il profumo, e in gnessulògo essa appare, si manifesta.
Leggendo questo libro bellissimo e molteplice intitolato all’inno, ma più in largo dedicato alle radici del pensiero e della parola poetica, si comprende meglio perché la poesia volgare, sbocciata con il chantar dei trovatori traboccante di fin’amors, è anzitutto esperienza della parola che scaturisce e canta nella lingua «quasi “infante”», dando voce e senso al mondo: «L’uomo è il solo che possa non soltanto rendersi conto ma anche sempre rendere conto delle cose. Di queste non è soltanto messaggero, ma portavoce. […] Il cosmo può esprimere la propria divinità perché l’uomo articola il suo linguaggio». La parola che coglie il pensiero nel nascere e nel primissimo cercare espressione linguistica è un Inno alla Gioia, al Joy d’Amor. Come ricorda finemente Nicoletta Di Vita, il De vulgari eloquentia (I 4, 3-5) proclama altresì, e con forza: «la prima parola che ha fatto risuonare la voce di Adamo, il primo parlante, poté essere solo il nome di Dio, El». «È assurdo e orribile», esclama Dante, «pensare che qualcosa sia stato nominato dall’uomo prima di Dio». La locutio prima dell’uomo, inno sgorgato dalla Gioia (a gaudio) per l’essere entrato nella creazione, è dunque il nome di Dio: «il mito dell’origine divina del linguaggio, ovvero dell’origine divina dei primi nomi», attraversa la civiltà occidentale. Quella parola prima fu ed è espressa nel “caso” vocativo, di cui Giorgio Agamben ha individuato «la centralità per una teoria della voce»: un “caso” che esige indipendenza, «spazio separato e autosufficiente», giacché si dà come semplice nome, «come il mero darsi di quel nome, al di là di ogni relazione con i costituenti dell’enunciato proferito».
Puro nome, mera nominazione di Dio, ossia della cosa non nominabile che per miracolo “prende luogo” nella parola: il divino, e anche il mondo, varcano così la soglia della innominabilità, si fanno dicibili, si trasformano in linguaggio che articola la realtà, le dà nome. Ed è l’atto essenziale del nominare, la nominazione senza nome, che «lascia venire la cosa alla parola». In questi termini Nicoletta Di Vita offre una tra le più alte definizioni del pensiero poetante che io conosca: appunto, lasciare che la cosa “venga” alla parola. Trovo sintomatico che filosofi e poeti additino con identico gesto l’atto creativo della pura nominazione: una poetessa anche lei alla sua opera prima, Simona Mancini, vincitrice in questi giorni del premio di Poesia Alma Mater – Violani Landi, in Di nuda madre (peQuod, Ancona 2023) scandisce come una punta di diamante la medesima idea, con parole quasi identiche: «Poesia è battesimo: nominare come se / fosse la prima volta» (ne ho scritto su Insula europea il 18 maggio 2023).
L’ineffabile trova espressione in quella che Agamben ha nominato potenza-di-non, nell’inciampare fragile e tenero del linguaggio quale evento in cui si articola la voce. In poesia come nella mistica, e in amore, la lingua dell’estasi raggiunge, negandosi, la vetta estatica del linguaggio. La poesia e la voce mistica chiamano barbagliare questa esperienza contraddittoria della voce, aperta ma incapace di accogliere interamente nel cuore il soffio «esmesurato». Esso diviene stridìo animale, grido erotico e al contempo interminato silenzio interiore: «drent’à lo cor firito, / non se sente de fore». Ed è, ancora e sempre, inno, giubilo, gioia. Così nella fulminea lauda-ballata di settenari di Jacopone: «O iubelo de core, / che fai cantar d’amore! // Quanno iubel se scalda, / sì fa l’omo cantare; / e la lengua barbaglia, / non sa que se parlare; / drento no ’l pò celare / (tant’è granne) el dolzore. // Quanno iubel c’è aceso, / sì fa l’omo clamare; / lo cor d’amore è apreso, / che no ’l pò comportare; / stridenno el fa gridare / e non virgogna allore».
Nominare Dio barbagliando e inneggiando significa pronunciare la parola “per la prima volta”, come Adamo in Paradiso. Questo è il nucleo originario della parola poetica, che realizza «l’irrompere del nome nel caos dell’innominato» (la mirabile formula è di Hans Blumenberg, ricordato dalla Di Vita). È qualcosa di vicino a ciò che Roberto Bazlen, per tradurre Erstmaligkeit, chiamava la primavoltità, così come Walter Benjamin parlava di Einmaligkeit, unavoltità. In prospettiva storicistica Angelo Brelich, nell’Introduzione alla Storia delle religioni (1966), riconobbe che il mito «fonda» la realtà, dandole senso e impedendo che il mondo travolga il soggetto nella sua sperimentazione delle cose: «I miti fondano le cose che non solo sono come sono, ma devono esser come sono, perché così sono diventate in quel lontano tempo in cui tutto si è deciso. […] Il mito, dunque, non spiega, per un bisogno intellettuale, le cose […], ma le fonda, conferendo loro valore».
Su posizioni diverse dallo storicismo, ma che si sono nutrite anche del pensiero di Ernesto de Martino, Nicoletta Di Vita definisce il mito «in senso proprio quel fenomeno che strappa un grado di “dicibilità” a un altrimenti “indicibile”»: nell’atto di nominare la cosa il residuale, ciò che rimarrebbe non pronunciato e impronunciabile, estraneo, minaccioso, entra nel linguaggio, si articola e così viene ri-fondato nel proferimento mitico. In questo senso «l’inno è la figura poetica del momento in cui il linguaggio si confronta con il mondo. È il mito di ogni filosofia (di ogni atto di linguaggio) di coincidere con la cosa che dice. […] In questione è qui non il nome qui e ora, ma la nominazione stessa, cioè il fatto di nominare […]. Non conta come dico il mondo, conta che lo si possa dire». Nominandolo, il linguaggio fonda miticamente il mondo, lo chiama e lo assume in sé: e la poesia, forma sublime del linguaggio, fiorisce quale tenera, protettiva quanto pericolosa invocazione e nominazione di un senso, nell’abbraccio della parola.
Ferdinand de Saussure ha riflettuto profondamente sullo «statuto del nome», muovendo dal riconoscimento di innumerevoli anagrammi nella ragnatela dei versi poetici (nel 1971 Jean Starobinski ricostruì magistralmente quel lavoro con Les mots sous les mots, tradotto da Giorgio R. Cardona nel 1982, che ora sta per essere ripubblicato da Quodlibet a cura di Lucia Amara). Negli stessi anni di Saussure, rammenta Nicoletta Di Vita, lo storico delle religioni Hermann Usener, con I nomi degli dèi (Götternamen, 1896) studiava «il “processo storico-linguistico” che rese possibile, in ambito indoeuropeo, “la nascita delle divinità personali”», concludendo che «il verbo divino “giace nascosto” nelle cose: esso è “lingua innominale” che attende di essere nominata». E Walter Benjamin, nel saggio sulla lingua del 1916, dirà che «la lingua di un essere è il modo in cui si comunica il suo essere spirituale», cogliendo (commenta splendidamente l’autrice) «il nome della cosa, cioè non il nome che dà il soggetto ma il nome che, dal fondo della cosa, attende di essere pronunciato». Un fitto, coevo intreccio di riflessioni convergenti da parte della filosofia, della linguistica, della storia delle religioni, perimetra il problema della nominazione del dio e dell’evento del nome, di cui Saussure colse l’indefinibilità radicale.
L’inchiesta di Nicoletta Di Vita muove da Socrate e Platone, dagli Stoici, soprattutto Cleante e Epitteto: ma presto attraverso le fonti antiche germoglia una vasta meditazione sull’inno in quanto «rimosso, qualcosa che è stato necessario superare», la parola che “deve venire”, «di cui il filosofo si mette con “coraggio” e necessità alla ricerca», giacché «il nesso tra l’inno e il pensiero si presenta a noi come un interrogativo, qualcosa di irrisolto, di mancato o di dimenticato». Inneggiare, pensare, filosofare, poetare saranno ancora per Hölderlin espressioni di un medesimo gesto mentale. La coincidenza fra inno e parola poetica è esplicita: «“Inno” è il nome che gli antichi danno al generico, di per sé inafferrabile, darsi del linguaggio poetico; e, a un tempo, esso è il nome di una precisa configurazione che quel linguaggio assume, fino a farsi convenzionale. L’inno contiene cioè in sé una doppiezza che pare essenziale in senso più esteso che non il solo genere innodico: l’ambivalenza tra un nucleo sempre imprendibile e incristallizzabile della parola e la sua necessaria cristallizzazione. Esso è come la soglia, il momento in cui il sostrato comune della parola pronunciata è bloccato, prende forma, si mostra in un eidos visibile».
Roberta De Monticelli, presentando nel 1990 la sua straordinaria versione delle Confessioni di Agostino, per quel libro fondativo dell’Occidente parlava di una «felicità della mente», nutrita solo da «ciò che la rallegra» (Conf., XIII 27, 42), e di «una metafisica al vocativo»: vocativo è l’intero dialogo interiore con un Tu non esplicitato, e tuttavia sempre nominato, invocato. Di una festosa nominazione senza nome dell’inno, ove «il nome del dio è in verità assente, e tutto ciò che appare è la sua nominazione», parla Nicoletta Di Vita. E riandando al pensiero di un maestro della linguistica moderna, Émile Benveniste, torna oggi sul «caso vocativo», nel quale i nomi «compaiono, in certo modo, come semplici nomi, come il mero darsi di quel nome, al di là di ogni relazione con i costituenti dell’enunciato proferito. […] Non riuscendo mai a coincidere interamente con un caso, il vocativo sembra agire sul piano dell’atto proferito precisamente nella misura in cui si fa portatore di quello stesso proferimento». In questo modo si cristallizzano in un’immagine dialettica il “dove” e il “quando” dell’inno, del sorgere del pensiero nella nominazione senza nome: «l’inno non è semplicemente il luogo della pronuncia del nome divino, ma quello di un sostare, senza apparentemente alcuna estrinseca finalità, nel luogo esteso e come indefinito della stessa nominazione».
Il filosofo, al pari del poeta, «chiama le cose alla nominazione», invocandole. La filosofia dell’inno, nella lettura di Nicoletta Di Vita, dà vita a un’elegante, profonda meditazione sul pensiero poetante come espressione più intima della relazione fra le parole e le cose, dunque anche fra l’Io e l’Altro. Mi sembra significativo che il tema su cui Nicoletta Di Vita sta scrivendo dopo l’uscita di Il nome e la voce sia il lamento. Giorgio Agamben sintetizza a meraviglia nel risvolto di copertina: «l’inno e il lamento sono le ancora oggi le due vocazioni fondamentali dell’essere parlante». Emmanuel Levinas, Edmond Jabès, ci hanno insegnato che il dialogo, l’incontro, è in primo luogo grido, apertura al Tu, all’Altro, invocazione gaudiosa, ma anche lamento. Adamo in Paradiso invoca Dio; Giobbe a Dio urla il dolore dell’universo; Paul Celan risillaba per il lettore la parola sottratta al vuoto, «cavata al silenzio» quando il terribile è avvenuto. Così sempre il filosofo e il poeta si addossano il mondo intero, tutta la lingua invocata a dirlo. Tornando alle geniali, classiche ricerche di Benveniste sui pronomi, Nicoletta Di Vita illumina la funzione centrale, parallela al “caso” vocativo, svolta dal tu: «Parlare alla seconda persona, […] come accade nel caso vocativo, significa non semplicemente rivolgersi a qualcuno per comunicare o chiedere qualcosa, per chiamarlo o appellarlo in qualche modo, ma, ogni volta, compiere un atto di linguaggio in cui “ciascun parlante assume su di sé l’intero linguaggio”, chiama la cosa non come un oggetto ma, in questo senso speciale, in quanto essa è chiamata nella lingua».
Il primo Tu del poeta è il suo pensiero poetante. Al «solitario campo» della Mente, e al Pensiero dominante che «siccome torre» vi giganteggia, Leopardi dedica uno dei Canti più intensi, tutto al vocativo, dai versi iniziali, di potenza immaginativa cosmogonica («Come solinga è fatta / La mente mia d’allora / Che tu quivi prendesti a far dimora! […] / … Siccome torre / In solitario campo, / Tu stai solo, gigante, in mezzo a lei») fino alla fine, là dove il Pensiero si trasforma nell’Amata-Ánghelos, nell’epifania d’Amore, la trobadorica Fin’Amors: «…Bella qual sogno, / Angelica sembianza, / Nella terrena stanza, / Nell’alte vie dell’universo intero, / Che chiedo io mai, che spero / Altro che gli occhi tuoi veder più vago? / Altro più dolce aver che il tuo pensiero?».
La prima cosa invocata, «chiamata alla nominazione» dal Poeta, è il Pensiero, che svetta con la sua potenza nella derelizione della Mente, già quasi Waste Land ridotta a deserto. Il pensiero dominante, che nella Mente invoca la gloria della lingua e la gioia del canto, è dunque l’Inno al Pensiero. O forse è anche il Lamento del Pensiero, costretto a «sostare nella lingua» chiamando la parola da Gnessulògo, per trasformare in bellezza anche il Vuoto, il Nulla. È un dubbio che Nicoletta Di Vita illuminerà di certo nel suo prossimo libro.
Nicoletta Di Vita, Il nome e la voce. Per una filosofia dell’inno, Neri Pozza, Vicenza 2022, pp. 269, € 22.