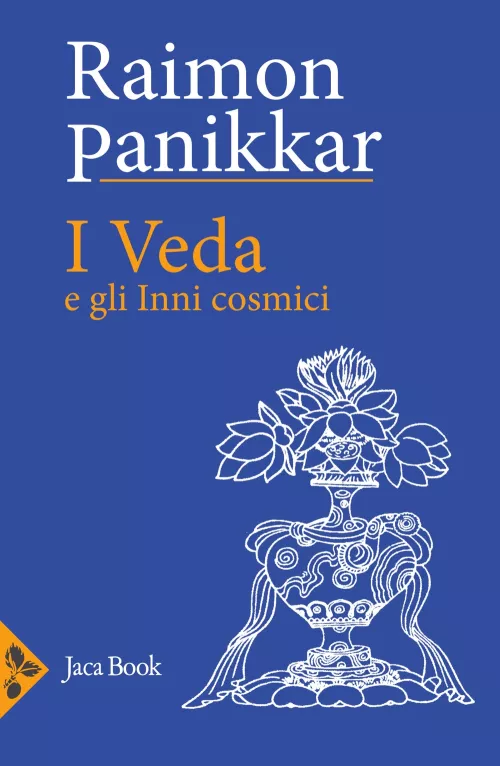Uno sterminato tappeto di inni
L’Universo dei Veda è uno sterminato tappeto di inni, un intreccio vibrante di voci e di echi trasformati in ritmo e misura, dunque anche in spazio e tempo. È un Teatro della Memoria senza confini, in cui si raccoglie tutto ciò che è stato e non è stato, che potrebbe essere e forse sarà, e che la Parola dell’inno fa esistere nella Mente, manas, e nella realtà. L’immensa antologia raccolta, tradotta e commentata da Raimon Panikkar, uno dei sapienti a cui maggiormente dobbiamo in Occidente la conoscenza di quel corpus antichissimo formatosi nell’India settentrionale intorno al 1500 a. C., si stende lungo una temporalità abissale, scandita in un’armonia che riflette individuo e cosmo, luce e suono: da Aurora e Nascita a Germinazione e Crescita, da Fioritura e Pienezza a Tramonto e Declino, da Morte e Dissoluzione a Nuova Vita e Libertà.
Alla fine del percorso, che è anche un’iniziazione rituale, la conquista è «la semplicità assoluta»: «Nei più profondi recessi dell’essere dell’uomo c’è un ardente desiderio, addirittura un bisogno, di semplificare tutta la sua vita, non solo a parole ma anche a fatti». La semplificazione suprema sta nella sillaba sacra, Om, il mantra in cui tutte le parole sono tenute insieme (dicono le Upaniṣad) come le foglie dal gambo di un ramoscello. Raggiungere la concentrazione e la capacità contemplativa significa appunto conquistare la Realtà Ultima, che è la capacità di far risuonare nell’universo intero Om, somma cosmica dei suoni e delle parole.
La Parola, che i Veda chiamano Vāc, è la primogenita dell’Essere, ed è essa stessa Brahman. I più belli degli inni vedici tradotti da Panikkar in queste mille pagine di preghiera e di interiorità sono forse quelli dedicati a Vāc. Inneggiare alla Parola significa coglierne la natura di «principio vivificatore in tutti gli esseri»: natura di «vento», di «respiro della vita». «Essa, che esiste da tutta l’eternità, rivela il Padre e per amore delle creature lo “genera”, altrimenti egli rimarrebbe completamente avulso da loro e non-esistente». Gli inni sapienziali (Ṛgveda) sono invocazione della Parola: parola che “dà nome” alla Parola inneggiando a Lei, offrendo attraverso la voce il sacrificio che separa esistente e non-esistente, pronunciato e indicibile, «generando» il Padre attraverso la sua rivelazione. Tra la sfera degli dèi e la sfera del terrestre l’Uomo regna in una terza sfera intermedia, ove si edifica «un tempio interiore, quello che dobbiamo cercare». Come nel sufismo iranico studiato da Henry Corbin e nel pensiero ascensionale di Ugo e Riccardo di San Vittore, che nel XII secolo insegnavano a Parigi e che furono carissimi a Dante, già nel mondo vedico «la sfera della preghiera, della meditazione, della contemplazione», è quella in cui «la coscienza non si limita a riflettere ciò che è, ma modifica […] la cosa che riflette. […] Nell’atto di pregare l’Uomo partecipa al dinamismo che è al centro della realtà e penetra nel cuore del mondo. La preghiera è in verità Brahman».
Secondo una bellissima formula di Nicoletta Di Vita, il cui libro (Il nome e la voce. Per una filosofia dell’inno) ho presentato su Doppiozero, «nell’inno è in gioco qualcosa come la “gloria de la lingua” nel senso appuntato da Dante: libera dalla mondana “nominanza” e tuttavia portatrice di massima gloria, quella parola deve tutta la sua luce non all’oggetto che canta, né a ciò che di quell’oggetto dice, ma a qualcosa che ricade nella sua stessa lingua; a nient’altro che alla “gloria” della sua stessa lingua». L’inno è «una apertura prima al dire», «il luogo in cui il linguaggio sembra guardare verso se stesso». Negli inni dei Veda la Parola inneggia a sé: «Io sono la Regina che governa, colei che accumula tesori, / piena di saggezza, la prima di coloro che sono degni di adorazione. […] L’uomo che vede, che respira, che sente parole pronunciate, / ottiene il proprio nutrimento solo attraverso me». Così l’inno si manifesta davvero, come dice la Di Vita, quale «luogo dell’emergere della voce», in cui la Voce canta la propria gloria divina.
Panikkar propone una sintesi perfetta: «Dio non ha nome perché Egli stesso è Parola […] Vāc è proprio la parola totale vivente, vale a dire la Parola nella sua interezza compresi i suoi aspetti materiali, il suo riverbero cosmico, la sua forma visibile, il suo suono, il suo significato, il suo messaggio. […] Vāc è veramente il mistero primordiale che combina in sé i tre mondi del tempo: passato, presente e futuro. Tutto ciò che è partecipa in vāc, attraverso la quale tutto è venuto in essere e che ha lasciato ovunque la sua impronta». La cosmologia vedica, pur conservando la sua originalità radicata nella storia dell’induismo e la sua specificità politeistica, metafisica e antropologica, lascia balenare formidabili parallelismi concettuali con quella monoteistica ebraico-cristiana: «Solo l’Onnipotente è Signore della Parola sacra; solo lo Spirito ha potere sulla parola e conosce tutte le parole. […] Nella Parola, la cui funzione è sia nascondere che rivelare, Dio e uomo si incontrano. È la realtà cosmoteandrica per eccellenza».
Mi sembra magnifica la dimostrazione offerta da Panikkar del legame strettissimo che la Parola conserva con il sacrificio, di cui è il momento centrale per la salvezza dell’uomo: «La funzione di dare un nome a tutto è […] una funzione divina e gli uomini non possono far altro che prendervi parte, espletando quest’attività creativa per conto di Dio. […] Non c’è salvezza senza una chiamata e una risposta». Nella Bibbia Adamo, creato da Dio perché possa conoscere le cose e dare loro il nome, risponde alla chiamata nominando Dio, e poi il mondo. Nell’inno occidentale è il vocativo il “caso” della nominazione dell’Essere: puro nome, mera nominazione di Dio, ossia della cosa non nominabile che per miracolo “prende luogo” nella parola: il divino, e anche il mondo, varcano così la soglia della innominabilità, si fanno dicibili, si trasformano in linguaggio che articola la realtà, le dà nome. Ed è l’atto essenziale del nominare, la nominazione senza nome, che (scrive Nicoletta Di Vita) «lascia venire la cosa alla parola».
Nella cultura vedica, spiega Panikkar, «Dio non è né un nome proprio, né un sostantivo, né una sostanza, né una “cosa”, ma semplicemente il pronome interrogativo stesso. Mai un pronome è stato usato così propriamente in luogo di un nome inesprimibile e non-esistente. Il suo nome è semplicemente ka (chi?) o, per essere ancor più esatti, kasmai (a chi?)». Non dunque Chi?, ma A chi? è il vero nome di Prajāpati, il padre di tutti gli esseri. «Dio è una domanda al dativo, un a chi? verso il quale sono diretti tute le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri desideri; Dio è il termine problematico e interrogativo di tutto il nostro dinamismo. Se la forma appropriata del nome greco per Dio è il vocativo, il nome vedico è un dativo; non è solo il termine dell’invocazione, è anche colui che riceve il sacrificio. L’aspetto contemplativo prevale, comunque, e il nome sarà il nominativo puro: ka e da ultimo aham». Con rigore e intelligenza emozionanti Panikkar sfiora qui non solo un punto centrale nella teologia vedica, in cui sacrificio, parola e nominazione costituiscono un solo evento, ma coglie anche un nodo problematico della linguistica indiana, che riemerge in quella del Novecento occidentale, soprattutto con Émile Benveniste e le sue riflessioni sui pronomi e sul “caso” vocativo: «Non riuscendo mai a coincidere interamente con un caso, il vocativo sembra agire sul piano dell’atto proferito precisamente nella misura in cui si fa portatore di quello stesso proferimento» (N. Di Vita).

Ho nella memoria una pagina splendida, nella quale Roberto Calasso (Ka, Adelphi 1996) narra la scena in cui il Progenitore, Prajāpati, «emette» Vāc, la Parola, e così crea il reale, la discontinuità. «Prajāpati era solo. Non sapeva neppure se esisteva o non esisteva. […] Fra il petto e la testa c’era in lui un ardore, come di un’acqua che ferve in silenzio. Continuamente trasformava qualcosa: era il tapas. Ma che cosa trasformava? La mente. La mente era ciò che trasformava e ciò che si trasformava […] La mente: un flusso senza argini, attraversato da vampe che si perdono. Occorreva tracciare un cerchio, una cornice, un templum. “Assestare” si diceva Prajāpati. Ma tutto oscillava. […] Nella solitudine Prajāpati, il Progenitore, pensò: “Come riprodurmi?” Si concentrò in se stesso e un calore si irradiò da lui. […] Prajāpati sentiva di avere un compagno, un essere “secondo”, dvitīya, dentro di sé. Era una donna, Vāc, Parola. La emise. La guardò. Vāc ascese come un flusso continuo di acque. Era una colonna liquida, senza inizio e senza fine. Prajāpati si congiunse con lei. La spezzò in tre parti. Tre suoni gli uscirono dalla gola, nello slancio amoroso: a, ka, ho. A fu la terra, ka lo spazio intermedio, ho il cielo. Con quelle tre sillabe il discontinuo irrompeva nell’esistenza».
Mi sembra che, al di là delle affinità a cui ho fatto cenno, in questa metafisica della Voce creatrice come atto sacrificale si tocchi con mano anche la distanza incolmabile fra la civiltà vedica e quella ebraico-cristiana. Nei Veda, come spiega Panikkar, la nominazione del divino (A chi?) «non è semplicemente una domanda teoretica; è l’oggetto della nostra adorazione, il termine del nostro culto, lo scopo del sacrificio. Dio non può essere “conosciuto” se per conoscenza intendiamo una consapevolezza meramente mentale; può essere raggiunto solo tramite il sacrificio, l’azione sacra, l’ortoprassi, il fine ultimo di tutte le religioni. Il sacrificio, inoltre, ha bisogno di conoscere solo l’interrogativo di Dio. […] Il sacrificio non è una manipolazione del divino, ma il balzo esistenziale con il quale l’uomo si tuffa, per così dire, nel non-ancora-esistente con la sicurezza cosmica che il tuffo stesso causi l’emergere di quella realtà nella quale si tuffa». Questa caratteristica che Panikkar definisce «cosmoteandrica» impregna l’intero sistema concettuale e comportamentale della civiltà vedica. La creazione-sacrificio ha carattere «onnicomprensivo», giacché vi è coinvolto l’intero universo: è «umano, divino e cosmico al contempo. Ovverosia è cosmoteandrico. Dio, Uomo e Universo sono correlati. Dio senza l’Uomo è nulla, ossia “non-cosa”. L’Uomo senza Dio è esclusivamente una “cosa”, non una persona, non un vero essere umano, mentre il Cosmo, senza Uomo e senza Dio è “qualunque cosa”, senza consistenza ed essere; è puro caos inesistente. […] Dio non è completamente altro dall’Uomo né il Mondo è un’entità del tutto estranea all’Uomo. L’Uomo è più di un singolo individuo e più della somma di tutti gli individui».
Straordinaria, però ardua da comprendere fino in fondo, è la compartecipazione dell’umano al divino e al cosmico. Uno fra gli inni più celebri e importanti del Ṛgveda, il Puruṣa Sukta (che Panikkar suggerisce di intitolare Ecce homo), descrive la formazione del mondo dal sacrificio dell’Uomo primordiale, l’Uomo cosmico, che è anche «l’aspetto personale della totalità della realtà»: «Mille teste ha l’Uomo / mille occhi, mille piedi; / cingendo la Terra da ogni lato, / la superò per l’ampiezza di dieci dita. // […] Usando l’Uomo come loro oblazione, / gli Dei compirono il sacrificio. / La Primavera servì come burro chiarificato, / l’Estate come combustibile, l’Autunno come offerta. // […] Da questo sacrificio, compiuto fino in fondo, si raccolse latte cagliato misto a burro. / Da qui vennero le creature dell’aria, / gli animali della foresta e quelli del villaggio. // Da questo sacrificio, compiuto fino in fondo, nacquero gli inni e le melodie; / da questo nacquero i diversi metri; / da questo nacquero le formule sacrificali».
Nel secchio di latte cagliato cantato dall’inno vedico si raccoglie l’Universo. Il burro primaverile dà vita a una nuova primavera, e l’inno stesso scaturisce dal sacrificio dell’Uomo cosmico. Si ricorderà la stupenda ricostruzione della cosmogonia di un mugnaio “eretico” del Cinquecento italiano, il friulano Menocchio, che Carlo Ginzburg ha offerto in uno fra i più bei libri di storia antropologica del Novecento, Il formaggio e i vermi (1976). Misteriosamente, per sottilissimi labirinti e fili culturali, anche Menocchio legge il farsi e disfarsi del mondo in un secchio di latte, nel quale gli angeli-vermi generano il formaggio: «Io ho detto che, quanto al mio pensier et creder, tutto era un caos, cioè terra, aere, acqua et foco insieme; et quel volume andando così fece una massa, aponto come si fa il formazo nel latte, et in quel deventorno vermi, et quelli furno li angeli...». La narrazione di Menocchio dipenderà forse dal paragone biblico fra sacra doctrina e latte, riecheggiato nella scomposizione allegorico-teologica di siero, burro, formaggio che si diffonde nei padri della Chiesa fino a Francesco di Sales (in Letteratura europea e Medioevo latino Curtius lo cita nel capitolo sulla metaforica). Ma è stupefacente scoprire come civiltà pastorali lontane nel tempo e nello spazio abbiano ideato e trasmesso le stesse metafore, le stesse allegorie, per raccontare (su orizzonti mentali diversissimi) l’origine e la metamorfosi, la storia dell’uomo e del cosmo nel loro reciproco implicarsi.
Anche l’Occidente cristiano raccolse la sua collezione innologica, che lungo i secoli fu selezionata e canonizzata in un corpus di carattere liturgico, stringendo in un solo sconfinato abbraccio di più di 1500 anni decine e decine di poeti, da Ambrogio vescovo di Milano e maestro di Agostino d’Ippona, morto nel 397, fino ad Anselmo Lentini, scomparso nel 1989, definito da Federico Giuntoli, curatore dell’edizione einaudiana, «uno dei maggiori interpreti della riforma della Liturgia horarum dopo il Concilio Vaticano II». L’incanto della voce che canta inneggiando non si spegne mai, seduce chierici e laici: ma anziché narrare l’Universo e la cosmogonia, in Europa trasmette messaggi pastorali di ortodossia per contrastare il diffondersi delle teorie ereticali (ad esempio quella di Ario): «Il testo delle innodie diviene con Ambrogio un mezzo privilegiato per divulgare le verità della fede» con il fascino del canto sacro. Nel 386, scrivendo l’omelia pronunciata la Domenica delle Palme, Ambrogio ammetteva la natura quasi-magica della propria retorica riversata negli inni, già allora famosissimi: «Dicono che il popolo sia stato abbindolato anche dall’incantesimo dei miei inni […]. Di certo, non lo nego. Si tratta di un grande incantesimo, il più potente di tutti. Che c’è, infatti, di più potente del confessare la Trinità, che quotidianamente viene celebrata dalla bocca di tutto il popolo?».
Per secoli l’inno cristiano punteggia il breviario, la “liturgia delle ore”. Uscendo dal Medio Evo monastico, nell’Umanesimo la preghiera-inno si intride della ritrovata cultura classica, addirittura della sua mitologia. Nell’innario di Zaccaria Ferreri, all’epoca di Clemente VII, di Michelangelo e di Ludovico Ariosto, «la Trinità diviene il triforme numen Olympi, mentre di Maria si dice che uccise il mostro disgustoso del funesto Flegetonte, riconciliando a noi gli dèi superbi». L’inno ha forza di attrazione, assorbe Orazio, Virgilio e Ovidio, riplasma in letteratura i misteri sacri. Ma le sorprese non finiscono mai. Nel XX secolo un certo Evaristo d’Anversa canta «l’Aurora, messaggera del sole, / che risveglia le fatiche del mondo»: sotto il titolo Soccorritore dei lavoratori, dedicato a San Giuseppe lavoratore per la festa del 1° maggio, l’inno ecclesiastico imita e contrasta, incredibilmente, gli inni politici che negli stessi decenni risuonano con potenza nelle piazze, ne fa suo il lessico e gli slogan: «Si allontanino la violenza e le contese / e ogni frode dai salari, / una sola sobrietà regoli / la quantità di cibo e del tenore di vita». L’inno a San Giuseppe lavoratore canta la gloria del Padre Putativo che scalza dalla loro sfera d’azione gli dèi recenti Lenin e Trotskij, Mao e Che Guevara.
- Raimon Panikkar, I Veda e gli Inni cosmici, a cura di Milena Carrara Pavan, Jaca Book, Milano 2023, pp. 1065, € 45
- Inni cristiani d’Occidente. L’innario della Liturgia horarum iuxta Ritum Romanum, editio typica altera, a cura di Federico Giuntoli, Einaudi, Torino 2023, pp. 950, € 90
- Nicoletta Di Vita, Il nome e la voce. Per una filosofia dell’inno, Neri Pozza, Vicenza 2022, pp. 269, € 22