La voce di Ripellino
Ascoltare la voce di Ripellino, dopo la lettura “silenziosa” delle opere, è una vera emozione: il suo elettrico velluto – un declamato “curiale” percorso da lampi di ilarità, da corrugamenti sarcastici, da sordi rimbombi, franante a tratti in un sospiro che sembra inseguire il fiato disperso – non si dimentica. Una voce educata: da attore; da sacerdote dell’arte.
Ha ragione Antonio Pane, che sull’eco di quella voce, indimenticabile e indimenticata, apriva Fato del libello, l’introduzione magnifica alla sua preziosa raccolta di interviste Solo per farsi sentire (Mesogea 2008). Antonio ricordava «il “filmato” di Rosella De Vito, i fotogrammi di Ripellino che per una volta recita, “con voce morbida e sonora”, le sue poesie». «Vi si può appendere, in dissolvenza, l’eco trasportata da lontane aule universitarie», diceva. E poi rammenta l’entusiasmo di una sua allieva:
Il Professor Ripellino era capace di ispirare nei suoi studenti una specie di esaltazione collettiva, una devozione completa. [...] Quando cominciava a recitare, sembrava lievitare davanti a noi: gli occhi infuocati, gli zigomi rossi per l’eccitazione febbrile, la voce lenta, strascinata, profonda legava le parole l’una all’altra come perle luccicanti di significati diversi.
Chi la dimentica più, quella voce viva? È un flatus sottile ma ancora vibrante, un tarlo che rosicchia la scatola dei ricordi nel mio Teatro della Memoria, colmo di immagini suoni parole: e ogni tanto, come lui disse alla sua «cipollina» nella 28a di Notizie dal diluvio (1968-69), quel flatus vocis sussurra: «vorrei vivere nella tua voce, nei tuoi gesti, nei tuoi occhi, / anche quando mi avrai dimenticato».

Mi sarebbe piaciuto moltissimo sentirgli leggere la poesia da cui ho tratto, come titolo, gli ultimi due versi: una delle prime sue a stampa, apparsa nel 1960 in Non un giorno ma adesso, Grafica, Roma 1960), che infatti apre la scelta curata per Einaudi nel 1990 da tre (Alessandro Fo, Antonio Pane stesso, Claudio Vela) dei Cinque Moschettieri Ripellinisti (il quarto è Federico Lenzi, il quinto Umberto Brunetti), che negli ultimi trent’anni con paziente tenacia, precisione di alta filologia e grazia piena di fuoco hanno costruito con lampeggianti sondaggi le fondazioni su cui ora è sorto un edificio critico-testuale compatto ed elegante (la poesia inaugura anche Poesie prime e ultime, a cura di Federico Lenzi e Antonio Pane, con Presentazione di Claudio Vela e Introduzione di Alessandro Fo, Aragno, Torino 2006). Invece la voce di Ripellino non l’ha mai letta, registrandola perché noi la ricevessimo in dono:
Non ho mai detto d’essere solo
come un pupazzo di Schlemmer.
Le case come vecchine
coi fazzoletti delle persiane sugli occhi
mi ripetono sempre parole cordiali.
Non ho mai detto di soffrire
come un pezzo di legno sotto una pialla.
Ma le stelle sempre si nascondono,
quando cerco un briciolo di luce.
Non ho mai detto d’essere triste
come una bottiglia vuota,
perché so già da tempo
che l’acqua svanisce dalle fontane,
quando ho bisogno di bere.
Non ho mai detto d’essere felice
come una spalliera di peonie,
perché non so catturare la gioia,
che mi sfiora talvolta con piume di cigno.
Non ho mai detto nulla, ma ciascuno
comprende che adoro la vita.
«Non ho mai detto nulla, ma ciascuno / comprende che adoro la vita». L’anafora che si snocciola lungo tutta la poesia la sigilla sul Nulla, quasi volesse dire proprio: «Non ho mai detto Nulla». O forse: «Ho detto il Nulla», quasi si trattasse di un novecentesco, schlemmeriano «Farai un vers de dreit nien» di Gugliemo IX duca d’Aquitania (con cui si apre la lirica europea, all’inizio del XII secolo), o addirittura il non-essere e non-sapere poetico, baldanzoso di e vitale, «Er fenisc mo no-say-que-s’es, / c’aisi l’ay volgut batejar» del grandissimo Raimbaut d’Aurenga, da «Udite, ma non so che sia, / signori, ciò che qui incomincio» fino appunto a «Qui finisco il mio non-so-cos’è: / così ho voluto battezzarlo: / non udii mai nulla di simile, / perciò così devo chiamarlo».
Se così fosse, quell’«ho detto il Nulla», il «non-so-cos’è» di Ripellino, erede di una vastissima tradizione poetica, cancellerebbe la sequenza che alterna strofe di cinque e quattro versi, una sorta di sghemba ballatetta in cui il ritornello si diffrange nell’ossessivo: «Non ho mai detto di…». Si assommano e si annullano nel distico finale le semantiche delle parole-chiave che chiudono i primi versi, fra assonanze e consonanze: la solitudine della prima strofa («solo»), la sofferenza della seconda («soffrire»), la tristezza della terza («triste»), la felicità della quarta («felice»); e quindi anche quelli che Winnicott definirebbe gli oggetti transizionali della lirica: il pupazzo di Schlemmer, il pezzo di legno sotto una pialla (una specie di buffo Pinocchio in lacrime), la bottiglia vuota, la spalliera di peonie. Winnicott dice proprio: «...è come se il bambino potesse ora dire alla madre: “Ti amo perché sei sopravvissuta alla distruzione che ho operato su di te. Nei miei sogni e nella mia fantasia ti distruggo ogni volta che ti penso, perché ti amo”».
La negazione, e nel contempo una fervida resistenza al negare, cresce lunga la lirica, figurando per allegoria un destino di poeta malastrucs (la parola è ancora una volta di Raimbaut d’Aurenga), il Malastrato, il Nato-sotto-cattiva-stella: «le stelle sempre si nascondono, / quando cerco un briciolo di luce»; «l’acqua svanisce dalle fontane, / quando ho bisogno di bere»; fino alla sphragís della chiusura: «perché non so catturare la gioia, / che mi sfiora talvolta con piume di cigno». E qui, appunto, il sigillo che al Nulla oppone la Vita: «Non ho mai detto nulla, ma ciascuno / comprende che adoro la vita».
Continuo a pensare che un fuoco vivido d’ispirazione sia il famoso Osso di seppia montaliano «Non chiederci la parola…» / «Non domandarci la formula…», chiuso dal celebre «Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo», ed anche che nella strepitosa intermemorialità di Ripellino (il termine è stato ideato con grande acutezza da Roberto Antonelli) riemerga il Marino Moretti di Io non ho nulla da dire, scandito da una costellazione (ne conto, fino alla fine, almeno 7 riprese) del verso: «Io non ho nulla da dire», che vale fin da subito come «invariante» prima e principale dell’intero Libro di Poesia e di Vita anche per Ripellino. Nella sua scatola degli attrezzi, come ho proposto nell’Introduzione a Lo splendido violino verde, Artemide 2021, mirabilmente commentato da Umberto Brunetti, e torno ora a proporre, va riconosciuto un intenso, ben testimoniato crepuscolarismo trascendentale, a proposito del quale ho offerto un mazzetto di prove, ma la cui restituzione-restauro richiederà nuove campagne di scavo:
IO NON HO NULLA DA DIRE
Aver qualcosa da dire
Nel mondo a se stessi, alla gente.
Che cosa? Non so veramente
Perché io non ho nulla da dire.
Che cosa? Io non so veramente.
Ma ci son quelli che sanno.
Io no – lo confesso a mio danno –
Non ho da dir nulla ossia niente.
[…]
Ed io sono l’unico al mondo
Che non ha niente da dire.
L’eco di questo Nulla a cui il crepuscolarismo trascendentale di Ripellino oppone la Vita, la Parola, si riverbera fino alla conclusione della Fortezza d’Alvernia, cinque-sei anni dopo. Come avverte Ripellino stesso nel Congedo:
Il topònimo “Alvernia” è una parola compòsita, un “portemanteau word”, nella quale si assommano “inverno”, “averno”, “verna”, e inoltre il ricordo dell’Auvergne francese e della Chanson pour l’Auvergnat di Brassens, che spesso udivo da un disco di Juliette Gréco. “Nonostante” è il “Leitwort” del poema: l’avverbio si fa sostantivo, a indicare noi tutti che, contrassegnati da un numero, sbilenchi, sgualciti, piegati da raffiche, opponevamo la nostra caparbietà all’insolenza del male.
L’Alvernia invernale, funeraria e musicale di Brassens inavvertitamente ci riporta ancora a casa dei trovatori provenzali, “nonostante” quella sia la denominazione fantastica del sanatorio di Dobříš, a pochi chilometri da Praga, dove Ripellino rimase qualche mese nel 1965. La dichiarazione è sempre quella di chi scrive per «tenere a bada la morte»: «adoro la vita»; «anche se nonostante, continuo ad amarti»…
Vita, non abbandonarmi. Comunque tu sia, cactus, coltello,
daga, cappio, ferro in fuoco, oscurità, malsanía,
sei sempre vita, e frullina e leggiadra e civetta:
anche se nonostante, continuo ad amarti.
Comunque tu sia, laida e scrignuta e streghesca e malvagia,
sei sempre vita, e preziosa nel mio lapidario.
Verde riviera, non abbandonarmi:
anche se involto d’atroce malinconia,
non voglio smarrirti, zitella dal fiato pesante,
guercia bigotta, garrula becchina ,
tu rogna e affrantura, tu amore, mia vita,
tu limpida vita, tu vita inimica, ma vita.
(La Fortezza d’Alvernia, n° 51, ultima poesia)
E già in Non un giorno ma adesso, nella serie anaforica dall’aria ancora una volta antica, trobadorica, dantesca, «Vivere» è, secondo quella che Wisława Szymborska scopriamo essere la «meravigliosa normalità del mondo» (così l’ha definita il suo biografo Michał Rusinek), «semplicemente, amare la vita»:
Vivere è stare svegli
e concedersi agli altri,
dare di sé sempre il meglio
e non essere scaltri.
Vivere è amare la vita
coi suoi funerali e i suoi balli,
trovare favole e miti
nelle vicende più squallide
Vivere è attendere il sole
nei giorni di nera tempesta,
schivare le gonfie parole
vestite con frange di festa.
Vivere è scegliere le umili
melodie senza strepiti e spari,
scendere verso l’autunno
e non stancarsi d’amare.
(Non un giorno ma adesso)
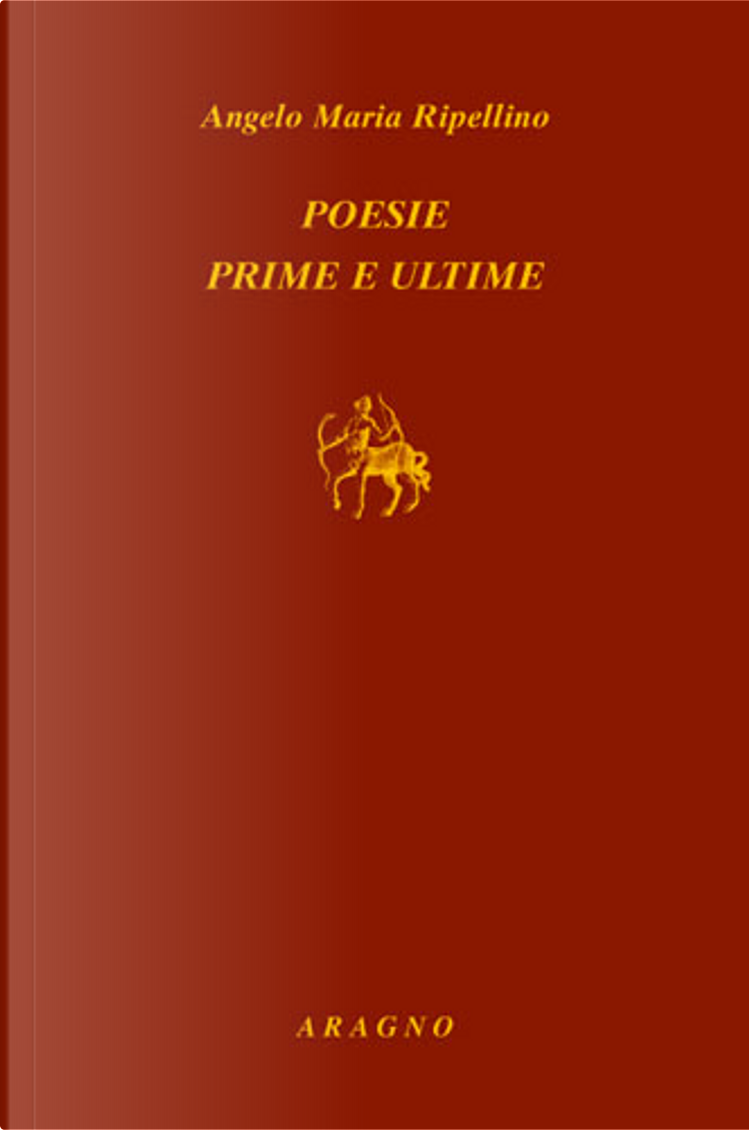
Credo che avrebbe potuto scriverli lui, Ripellino, quei versi così ripellineschi di Alexàndr Blok dell’ottobre 1908, che invece tradusse nella meravigliosa antologia Poesia russa del Novecento, realizzata per Guanda nel 1954 (Caterina Casadei ha scritto cose belle sul rapporto fra l’arlecchinesco Blok e la poesia di Ripellino):
Abbàssati, tendina scolorita,
sui miei gerani malati.
Fuggi, illusoria vita zingaresca,
spegni, chiudi gli occhi tuoi!
Eri tu, vita, a ornare la mia stanza
squallida con erba della steppa?
Eri tu, vita, ad avvelenare
con verde vino il mio plumbeo sopore?
(Poesia russa del Novecento, a cura di A. M. Ripellino, Guanda 1954, p. 141)
«Tu rogna e affrantura, tu amore, mia vita, / tu limpida vita, tu vita inimica, ma vita». Vita, come Gioia, è uno dei vocaboli-pilastro, una fra le strutture immaginali-lessicali su cui poggia l’arborescente architettura allegorica di Ripellino, intesa (come scriveva benissimo Alessandro Fo nel 1990, La poesia di Ripellino) a trasformare la «propria giocoleria letteraria» nell’«aspetto precipuo di un compito quotidiano: vestirsi da domatore, “tenere a bada la morte”». «Come in giovinezza», si dice nell’ultima pagina del Congedo della Fortezza d’Alvernia, «ancor oggi scrivere poesie è per me soprattutto dare spettacolo, ogni lirica è un esercizio di giocolería e di icarismo sul filo dello spàsimo, un tentativo di tenere a bada la morte con tranelli verbali, bisticci e negozi di immagini». E che sullo sfondo Ripellino pensi al Portrait de l’artiste en saltimbanque di Jean Starobinski, libro da lui amatissimo (io stesso lo tradussi per Paolo Boringhieri nel 1984; una nuova edizione, con un saggio rimeditato tanti anni dopo, è apparsa da Abscondita nel 2018), lo indica con precisione, mi sembra, un richiamo nell’ultimo capoverso del Congedo:
Mille scuole, mille lune si avvicenderanno nei cieli letterari, ma il poeta sarà sempre un Kao-O-Wang, un nonostante, una sardina decapitata, – e perciò un “fool”, rifiutato dall’Indifferenza e sommerso da quell’Eterno Buon Senso che oggi chiamano Civiltà dei Consumi, – un fuori sesto, un X a disagio, che si sente colpevole di tutto, senza aver colpa di nulla.
Non ho mai capito chi sia Kao-O-Wang, oltre che un Nonostante della tribù ripelliniana, che emerge per la prima volta, misteriosamente, in una delle ultime poesie di Non un giorno ma adesso (1960):
Inutilmente Kao-O-Wang trae da una cassa laccata
file di lampioncini, sciabole di rame,
draghi, calici, serpi, bandiere stralunate,
che al suo tocco si coprono di fiamme.
Inutilmente disegna nel tessuto dell’aria
con un cero fumoso le linee d’un vecchio castello.
Però lo immagino anacronisticamente imparentato (dieci anni prima) con un altro fantasma-immagine, La clownessa Cha-U-Kao di cui Starobinski nel 1970 parla all’inizio del capitolo più notevole del Portrait, quello sui Sauveurs dérisoires, i Salvatori derisori: «Così come la fissa il pennello di Toulouse-Lautrec, sembra una replica al femminile del Vecchio Saltimbanco baudelairiano». Disfatta, crollata, la clownessa è, al pari di Baudelaire e di Ripellino, sulla soglia della fine. Direbbe Kafka: senza speranza, perciò piena di speranza. Secondo il poeta e critico d’arte Jean Laude, Cha-U-Kao «esprime una stanchezza immensa e la coscienza vacillante di una degradazione». Però Starobinski nella derelizione assoluta vede scintillare il fulgore del riscatto, quasi un’immagine dialettica benjaminiana: «Questa stanchezza è l’esatto rovescio dello spettacolo, ma a sua volta lo spettacolo, con le sue luci e i suoi ceroni, è il rovesciamento di quella stanchezza». Quel che tocca intimamente Ripellino, come Georges Rouault, il più intenso pittore di clowns tragici e cristologici, «è la scandalosa collusione fra le apparenze esteriori e l’anima». Come Rouault, anche Ripellino vuole colpirci con l’effetto patetico della contraddizione fra l’interno e l’esterno. Ha bisogno del travestimento derisorio, del costume di lustrini, per farci provare l’infinita tristezza dell’anima esiliata al di fuori del suo vero spazio, nella condizione del “forestiero” e nell’esistenza errabonda. [...] Il clown è il rivelatore che porta la condizione umana fino all’amara coscienza di sé stessa. L’artista deve diventare l’attore che si proclama attore.
«Librarsi in volo e piombare a terra, trionfo e declino; agilità e atassia; gloria e sacrificio; il destino delle figure clownesche oscilla fra questi estremi»: così Starobinski apriva il capitolo Sauveurs dérisoires, Salvatori derisori. Ancora una volta il Congedo della Fortezza d’Alvernia conferma che la scelta delle maschere spettacolari, delle persone clownesco-funamboliche, per Ripellino non fu solo un facile addobbo teatrale, ma una scelta di poetica profondamente radicata nella tradizione europea. «Ogni tessitura poetica è anche un amàlgama e un compendio di citazioni», proclama ancora il Congedo della Fortezza (ove fra l’altro si rimanda, significativamente, alle Origini romanze, «all’acerbità lessicale della nostra poesia del Due e del Trecento»). Poco più tardi (1975), nella prosa Di me, delle mie sinfoniette, conferma il ruolo importante della memoria testuale nella propria opera: «Un’ebbra molteplicità di rimandi e reminiscenze ricerca e nutre il tessuto della mia scrittura». E comunque, nella recensione che Ripellino pubblicò sull’«Espresso» dell’11 ottobre 1970, all’uscita del Portrait (raccolta da Umberto Brunetii e Antonio Pane nel II volume di Iridescenze, Aragno 2020), emerge qualche “distinguo” nei confronti della «spettralità» dei clowns sacrificali starobinskiani:
Ogni pagliaccio tragico è per Starobinski un abitante provvisorio della propria apparenza, e quasi uno spettro. […] Da questa spettralità si diramano due interpretazioni del binomio pagliaccio-artista. La prima: che egli sia una larva demonica come arlecchino […]: che egli venga da un altro spazio, contrabbandiere che varca frontiere vietate, revenant che soffoca il suo urlo ferino, il suo male, coprendolo con un chiacchiericcio cocasse. La seconda: che invece l’olocausto del saltimbanco deriso, l’umiliazione e la contumacia di quello che prende gli schiaffi siano una replica della passione di Cristo. Con bizzarria reversibile il clown riceve un’aureola si santità e a Cristo si appicca la maschera sguaiata del clown. Qui viene in soccorso Georges Rouault, la cui religione si esprime con uguale veemenza nei quadri di tema sacro come nelle apocalissi clownesche. Il Golgota e il tendone del circo sono contigui, e il clown, ovvero l’artista, colui che si espone al ludibrio di una plebe che sgrigna, è un frutto che soffre, una vittima redentrice.
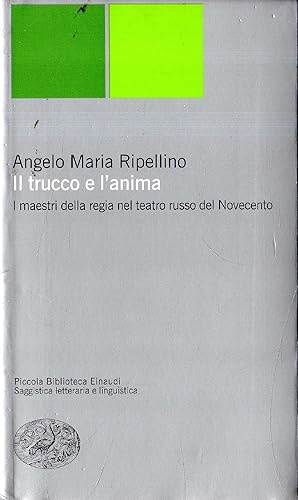
Ma Ripellino si dichiara attratto specialmente dal «clown balordo, che esprime la plumbea gravezza della terra», buffone da commedia dell’arte che resiste al balzo antigravitazionale, alla leggerezza del funambolo, e fa ridere lasciandosi cadere, rinunciando al volo:
Sacco di tela grossa, tardo di comprendonio, maldestro, imbroglia tutto, semina confusione, sovvertendo con la sua goffaggine provvidenziale l’ordine constabilito. Flaccido e cannarone, parente dei pappalasagne e dei guastafeste del teatro folclorico, è incapace di levarsi in alto, lo affascina il gouffre d’en bas.
Vita e Gioia sono i perni del mundus fantasticus di questo grande Classico fra i moderni, così legato alla tradizione romanza, nella sua arcata millenaria. È ancora Fo ad aver colto con grande finezza come
nella poesia di Ripellino – così vaga di giochi verbali – ricorrono parole-valori che curiosamente s’incastrano l’una nell’altra, riconfermando col vincolo dei fonemi il legame che interconnette le cose da esse significate. La «gioia» ad esempio, che è la parola chiave di tutto questo universo, tanto perfettamente si adagia lungo «giovinezza» che questa finisce per apparire quasi una semplice espansione dell’altra: come il finale di una stupenda poesia vuol confermare.
La poesia evocata da Alessandro Fo è il n° 76 di Notizie dal diluvio, «Quando partono i comici, / scende pesanza nel cuore», con Scardanelli che «da un lembo dell’Aurelia sventola il fazzoletto». La lirica si chiude appunto, come nota Fo, sulla «gioia» “contenuta”, alla lettera, alfabeticamente, nella «giovinezza»: «Così se ne va per il mondo la gioia, la giovinezza / lasciandoci obliqui, appassiti, di pezza».
Non saprà «catturare la gioia», questo saltimbanco geniale e bislacco, questo «squamoso pagliaccio in bombetta»: ma di gioia sa certo «ferire» per aprire alla scrittura «uno spazio felice (come voleva Bachelard)», per «straziare il grigiore», in cerca di «una gioia contumace, assopita e travestita»: così mi disse un giorno, esattamente 48 anni fa, dialogando a casa sua, in Via Sant’Angela Merici, non molto lontano dalla “Sapienza” (pubblicai l’intervista, sotto il titolo A. M. Ripellino e la magia della scrittura, in «La fiera letteraria» del 15 giugno 1975: la si legge ormai nel già rammentato Solo per farsi sentire). E infatti ancor oggi, leggendolo, e riascoltando nel fondo della memoria quella «voce lenta, strascinata, profonda» che «legava le parole l’una all’altra come perle luccicanti di significati diversi», ciascuno comprende che adorava, e che la sua poesia, immortale dopo la sua morte, continua a adorare la vita.
«Non ho mai detto nulla, ma ciascuno / comprende che adoro la vita». Dovette incantare Ripellino questo continuo intrecciare le sue «parole-valori» (Alessandro Fo): Vita, Nulla, Gioia. Ed è proprio sul Nulla che chiude uno fra i suoi libri più belli, Lo splendido violino verde. Se «camicie» in Gozzano può rimare con «Nietzsche», e «fraterne» con «Verne» in Moretti, Ripellino, immerso nella luce del suo crepuscolo, ha ideato la splendente quanto tenebrosa rima gioia : Goya («Quanta fatica per raggiungere la gioia, / per districarsi dall’intruglio delle tenebre, / dall’obbrobrio della notte-Goya, / da questa occhialuta febbre»: Lo splendido violino verde, n° 15). Lui che «non ha mai detto nulla», è autorizzato, a chiudere il suo libro con la più cetrullesca e pulcinellesca, la più arlecchinesca e filosofica delle rime, evocando la fascinosa Hanna Schygulla, che occhieggia dalla copertina del libro nell’edizione Brunetti, guardando, seducente sirena Cetrulla, verso il Nulla:
Quanta enfasi, quanta arroganza cetrulla.
O vita, o Hanna Schygulla,
sciantosa di varietà, sulla riva
del Nulla.









