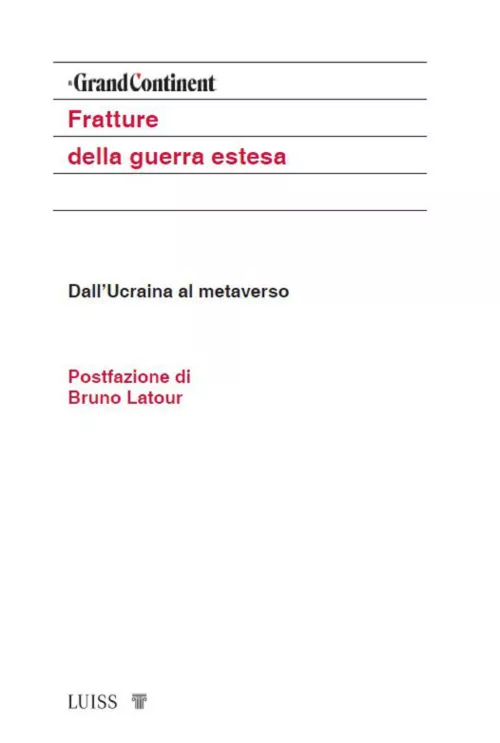Una grande Europa?
Grand Continent si presenta come una rivista europea, per certi versi la prima, scritta non più da francesi italiani tedeschi etc., ma da europei. E non da burocrati di Bruxelles ma da studiosi espressione della società civile europea in formazione. Fin qui l’inizio è buono, è una risposta all’euroscetticismo cha ha alle spalle padri nobili e non solo le attuali macchiette nazionaliste: una generazione fa, scriveva Raymond Aron che non esisteva cittadino europeo ma solo cittadino francese, italiano, tedesco etc.
La guerra è al centro dell’analisi di Grand Continent in un recentissimo volume (Fratture della guerra estesa. Dall’Ucraina al metaverso, Luiss 2023). L’idea è che ci siamo illusi, per molto tempo, che la guerra non fosse alle porte dell’Europa: adesso è entrata con prepotenza dalla porta Ucraina.
L’analisi è però iperbolica, eccede per quantità e forse manca di qualità. La quantità retorica messa in campo da Grand Continent riguarda l’entità della posta in gioco, ordine o caos: se crolla l’Ucraina l’Europa diventa ancora più marginale; se vince l’Ucraina sarà la Russia a crollare e l’Europa dovrà gestirne gli effetti imprevedibili; se infine non vince nessuno dei due si delinea uno scenario di transizione, con l’Europa spettatrice più che attrice. Il presupposto è che entrambi i campi contendenti, Occidente e Russia, sperano “implicitamente o esplicitamente, che si produca un cambio di regime presso l’avversario” (così Jean-Marie Guéhenno che firma l’articolo iniziale). Ma questa analisi su cui è lecito dubitare (davvero vogliamo il cambio di regime in Russia? e la Russia pensa a un cambio di regime in Occidente?) non è suffragata da alcuna evidenza empirica né da alcuna ipotesi teorica.
Manca un’idea di Europa nell’analisi di Grand Continent: un paradosso perché un “grande continente” non può essere tale se non ha una visione del mondo. La Cina certamente ce l’ha, gli Stati Uniti pure: i due capitalismi politici vedono il mondo a partire dal proprio interesse imperiale. La Cina ha illustrato nel Quotidiano del popolo, tempo fa, la propria immagine del mondo: la Cina al centro, l’immensa Asia che si protende verso la piccola appendice Europea, l’Africa assai prossima alla Cina, l’America del Nord e del Sud ai poli opposti. Divide et impera. L’altro impero, quello Americano, vede il mondo attraverso il proprio dominio tecnologico, che seppur sfidato è ancora lì saldamente localizzato, nelle grandi imprese digitali che comandano il consumo globale di tutti noi. L’Europa non ha alcuna visione del mondo.
Ce l’aveva De Gaulle, un’Europa dall’Atlantico agli Urali (Russia compresa!). Ce l’aveva il filosofo Alexandre Kojève: un Impero Latino in grado di integrare le due sponde del Mediterraneo, Europea e Africana. Ma erano gli anni 1940-‘50. Oggi non ce l’ha alcuno dei leaders europei, divisi e incapaci di visione, né la Commissione Europea debole e ambigua: liberista nei fatti, universalista a parole.
Anche il paragone tra la prima guerra fredda America-Unione Sovietica del XX secolo e la seconda guerra fredda attuale, a più livelli e a più strati (contenuta nell’articolo di Carlo Galli) non convince. Una volta c’erano due blocchi, Ovest ed Est, e ciascuno aveva i suoi alleati, più un certo numero di Paesi non allineati. Oggi molto dipende dal punto di vista multipolare dell’osservatore: per un Africano (ma sono oltre 50 Paesi diversi) o per un Latinoamericano la guerra calda Ucraina e quella stessa Israelo-Palestinese non sono che episodi remoti. Il vero tema è la dissoluzione dell’ordine mondiale, evidente nei suoi termini economici, politici e militari. La ripresa dei BRICS (Brasile Russia India Cina Sud Africa) e il loro eventuale allargamento, il protagonismo dei paesi islamici moderati e dei regimi totalitari come l’Iran, etc. sono elementi di un puzzle che non sta dentro l’immagine della seconda guerra fredda.
In questo scacchiere frammentato come si colloca l’Europa e cosa deve fare? Qui le risposte degli autori di Grand Continent variano non poco. Assumere un assetto democratico che dia legittimità al modello occidentale di civiltà (come sostiene Carlo Galli)? Spingersi verso un neoidealismo geopolitico rivolto al futuro mediante un approccio morale (secondo Benjamin Tallis)? Entrambe le proposte non rispondono a mio avviso alla crisi dell’ordine liberaldemocratico, anzi fanno come se esso fosse tuttora bene in sella. Ma così non è. Inoltre, la crisi delle democrazie liberali non è altra cosa dalla crisi della globalizzazione che le liberaldemocrazie hanno sostenuto per trent’anni. Simul stabunt simul cadent.
Molto importante è il rapporto tra l’Europa e i Paesi non allineati, documentato nell’articolo di Apratim Sahai. Essi (India in testa, ma insieme ad essa Indonesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti con Dubai, nuova Londra per i capitali russi, indonesiani, cinesi, mediorientali) puntano ad aggirare il dollaro americano e le sanzioni alla Russia. Rappresentano un blocco non omogeneo, ma unito nel negoziare gli “interessi del petrolio” e gli “interessi delle terre rare” con l’Occidente e in particolare con l’Europa. La quale gioca il solito gioco nazionale, con accordi tra singoli Paesi europei (Germania, Francia, Olanda) e singoli Paesi non allineati su energie infrastrutture veicoli elettrici etc., uno schema che ripete gli errori della globalizzazione anarchica del passato trentennio. Insomma, l’Europa non esiste né come unica potenza politica né come unica piattaforma economica. Ma è questo che dovrebbe sforzarsi di decidere e di fare.
Soprattutto, continua così la vecchia politica estrattiva che ha visto protagonista l’Occidente coloniale e postcoloniale. Nessuna green economy mondiale, mentre si infittiscono gli scambi opportunistici tra Paesi a colpi di materie prime, generi alimentari, armamenti, tecnologie. L’articolo di Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, dal titolo pomposo “Un Green New Deal globale da Washington” non deve ingannare. Si tratta infatti di una nuova ricerca del “consenso di Washington”, quello andato in pezzi negli ultimi anni perché basato sull’imposizione ai Paesi emergenti di un unico modello, quello della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, basato su riforme economiche liberiste. Adesso si cerca il consenso rivedendo quella ricetta fallimentare: essa ha svuotato la stessa America trasferendo all’estero la produzione di beni strategici, ha fatto crescere solo la finanza, ha favorito la Cina, ha aggravato la crisi climatica e approfondito le diseguaglianze. Cosa lo dovrebbe sostituire per Sullivan? Uno Stato che “investe in modo mirato in quei settori che liberano il potere e l’ingegno dei mercati privati, del capitalismo e della concorrenza”. Ma è esattamente il neoliberismo! Che mai ha abbandonato lo Stato, sempre lo ha usato per il rafforzamento degli interessi economici dominanti. Mentre il vero New Deal, quello di Roosevelt, aveva imposto una colossale redistribuzione della ricchezza quale neppure Lenin aveva realizzato in Unione Sovietica (parola dell’economista Joseph Schumpeter, uno che di capitalismo se ne intendeva).
Sullivan propone un modello concentrico con al centro gli USA, in un secondo cerchio gli alleati europei e indopacifici, in un terzo il resto del mondo. Modello innovativo secondo Grand Continent: ma in effetti del tutto simmetrico alla visione imperiale Cinese. Da questo duopolio non si esce. E il ruolo dell’Europa si annulla in esso.
L’articolo di Chris Miller, “Da Taiwan al metaverso”, mette in evidenza che il sorpasso Cinese sta già avvenendo in settori decisivi della potenza militare: marina, missilistica, armi AI (intelligenza artificiale). Eppure, le porte vitali della tecnologia (semiconduttori, software) sono ancora in mano Americana. E le aziende dominanti dei semiconduttori stanno a Taiwan e in Corea del Sud, in Giappone e in Olanda. Sono questi Paesi che decideranno in un senso o nell’altro la guerra tecnologica in corso tra le due Potenze.
Intanto l’Europa, nel settore decisivo delle nuove tecnologie energetiche pulite, sta facendo autogoal: Paesi come l’Italia e la Spagna hanno dovuto tagliare i programmi di sovvenzione ai produttori di energia solare a causa delle pressioni di bilancio (il suicidio Europeo è ben descritto nell’articolo di Adam Tooze che denuncia “un incoerente insieme di imperativi con direzioni e obiettvi diversi” dentro l’architettura neoliberale Europea del mercato delle quote di emissione che lasciava le imprese libere di seguire strategie indipendenti.
Il libro è impreziosito da una postfazione di Bruno Latour, scritta poco prima della sua scomparsa, che traccia un parallelo affascinante tra guerra territoriale (quella Ucraina) e guerra climatica. Si tratta di due conflitti territoriali, diversi ma convergenti. L’auspicio di Latour è che, come la guerra territoriale aggiunge l’Ucraina all’Europa (fino al suo ingresso nell’Unione Europea), così la guerra del nuovo regime climatico aggiunge le fonti, i luoghi, i Paesi di estrazione che i Paesi europei utilizzano (le connessioni che assicurano prosperità all’Europa la legano ai Paesi emergenti) e che ridefiniranno le frontiere dell’Europa. Fino a quello che ci sembra impossibile ma che è invece essenziale: “formare volontariamente una nazione”.