Archivi / Valeria Luiselli, Archivio dei bambini perduti
“La storia che voglio raccontare è quella dei bambini che sono scomparsi, le cui voci non possono essere più udite perché sono andate perdute, forse per sempre. Forse, come mio marito, vado anch’io a caccia di echi e fantasmi. Soltanto che i miei non si trovano nei libri di storia e nemmeno nei cimiteri. Dove sono i bambini perduti? E dove sono le due bambine di Manuela? Non ne ho idea, ma so una cosa: se voglio trovare qualcosa, qualcuno, se voglio raccontare la loro storia devo cominciare a cercare altrove.”
Archivio è una parola stupenda, me ne piace il suono, mi piacciono le altre parole a cui rimanda: arco, architettura, architrave. Un altro modo di definire archivio è con l’uso del termine scriniàrio (scriniarius, scrinium e quindi scrigno). L’archivio è dunque anche uno scrigno, che aggiunge all’importanza della conservazione anche qualcosa di protettivo, di affettivo. La fascinazione per gli archivi mi accompagna da sempre, mi piace l’idea di un posto in cui si possano trovare le cose – tutte le cose, anche quelle inventate o soltanto immaginate; mi piace che ci sia qualcuno che abbia la cura e la necessaria pazienza di occuparsene. Gli archivi sottoterra, la polvere, la ricerca, la consultazione, il prendere da uno scaffale e poi riporre. Gli archivi sono storia, gli archivi fanno memoria. Pensiamo agli archivi e guardiamo al passato, invece le scatole, le parole, i suoni che verranno a salvarci saranno conservati negli archivi del futuro. Valeria Luiselli, con Archivio dei bambini perduti (La nuova frontiera, 2019 – trad. di Tommaso Pincio), raccoglie tracce, semina presente, costituisce la memoria che verrà, lo fa mediante i suoni del mondo, il lessico di una famiglia in viaggio attraverso gli Stati Uniti, lo fa nominando le cose daccapo.
L’esigenza di nominare le cose mi ha ricordato Jeffrey Lockhart, il protagonista di Zero K di Don DeLillo (Einaudi 2016, trad. di Federica Aceto). Lockart, più volte in quel romanzo manifesta la necessità di nominare le cose, perché se non lo fa non le riconosce, perché potrebbero sparire da un momento all’altro. DeLillo costruiva con quel testo una casa del linguaggio, Luiselli con il suo archivio costruisce un viaggio nel (del) linguaggio, arricchendo le parole, vecchie o nuove che siano, dei suoni che fanno, dei suoni che le circondano. La lingua, quindi, la capacità che hanno i quattro protagonisti del libro – mamma, papà, figlio, figlia – di comunicare tra di loro, di passarsi le storie e di inventarne di nuove, è la base su cui nasce la ricerca dei bambini perduti, l’archivio all’aria aperta, sotto il cielo, fatto di echi, riverberi, forse destinato a salvarci. L’archivio di Valeria Luiselli si assume l’onere di salvare i bambini perduti.
“Le conversazioni in una famiglia, diventano archeologia linguistica. Costruiscono il mondo che condividiamo, lo stratificano in un palinsesto, dando senso al presente e al futuro. La domanda è: in futuro, scavando nel nostro archivio privato, riascoltando il nastro della nostra famiglia, quelle conversazioni equivarranno a una storia? A un paesaggio sonoro? O saranno soltanto macerie di suoni, rumori e detriti?”
I protagonisti di questo romanzo sono quattro, una famiglia. I due adulti si sono conosciuti e poi innamorati grazie al lavoro che hanno dovuto fare insieme, raccogliere, documentare, i suoni e le voci – i dialetti e le lingue – parlate a New York, di quartiere in quartiere, per alcuni anni. Nei parchi, davanti alle scuole, nelle metropolitane, nei bar, davanti ai tribunali. Lui è il padre del bambino, lei è la madre della bambina, sono i genitori di entrambi. Dopo anni di felicità decidono di partire verso il sud degli Stati Uniti, in Arizona. L’uomo vuole lavorare sugli Apache, catturare i suoni dei luoghi in cui l’ultimo gruppo di quegli indiani si arrese. La donna vuole andare nei territori in cui l’emergenza migratoria – i flussi di bambini che arrivano dal Messico, scappando da un destino orribile verso un futuro impervio, incerto – si mostra. Sono piccoli e attraversano da soli il confine, trasportati spesso da quei furfanti che vengono chiamati coyote facendosi pagare a caro prezzo, e abbandonati in piena notte nel deserto. Questo è il punto di partenza del romanzo.
"Quei bambini erano venuti negli Stati Uniti per cercare protezione, cercare madri, padri o altri parenti migrati in precedenza che potessero accoglierli. Non cercavano il Sogno Americano, come si dice di solito. Quei bambini cercavano solo una via d'uscita dal loro incubo quotidiano."
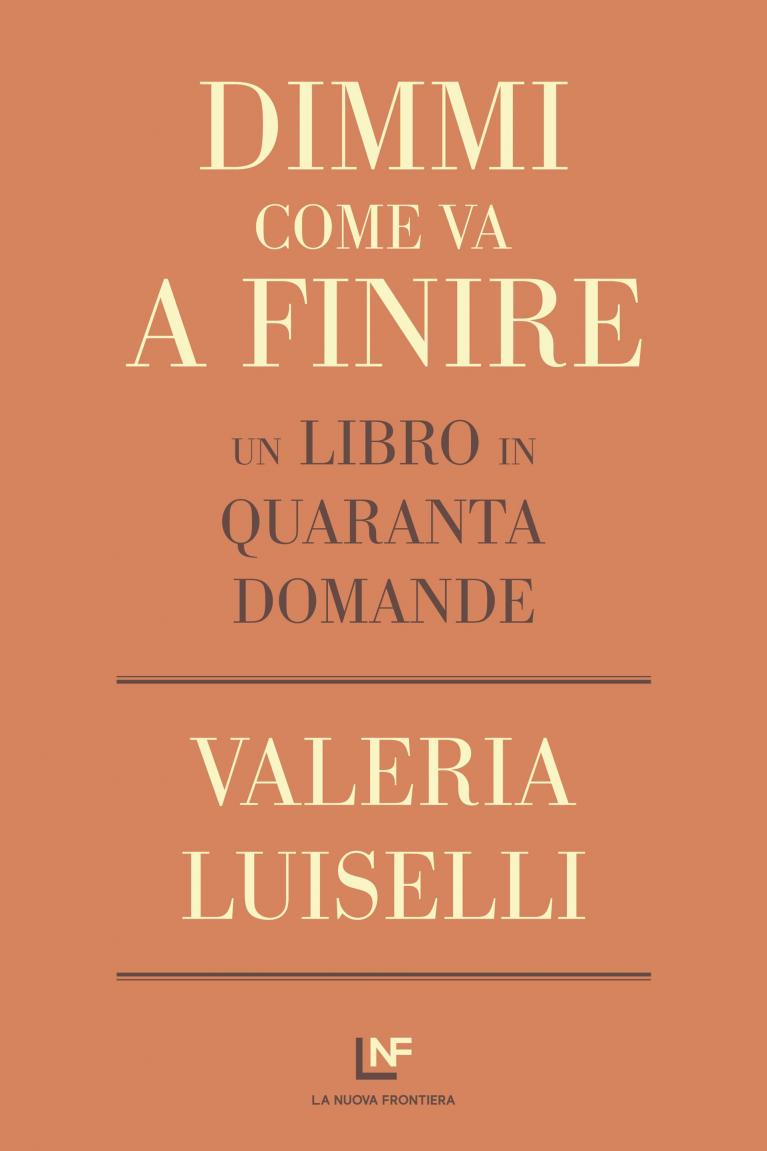
Questo però non è un romanzo classico, è diverso e straordinario per molti motivi. Intanto bisogna parlare delle stratificazioni narrative che la storia porta con sé. Ci sono due narratori. Nella prima parte del libro narra la madre, nella seconda il figlio; per essere precisi i narratori sono potenzialmente tre, perché quando parla il figlio, quando racconta a sua sorella minore (lui ha 10 anni, la bambina 5) ha due voci diverse, una è quella del fratello, la seconda è quella che inserisce all’interno del racconto la vicenda dei bambini perduti, reinventata come i ragazzini sanno fare, partendo da un piccolo libro rosso che la madre ha portato con sé e da quello che ha detto loro.
La lingua e l’immaginario di Luiselli cambiano in base al narratore, una è quella della madre quando dice per sé e quando riporta le parole del marito e dei figli; un’altra è quella del bambino, tutto è uguale e tutto è diverso. Nel lungo viaggio il tempo si sospende tra due mondi, quello degli adulti e quello dei bambini, c’è un passato da cui si viene, ma dentro quella macchina dal bagagliaio capiente si scrive un futuro.
“Immagino che un archivio ti metta a disposizione una sorta di vallata in cui i tuoi pensieri possono rimbalzare e tornare da te, trasformati. Sussurri intuizioni e pensieri al vuoto, nella speranza di udire qualcosa in risposta. E a volte, soltanto a volte, un’eco ritorna, in effetti, un riverbero vero e proprio, qualcosa che rimbalza con chiarezza quando hai finalmente azzeccato il tono giusto e trovato la giusta superficie.”
Il paesaggio cambia via via che si macinano i chilometri, ci sono gli audiolibri, il più volte ascoltato (e non causalmente) Il signore delle mosche, ci sono le canzoni, tra queste Space Oddity di Bowie, un vero e proprio codice di comunicazione tra i due bambini, ci sono i notiziari che parlano dei piccoli deportati, un aereo che parte da Roswell in New Mexico per riportarli indietro in uno dei capitoli più toccanti del romanzo. In un incontro pubblico tenutosi a Venezia, alla Libreria MarcoPolo, parlando di quel capitolo, Luiselli ha detto che gli stranieri negli Usa vengono chiamati Aliens e se ricordiamo la storia degli ufo legata a Roswell capiamo la scelta di far decollare l’aereo da lì. Il paesaggio risente di ciò che avviene nell’auto, delle voci degli indiani riportate indietro dal padre, dei numeri di telefono cuciti nel colletto interno degli abiti dei bambini che provano a passare il confine, come le due bambine di Manuela (donna che la narratrice ha conosciuto a New York, per registrarne il dialetto) che si trovano perdute e sperdute in un centro vicino alla frontiera o chissà dove.
"Questo paese, ha detto papà, è tutto un cimitero, ma solo poche persone hanno una vera tomba, perché la vita di gran parte della gente non conta nulla. La maggior parte delle esistenze viene cancellata, va perduta in quel vortice di spazzatura che chiamiamo storia, ha detto."
Nel baule ci sono sette scatole, quattro dell’uomo, una della donna, due per i bambini. Quelle dei bambini sono vuote. Nelle scatole degli adulti ci sono mappe, libri (veri o inventati, uno composto da sedici elegie dei bambini perduti è uno dei nodi cruciali del romanzo).
È un libro pieno di suoni, cito ciò che ha affermato Luiselli: “È come se occupassimo uno spazio privo di gravità, di gravità morale e sociale. L’audio è il mezzo più contemporaneo, perché devi prestare attenzione, non puoi inghiottirlo, devi ascoltare dall’inizio alla fine". Archivio dei bambini perduti lo leggiamo ma lo ascoltiamo, facciamo caso alla musica di un paese attraversato, al rimbalzo di una voce in un canyon, immaginiamo il rumore di piccoli passi sulla terra, sentiamo il vibrare di quell’aereo che decolla, la melodia furiosa dei pensieri degli Apache. Che rumore fa un bambino che scompare? Qual è il suono di un bambino perduto? Che note si susseguono quando due che si sono molto amati si stanno lasciando?
Valeria Luiselli è una giovane scrittrice che ha molto da dire e lo dice benissimo. È nata in Messico, vive a New York, è anche italiana. Questo tempo di migrazioni è il suo tempo. I bambini si spostano, sono destinati a spostarsi, si sposteranno, ci sposteremo, saper raccontare in un’opera di fiction ciò che avviene, ciò che sta avvenendo significa intravedere la strada che verrà. Anche questo è il compito della letteratura. Luiselli lo affronta sia con i romanzi che con i saggi; tra questi mi piace ricordare il più recente, lo splendido Dimmi come va a finire (La nuova frontiera, 2017) perché è collegato direttamente ad Archivio dei bambini perduti. Scrivere quel saggio ha liberato lo spazio in cui il suo talento di ha potuto costruire il romanzo.
Archivio dei bambini perduti è il libro della perdita, del lasciarsi le cose alle spalle, è il vuoto (come quello delle due scatole dei bambini) da riempire. Il futuro viene dopo che tutti si sono persi: i bambini che valicano il confine, il fratellino e la sorellina che decidono di andare a cercarli, la mamma e il padre che a ogni chilometro lasciano qualcosa e si perdono. È un libro che arricchisce e commuove. Ci troviamo davanti a una delle opere più interessanti pubblicate quest’anno. Diamo il nome giusto alle cose, andiamo a cercare e troveremo. I bambini perduti ci riguardano, non occuparcene ci farà smarrire e non ci sarà un numero di telefono cucito addosso a salvarci.









