Speciale
Dizionario Levi / Antropologo
Il testimone, il chimico, lo scrittore, il narratore fantastico, l'etologo, l'antropologo, l'alpinista, il linguista, l'enigmista, e altro ancora. Primo Levi è un autore poliedrico la cui conoscenza è una scoperta continua. Nel centenario della sua nascita (31 luglio 1919) abbiamo pensato di costruire un Dizionario Levi con l'apporto dei nostri collaboratori per approfondire in una serie di brevi voci molti degli aspetti di questo fondamentale autore la cui opera è ancora da scoprire.
«Ogni grande narratore è anche un etnologo, e tale qualità, che in alcuni può risultare accessoria o implicita, in Primo Levi divenne via via centrale». Sono parole di Daniele Del Giudice (Introduzione, in Primo Levi, Opere, Einaudi 1997), delle quali va sottolineato l’aggettivo “grande”. Perché non tutti i narratori sanno, dopo aver analizzato, sviscerato, metabolizzato le categorie del vissuto, restituire non una semplice descrizione della realtà, ma anche e soprattutto una nuova visione di quei fatti, elaborata alla luce della storia e del comportamento umano. Una narrazione che non si limiti al descrivere, ma che proponga una nuova teoria attraverso cui guardare il mondo.
È nel campo di Auschwitz prima e lungo le strade di mezza Europa poi che Primo Levi getta le basi della sua antropologia. È là che inizia il suo lavoro di etnologo, per poi tradurre tutte le sue riflessioni nella sua opera più profonda e drammatica che sarà I sommersi e i salvati. Perché il campo è involontariamente un laboratorio dove si sta compiendo un esperimento terribile, che finisce per mettere in luce cosa faccia parte della natura umana e cosa sia invece il prodotto della cultura.
Sopravvissuto al campo di sterminio, Levi attraversa un’Europa segnata da una umanità rimescolata, travolta da una guerra che è iniziata con una rivendicazione identitaria fortissima ed è finita con lo sbriciolare ogni appartenenza. Perché per appartenere a qualcosa bisogna prima di tutto essere qualcuno, essere un uomo. Il dubbio che Levi nutre fin dal suo primo scritto. Come una valanga, la guerra aveva travolto il continente, nessuno era più al suo posto, in quello che credeva essere il suo posto. Babele era ritornata: «Chiamavano nomi, pregavano, imprecavano, implorarono aiuto in tutte le lingue d’Europa». È questa l’umanità di cui Levi si fa etnologo ne La tregua, un’accozzaglia di sradicati, strappati a tutto e da tutto, fin quasi persino all’umanità. In questo caleidoscopio umano le parole di Levi tracciano sempre, tranne nel caso dei tedeschi, confini a matita, dal tratto leggero, che lascia spazio alla comprensione e al cambiamento, perché “una guerra spacca come una sassata” e frantuma ogni ordine.
Tutti possono o vogliono diventare qualcos’altro, fingersi diversi ed è in questo mare in continuo movimento che Levi traccia la sua etnologia, che è fatta più di individui, che di popoli, tranne che nel caso dei tedeschi e dei russi. Nei confronti di questi ultimi, che Levi chiama sempre russi e mai sovietici, come se ne volesse cogliere più l’anima antica, popolare, che non la condizione storica del momento, esprime una sorte di spontanea simpatia e ammirazione e a un tempo una certa mancanza di fiducia, che non diventa però mai disprezzo. Sembra quasi che Levi accetti con bonarietà quel tanto di inefficienza che li accomuna ai mediterranei. Come quando descrive la distribuzione del cibo nel treno del ritorno, dove un giorno le razioni erano quasi a zero e il giorno dopo smisuratamente abbondanti, senza alcuna ragione: «si trattava ancora una volta della benefica secolare incuria russa, della negligenza oblomoviana, che affiorava a tutti i livelli in quel momento felice della loro storia» (ibidem). Una inefficienza che forse diventa persino liberatoria dopo la delirante precisione dei nazisti nel mettere in atto crudeltà di ogni tipo. Levi ammira il patriottismo dei russi che incontra, sincero, profondo, mai fanatico, persino ingenuo.
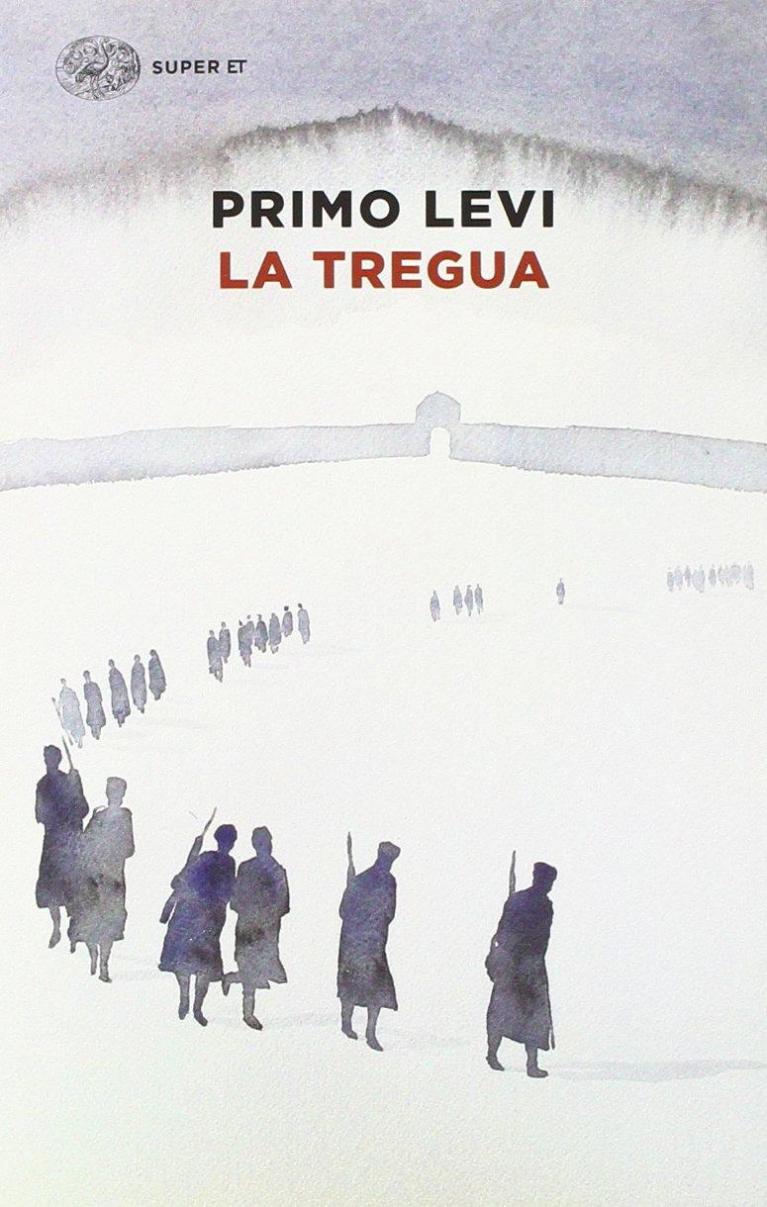
Poi i tedeschi, appunto, dopo averne subito la violenza nel lager, Levi li rivede nel breve passaggio in Germania lungo la via del ritorno. Qui Levi abbandona “lo sguardo da lontano” dell’etnologo e la sua presunta oggettività. Punta il dito e chiede risposta. Il male fatto è troppo grande perché possa essere spiegato in termini che risuonino di umanità. E forse qui Levi propone una inversione di ruoli: chi è un uomo? E il soggetto non è più il deportato a cui si è tentato di portare via la cifra umana, è colui che ha cercato di strappargliela e neppure ritrova quel gesto, questo sì umano, del chiedere scusa. Lui è rimasto impantanato nella sua inumanità, non Levi e i suoi compagni di sventura, che nonostante tutto non riescono a gioire del disastro altrui.
Il panorama etnologico di Primo Levi è fatto però soprattutto di individui appena accennati, che popolano l’universo disgregato di Auschwitz. Da questa disumanità emergono figure che non appartengono più alla categoria della storia, ma a quella del dolore, della paura, della volontà di sopravvivere. Individui persi a tutto e da tutto persi. Figure come Hurbinek. Un bambino e i bambini, scrive Levi, «erano a Birkenau come uccelli di passo» (ibidem). Hurbinek è la non creatura, è paralizzato alle gambe, non sa parlare perché è cresciuto nel campo e nessuno glielo ha insegnato. È un punto interrogativo, una domanda senza risposta, se non nell’infinitezza della tragedia e della crudeltà umana. Dopo il lager Levi inizia a disegnare ritratti umani, come dice ancora Del Giudice, «a figura intera», perché dopo la liberazione il tempo riprende a scorrere, ci si muove, qualcosa accade, l’inaspettato attende e lascia sperare, anche se la novità non sempre è piacevole.
Tra questi individui scompaginati spiccano Mordo Nahun, il Greco, uomo dall’etica piratesca e cinica, ma rigorosa, per cui Primo Levi prova una sorta di ammirazione e rispetto. Lo sente vicino perché mediterraneo come lui e questa mediterraneità diventa un modo per uscire da quell’insidioso grigiore che attira verso gli abissi dell’indifferenza, per rimanere attaccati a qualche brandello di storia forse per sopravvivere o per morire un po’ di meno. Così, come emerge da molti racconti di ex deportati, si costruiscono dei “noi” fragili, ma buoni a sopportare un po’ meglio il nulla voluto dai carnefici.
Difficile costruire un qualsiasi senso di appartenenza quando si è internati in un lager, dove tutto viene azzerato. Ci sono individui di nazionalità diverse, rumeni, austriaci, polacchi, italiani, tutti accomunati da un destino feroce, ma anche, per la maggior parte di loro, dall’ebraismo. Un dato identitario fondamentale questo, peraltro mai eccessivamente enfatizzato dal laico Levi, che nella sua antropologia viene però messo in crisi dai Sonderkommandos, quegli ebrei che hanno accettato di collaborare con i nazisti, che accompagnano i loro fratelli alle camere a gas, che ne portano via i vestiti, tranne poi finire anche loro nudi e strozzati dallo stesso gas. È questa la tristemente celebre “zona grigia”, una delle metafore più pregnanti di Primo Levi, quella che forse spiega meglio di ogni altra la “banalità del male” e la complessità della realtà umana, in cui il male non sta sempre da solo, dalla parte sbagliata, ma si intreccia in un abbraccio opaco con molte esistenze condotte all’ombra di una presunta normalità.









