Enzo Traverso, La tirannide dell’io
Tradizionalmente, la scrittura della storia è usa attenersi ai vincoli formali dell’impersonalità e del distacco. Se l’obiettivo della ricerca è la ricostruzione critica degli eventi passati, la distanza del ricercatore dalla materia di cui parla costituisce una garanzia di oggettività: la serietà scientifica è certificata, fra le altre cose, dall’assenza di elementi d’ordine personale che potrebbero inquinare il rigore dell’indagine e l’equanimità dell’esposizione. Così è; o meglio, così è stato, fino a non molto tempo fa.
Negli ultimi anni è emerso infatti un approccio differente, anzi, radicalmente opposto, che mina i cardini dell’epistemologia disciplinare attribuendo alla figura di chi scrive un ruolo attivo, a volte addirittura protagonistico. Anziché occultare la propria presenza, lo storiografo la esibisce; anziché tenersi a distanza dall’oggetto della ricerca, indugia sulle ragioni che glielo fanno sentire prossimo. Riguardo alla scelta dell’argomento trattato, i moventi personali vengono dichiarati, ammessi apertamente, in qualche caso notomizzati. Il risultato è che la scrittura della storia subisce una forte torsione soggettivistica: prendendo a prestito una formula corrente nel campo della critica letteraria, si passa da una scrittura «in terza persona» a una scrittura «in prima persona».
Questo, in estrema sintesi, lo scenario prospettato da Enzo Traverso in un volume edito da poco da Laterza nella collana Tempi Nuovi: La tirannide dell’io. Scrivere il passato in prima persona (trad. di Luca Falaschi, pp. 182, € 19). Traverso, come molti sanno, scrive e pubblica in francese, essendo espatriato da quasi quarant’anni; il titolo dell’edizione originale (2020) è Passés singuliers. Le “je” dans l’écriture de l’histoire.
Le due formulazioni, pur prossime, non sono del tutto equivalenti: più ambigua e sottile quella francese, più drammatica quella italiana, e fors’anche fuori misura, giacché di «tirannide» il testo in realtà non parla. Vero è peraltro che a questo fenomeno, in forte espansione, Traverso guarda con una curiosità mista a inquietudine. I pericoli di una «crescente invadenza dell’io» si direbbero più cospicui dei benefici che essa è in grado di offrire.
Traverso delinea un panorama storico ampio, risalendo fino alle prime, parzialissime infrazioni del paradigma oggettivistico mutuato dalle scienze naturali, che si possono registrare fin dalla prima metà dell’Ottocento. Già Jules Michelet, inventore della «ego-storia» (moi-histoire) si era fatto promotore di un tentativo di dialogare con il passato che implicava un certo grado di immedesimazione con gli attori dell’epoca; più tardi Leopold von Ranke parla di Einfühlung, Wilhelm Dilthey insiste sul concetto di Erlebnis.
Gradualmente, si acquisisce l’idea che è la stessa obiettività storica a esigere la coscienza del proprio coinvolgimento personale. Lo storiografo è un individuo in carne e ossa, con un’esperienza sociale, familiare, culturale determinata, che non può non incidere anche sui suoi orientamenti di ricerca: se esserne consapevoli è doveroso, renderne edotto il lettore potrebbe valere addirittura come principio deontologico. Avviene così che un’ammissione che in precedenza sarebbe potuta apparire «quasi oscena», alla stregua della violazione di un tabù o della confessione di un peccato, finisce per essere accettata come un atto di onestà intellettuale.
Lungo questo processo, due fenomeni assumono un particolare rilievo. Uno è rappresentato dal crescente peso attribuito alle memorie nel corso del XX secolo, in particolare alle memorie delle vittime della Shoah. L’altro, dalla diffusione senza più limiti delle autobiografie: se chiunque è legittimato a narrare la propria vita, perché non chi scrive di storia?
A questo proposito, un evento di rilievo è la pubblicazione degli Essais d’ego-histoire curati da Pierre Nora (1987), una raccolta di autobiografie di storici che a un italianista, pur con tutti i possibili distinguo, non possono non richiamare alla memoria l’impresa promossa due secoli fa da Giovan Artico di Porcìa, quel Progetto ai letterati d’Italia per iscrivere le proprie vite (1728) da cui sortì l’autobiografia di Giambattista Vico.
Ma secondo Traverso l’emergenza di una nuova soggettività storiografica va ben al di là di più o meno sporadici cedimenti alla voga dell’autobiografismo, così come di imprese autobiografiche condotte con ineccepibile rigore di metodo; e nemmeno può essere ricondotta alla semplice necessità di aggiustare o aggiornare quel punto di equilibrio tra distanziamento critico e identificazione empatica che è divenuto inevitabile definire, una volta archiviato il mito dell’oggettività scientifica (con l’annessa presunzione di poter estromettere completamente l’io dall’attività della ricerca).
Il coinvolgimento personale, infatti, non costituisce soltanto un aspetto della scrittura del passato, uno fra gli altri: in non pochi casi, ne rappresenta la matrice. Un’autentica «simbiosi» lega lo storico all’oggetto della sua ricerca: è questo ad esempio il caso di La leçon de Vichy. Une histoire personnelle di Pierre Birnbaum (2019), di Composition française di Mona Ozouf (2009), di Jeanne et le siennes di Michel Winock (2003), di Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus di Ivan Jablonka (2012), tradotto da Mondadori (Storia dei nonni che non ho avuto). In un panorama quasi esclusivamente francese c’è spazio anche per un testo italiano, Partigia di Sergio Luzzatto (2013). Dunque, al «Narciso romanziere» di cui discettava cinquant’anni fa Jean Rousset (Narcisse romancier, 1973) si affianca ora un Narcisse historien?
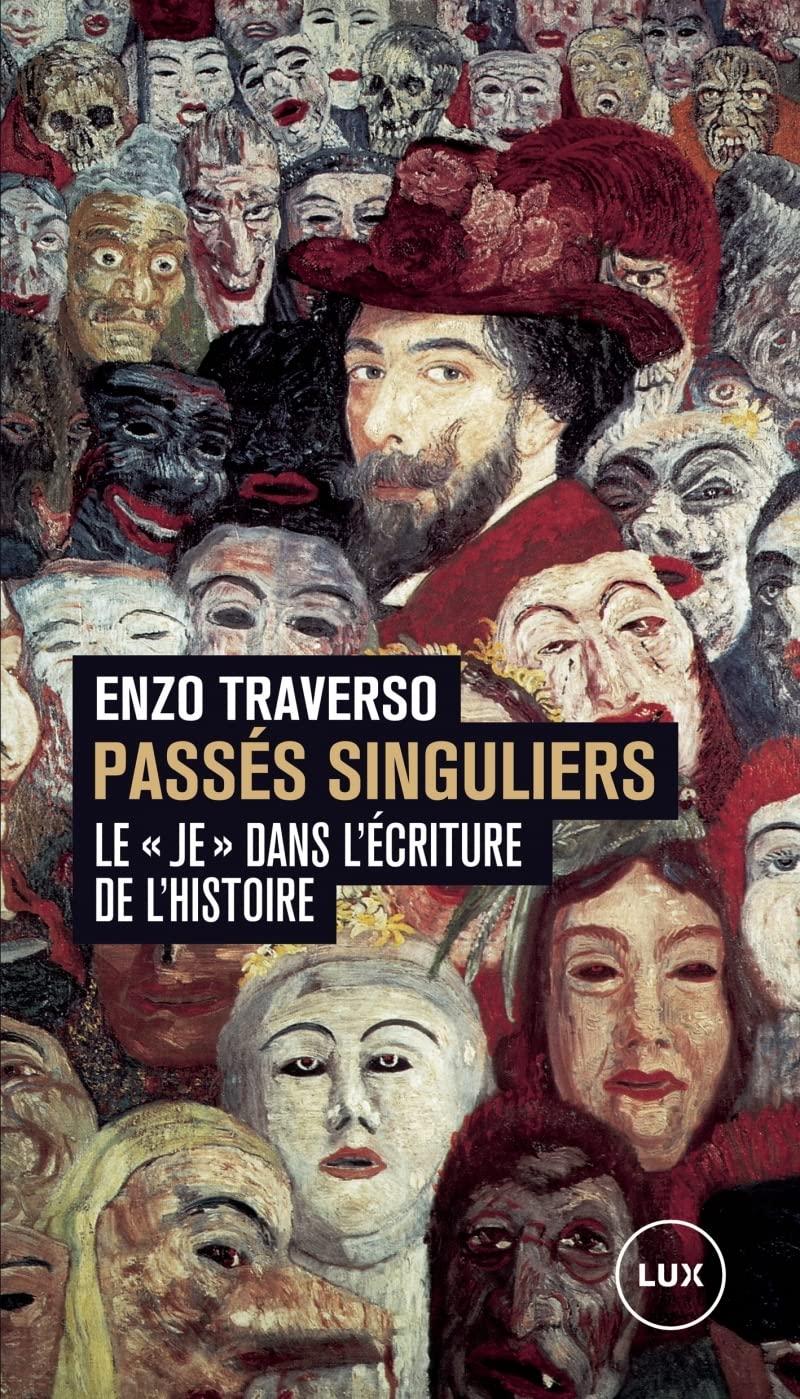
Qui tocchiamo un punto di particolare interesse, cioè la convergenza tra storiografia e letteratura. Mettendo sé stesso al centro del progetto di scrittura del passato, lo storico si trasforma pressoché inevitabilmente in personaggio letterario. E d’altro canto, è un fatto che molti tra i più quotati scrittori europei contemporanei, come Emmanuel Carrère e Javier Cercas, pubblicano romanzi intrisi di storia: narrazioni fattuali il cui nocciolo è la ricostruzione di vicende storiche, l’interpretazione di eventi pubblici noti o nascosti, lo scioglimento di enigmi storici, ovvero il ritratto di figure storicamente esistite.
Sull’osmosi fra scrittura storica e scrittura letteraria il già citato Ivan Jablonka ha scritto un saggio sul quale converrà ritornare, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales (2017). Nel frattempo, vale la pena di ricordare che in Italia non poche delle esperienze letterarie più significative del secolo XXI sono improntate al nesso fra narrativa e storia, o fra narrativa e inchiesta, dai romanzi del collettivo Wu Ming al caso davvero esemplare di Gomorra.
Nel chiedersi le ragioni della nuova tendenza soggettivistica della storiografia contemporanea, Traverso sottolinea due fattori: il cosiddetto linguistic turn, che ha interessato le scienze umane intorno agli anni Ottanta dello scorso secolo, e il coevo avvento del «neoliberalismo». Non che gli studiosi di cui parla siano «neo-liberali» (o, diremmo meglio, «neo-liberisti»): tutt’altro.
Rimane tuttavia il fatto che nel lungo periodo quella epocale svolta politica conservatrice ha portato a una nuova forma di vita, caratterizzata da un’importanza inedita della dimensione competitiva: tanto che in molti casi gli individui sono indotti (o costretti) a programmare la propria esistenza come una strategia aziendale. In questo argomento (così come nell’espressione, occasionalmente usata da Traverso, di «era del selfie») emerge con particolare chiarezza la diffidenza dell’autore verso una storiografia troppo centrata sull’io.
Da questo punto di vista mi pare che le considerazioni principali da fare siano due. In primo luogo, l’aggancio all’esperienza personale è un fenomeno ricorrente negli studi, e nella cultura umanistica in generale: ogni volta che, per una ragione o per l’altra, un assetto istituzionale viene avvertito come logoro o insoddisfacente, l’«io» è da sempre un plausibile punto di (ri-)partenza. Accade nella letteratura; è avvenuto in filosofia, in antropologia; che accada ora nella storia è senza dubbio significativo, ma non sorprendente.
Il problema è se l’affermazione di un nuovo paradigma soggettivistico non metta a repentaglio la qualità scientifica della ricerca. Ora, la presenza individuale dello storico nel racconto del passato conferisce alla narrazione un tratto di autenticità umana che ne accresce la credibilità, e quindi l’autorità: ma questo è un fenomeno che ha a che vedere con la letteratura, assai più che con la storiografia. Il rigore del metodo storico si gioca su piani diversi: quindi, a seconda dei casi, si tratterà sempre di verificare se la sovraesposizione dell’io costituisca una risorsa retorica aggiuntiva, che potenzia l’efficacia del testo, o se invece non rappresenti un ostacolo, un fattore di distrazione – al limite, un elemento centrifugo. Il riferimento a Partigia potrebbe essere illuminante. Il libro di Luzzatto può essere letto in tre chiavi: come contributo critico su Primo Levi, come indagine storiografica, come opera letteraria. Su quale di questi piani funzioni meglio, non è questione che vada dibattuta qui.
Un altro problema a cui Traverso è (giustamente) sensibile riguarda il rapporto fra individualità e socialità. L’espansione dell’«io», egli sostiene, va di pari passo con il restringimento del «noi». Le nuove scritture soggettiviste del passato sono l’espressione di una generazione che è stata segnata dalla fine dell’impegno politico, della militanza attiva, e che si è dedicata ai traumi e alle lacerazioni lasciate in eredità dalla storia recente.
Il punto è che il recupero del passato attraverso la memoria individuale e familiare – sul quale di per sé non ci sarebbe nulla di eccepire – potrebbe adombrare uno scenario in cui la dimensione collettiva si va man mano dissolvendo. L’indebolimento di quelli che siamo usi chiamare, sulle orme di Maurice Halbwachs, i «quadri sociali della memoria» potrebbe essere il sintomo di una graduale perdita di funzionalità nella trasmissione del ricordo del passato. La storia si frantumerebbe così in una serie di «passati singolari» (come recita il titolo originale del libro), non idonei a garantire la continuità di un tessuto culturale.
Da questo punto di vista, La tirannide dell’io può valere come un utile campanello d’allarme. La perdita del senso della durata, o quanto meno una sua drastica riduzione, è uno degli elementi che più chiaramente distinguono la mentalità delle generazioni più giovani da quelle dei genitori e dei fratelli maggiori (a tacere dei nonni), si occupino o no di ricerca storica. Fino a un certo punto, tale fenomeno ha una giustificazione concreta: in un mondo globalizzato e interconnesso, per capire quello che succede è necessario tenere presente quello che contemporaneamente sta succedendo altrove: più necessario di quanto non lo fosse in passato, quando, per ricercare la spiegazione degli eventi attuali, si usava innanzi tutto recuperare gli antefatti.
Non di meno, è difficile negare che l’affievolirsi del senso della storia rappresenti un fenomeno preoccupante, così come la mancanza di una memoria storica condivisa mina alla base la coesione sociale di ogni comunità. Per queste ragioni, preservare l’importanza della scrittura del passato dovrebbe essere considerato un obiettivo culturale cruciale. Le memorie individuali e familiari, da sole, non bastano, per quanto concepite e realizzate secondo i più rigorosi principi metodologici. E gli storiografi che riuscissero a consegnarci capolavori letterari renderebbero un buon servizio alla letteratura, ma non necessariamente alla storiografia. Il cui compito fondamentale rimane, come ha scritto Carlo Ginzburg, quello di «districare l’intreccio di vero, falso, finto che è la trama del nostro stare al mondo».









