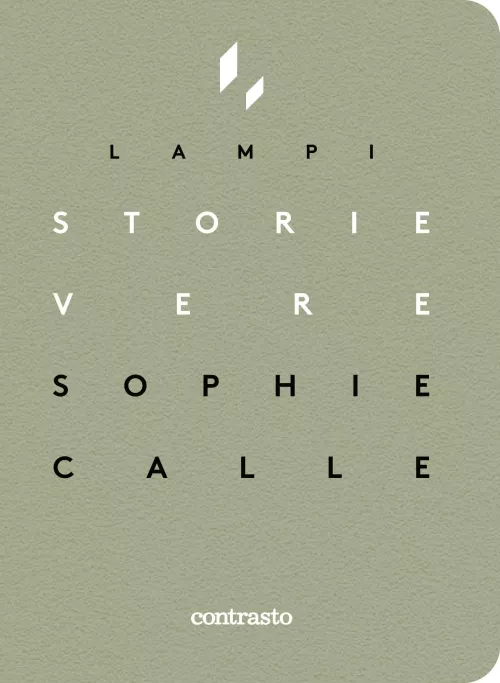Son coeur mis à nu / Sophie Calle, Storie vere
La nostra amata gatta Baguette compie oggi quindici anni. Sta male, è dimagrita; si nutre soltanto di brodetti proteici; sta morendo. Per portarci avanti nell’elaborazione del lutto, Caterina e io da qualche tempo coltiviamo fantasie cimiteriali. Avvolgerla in un drappo di lino. Adagiarne la salma in una cassetta di Moët Chandon. Seppellirla ai piedi di un bosso nell’avita casa di campagna. Pensavamo di esagerare, pensavamo di sbagliare. Non abbiamo figli, noi coppia dink, saremmo imputabili d’eccesso di pet care e corresponsabili dell’estinzione umana.
E invece ecco qui: pagina centoquindici di Storie vere di Sophie Calle, Des Histoires vraies in prima edizione 1994, con varie ristampe arricchite e modificate, fino questa italiana procurata da Contrasto per la meritoria collana “Lampi”, 2022. Il cinquantesimo dei sessantatré récits che compongono questo libretto è dedicato al gatto Souris, dentro la sua bara di legno (“serviva da modello ai rappresentanti prima dell’uso della fotografia”). A Souris sono dedicate anche altre microstorie, compresa Maternità: “Quando sostenevo di non volere figli, mi fecero notare che il mio comportamento con Souris era quello di una madre”.
Ogni libro cerca il suo pubblico e ogni lettore trova il proprio modo di leggere un libro. Vale anche per questo libro, che funziona in molti modi. Lo si può aprire dove si vuole, tanto la struttura è la stessa. Sulla pagina pari c’è una foto, quasi sempre scattata da lei, si presume. Sono perlopiù istantanee, prese un po’ così, a volte sghembe e sgrammaticate, a volte di recupero e a volte di riciclo. Sembrano fatte apposta per dare ragione a Joan Fontcuberta o a Joachim Schmidt. Sulla pagina dispari c’è invece un testo che può spaziare dall’epigrafe alla didascalia fino al racconto breve, introdotto da un laconico titolino. A volte il testo commenta le foto, a volte la foto illustra il testo, altre volte le cose vanno per conto loro. Ma resta un’unità compatta, non c’è mai salto di pagina. Qualche volta soltanto la foto si prende la pagina intera e il testo a quel punto scorre sotto.
I raccontini sono divisi in sezioni, ma definirle “tematiche” sarebbe imperdonabilmente burocratico. A leggerli in sequenza, uno dopo l’altro, i raccontini si compongono un po’ come quelle proiezioni di diapositive di una volta, commentate con enfasi deittica dagli zii o dai cugini, in certe serate festive o alla fine di pranzi o cene noiose.
Solo che a parlare qui è Sophie Calle. Una che a vent’anni si affacciava tutte le sere da un baraccone a Pigalle per fare lo striptease: “diciotto volte al giorno, tra le quattro del pomeriggio e l’una del mattino”, e siamo liberi di crederlo. E che poi posò come modella, salvo rendersi conto che un tizio alla fine di ogni sessione lacerava con una lametta i disegni tratti dall’ispezione del suo corpo. Uno di questi disegni, di sadico perturbante accademismo, è sulla pagina a fianco del raccontino.
Sophie Calle che poi si scopre, o si inventa artista, che differenza fa, e un giorno si fa assumere da uno di quegli alberghi veneziani che si affacciano sulla riva degli Schiavoni. Per tre settimane, siamo nell’inverno del 1981, s’intrufola nelle camere come donna di servizio. Prende nota di come trova le lenzuola, le cose che sono state lasciate sui comodini o sul lavabo, gli abiti appesi nell’armadio. Su quei lacerti di esistenze elabora fantasie, cercando d’immaginare le vite, i corpi, le azioni dietro quei detriti. Vuoti e assenze che assumono lo spessore di presenze possibili. La prossimità allucinatoria di oggetti quotidiani, informi, distratti, che non segnala altro che un’irrimediabile distanza. L’iperrealismo della traccia visiva e l’obiettività del referto a verbale compongono soltanto una diversa forma di opacità.
Voyageurs inconsapevoli di agire dinanzi a una voyeuse. “J’observais, par le détail, des vies qui me restaient étrangeres”: quel libro, ormai leggendario e costosissimo, s’intitola L’Hotel, Éditions de l’Étoile, 1984.
Erano gli anni in cui trionfava un’aggressiva pittura figurativa d’impianto neoespressionista insieme a una revisione ultracolta, al limite e a volte oltre il kitsch citazionista e il pastiche postmoderno. Anni in cui si credeva ancora alla presenza corporea dell’Autore (e poteva essere tanto il texano vitaminizzato alla Schnabel o il tossico suburbano alla Basquiat) e a quella merceologica del Capolavoro.

Calle lavorava in tutt’altra direzione. Aveva introiettato la natura più freddamente analitica e documentaria dell’arte concettuale e narrativa. E aveva compreso, per averla vissuta, la parte più importante delle pratiche performative e delle azioni femministe degli anni Settanta. Ma senza piagnistei e senza gonne a fiori. E anziché sputare su Hegel, ripudiare la famiglia, fondare un circolo di autocoscienza o una rivista “autoprodotta” in ciclostile tra compagne, ha provato a indugiare con disarmante sincerità e un certo coraggio su se stessa, imprimendo una torsione tutta particolare a concetti come «il privato è politico» o «io sono mia».
Ha così accettato di trasformare il gioco delle reminiscenze e la propria commedia umana in un transfert analitico. Ma ecco, senza ideologie, sistemi o grandi discorsi; accantonando le Teorie circensi sulla dominanza del Segno e accontentandosi dei segni: quelli lasciati dal fondo del caffè nella tazza, da un cuscino sprimacciato, dal cadaverino rinsecchito di un gatto morto (non Souris, ma un altro: lei dice che finora ne ha posseduti tre, tutti ormai andati).
O come quella volta che ha trovato in rue des Martyrs un taccuino d’indirizzi e prima di restituirlo al proprietario ha trascritto e contattato tutte le persone in elenco, spiegando che desiderava parlare loro per provare a capire chi fosse il proprietario. Così, senza volerlo incontrare, semplicemente ripercorrendo il suo giro di amici e conoscenze (The Address Book, 1983, inizialmente uscito a puntate su «Libération»). Cose come questa l’hanno fatta inscrivere in quella «estetica relazionale» – la nota definizione è di Nicholas Bourriaud— in cui l’arte agisce come interstizio sociale, sottratto alle leggi del profitto. Uno spazio che accoglie l’esperienza quotidiana, invitandoci con delicatezza o costringendoci con imperio ad accettare funzioni sociali diverse.
La vita che Sophie Calle racconta in Storie vere è quella del letto dove ha dormito fino a diciassette anni; dell’abito da sposa fino a quei tempi ambito; del suo seno a lungo meschino nel confronto con la florida madre e che prodigiosamente prese forma “nel 1992, in sei mesi”. Ed è una vita scandita dalle vecchie zie che ricamano lenzuola, di lei stessa che si rivede nella foto un po’ stupefatta di quand’era bambina, della notte trascorsa a dormire sulla Torre Eiffel. E poi di mariti che come primo regalo di matrimonio rilasciano un’erezione, e ai quali prima del divorzio viene chiesto di pisciare in un secchio davanti alla fotocamera, perché “quello scatto mi è servito per posare la mano sul suo sesso un’ultima volta”. E poi i figli non voluti, e poi ancora e sempre madri e padri che sono quelli che sempre ci ritroviamo. “Avevo trent’anni e mio padre riteneva che avessi l’alito cattivo. Senza consultarmi, mi organizzò una visita da un medico generico incontrato per caso. Ci andai. Non appena arrivata, dai suoi modi, mi fu subito chiaro che si trattava di uno psicanalista”.
Genitori che poi invecchiano e poi muoiono, proprio come Souris, ma molti anni dopo (“Decideva tutto lui. Anche la sua morte: 96 anni. Discorso chiuso. Poi l’ha vista arrivare a 94. Due anni rubati. Questo lo ha fatto infuriare”).
In Storie vere l’aggettivo che compone il titolo è forse la cosa più enigmatica e inquietante. Meno analitico e posato degli Untitled film stills di Cindy Sherman, meno viscerale e unilaterale rispetto alla Ballad of sexual dependency di Nan Goldin, il lavoro di Sophie Calle sta al punto di congiunzione di quelle autrici e di quei lavori, sfidando la concezione stessa di verità documentaria e di finzione autobiografica, mettendo in crisi lo statuto del documento fotografico come del racconto di sé.
Che questa edizione italiana sia proposta da Contrasto dice molto su come la fotografia è cambiata, negli ultimi quarant’anni, grazie proprio al lavoro di coloro che fotografi non sono. Ed è difficile davvero dire cosa Sophie Calle veramente sia: nella fusione tra arte e vita, e senza improbabili estetismi, è stata di volta in volta attrice, videomaker, fotografa, antropologa, psicologa, notabile e mistificatrice, e tutte queste cose insieme.
In anticipo sullo storytelling narcisista e sull’egotismo di Instagram, con la sua peculiare interferenza tra testo e immagine Sophie Calle ha creato qualcosa che tiene al tempo stesso dell’altare e del confessionale, del mistico e del prosaico, dell’album di famiglia e del journal intime, della finzione della vita e della verità della morte.
Ed è tutto chiaro nell’ultima foto del libro, con la figura dell’autrice che si riflette sulla superficie lucida di una lastra tombale di granito, sospirata assegnazione cimiteriale a novemila chilometri da Montparnasse. Son coeur mis à nu, nell’unico modo oggi possibile. Ci fa credere di sapere tutto di lei, ma in realtà non ne sappiamo niente.