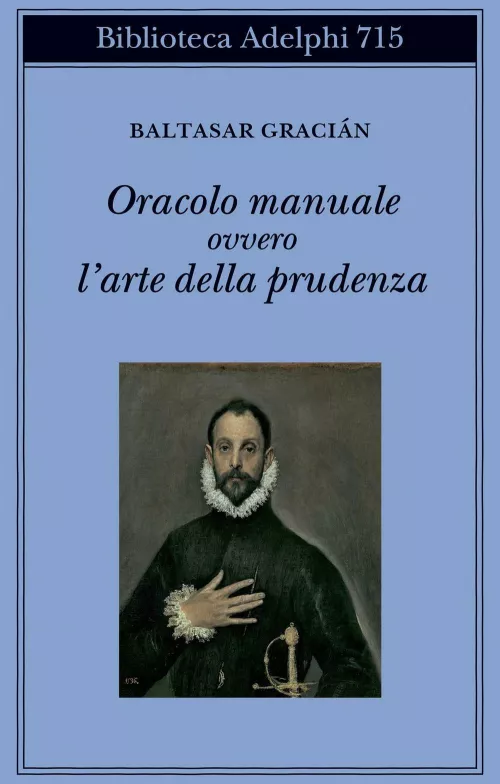Oracolo manuale / Baltasar Gracián. La lezione di Proteo
Cioccolatinizzazione; che mai vorrà dire, posto che esista, quest'orrido neologismo? Vuol semplicemente significare il triste destino che attende gli autori di massime, aforismi, apoftegmi e sentenze. Ciò che hanno distillato anni di esperienza di vita e di sagacia stilistica finisce per avvolgere gustosi cioccolatini.
Anche Baltasar Gracián non sfugge alla regola e spesso accade, ai degustatori delle suddette dolcezze, di imbattersi in suoi detti, quando le estraggono dai loro involucri di stagnola.
Ora, non so se per porre rimedio alla deplorevole sorte degli scrittori di massime, Adelphi pubblica, nella traduzione di Giulia Poggi, l'Oracolo manuale ovvero l'arte della prudenza, trecento aforismi usciti la prima volta nel 1647 e qui accompagnati da un poderoso saggio di Marc Fumaroli (Dall’“Oráculo manual” all’“Homme de cour”), tradotto da Graziella Cillario, che occupa quasi due terzi del volume; quindi sono propriamente due libri in uno.
Baltasar Gracián (1601-1658) era un gesuita anomalo, in conflitto con la Compagnia. Comunque spesso per precauzione si sdoppiava: alcune opere le firmava con il trasparente pseudonimo di Lorenzo Gracián (anche l'Oracolo), altre con il nome vero, specie quelle più ligie e “ortodosse”, come per esempio il Comulgatorio, sulla difficile arte di prepararsi a ricevere degnamente l'eucarestia.
Nonostante questo stratagemma e nonostante il suo potente protettore e mecenate, Don Vincencio Juan de Lastanosa, che amava ospitarlo nel suo palazzo di Huesca, Gracián incorse negli strali dei suoi superiori allorché pubblicò la sua opera più importante, i tre volumi del romanzo allegorico El Criticón. Qui era contenuta una descrizione piuttosto salace del collegio dei Gesuiti di Valencia, dove aveva avuto la ventura di insegnare. Lo ribattezzò El yermo de Hipocrinda: “il deserto dell'Ipocrisia”.
Per punizione venne privato della sua cattedra di Sacra Scrittura a Saragozza ed esiliato nella minuscola località di Graus. Era il 1658, l'anno in cui, non a caso, morì.
Come autore dell'Oracolo manuale Gracián ha goduto di un'immensa fortuna. Ma si sa, teste Borges, che spesso la celebrità non è che una forma d'incomprensione.
La storia del successo di questi trecento pensieri di Gracián è dunque prevalentemente una storia di fraintendimenti e misletture.
A cominciare dalla fortunatissima traduzione di Amelot de La Houssaie, uscita a Parigi nel 1684, per i tipi della Vedova Edme Martin e Jean Boudot librai, preceduta da un'Epistola dedicatoria a Luigi XIV e sotto il seguente titolo: L'Homme de cour de Baltasar Gracián, traduit et commenté par le Sieur Amelot de La Houssaie, ci-devant Secrétaire de l'Ambassade de France à Venise, testo debitamente munito di un privilegio reale stampato a fine volume.
Il francese era considerato il “latino dei moderni” e la traduzione in francese rappresentava il passaporto indispensabile per la celebrità europea.
Amelot de La Houssaie era un personaggio enigmatico. Non sappiamo quale fosse il suo nome esatto: Abraham Nicolas o solamente Nicolas? Né abbiamo certezza che il suo cognome si scrivesse La Houssaie o de la Houssaye. Né maggiori certezze abbiamo sul suo luogo di nascita e sulla data. Per alcuni fu un ex ambasciatore di Francia a Venezia. Per altri, e più probabilmente, solo un segretario d'ambasciata, a Venezia, a partire dal 1669. Benché accusato di furto di oggetti d'arte e documenti riservati, non fu espulso dall'ambasciata né fatto oggetto di azioni giudiziarie. Rimasto nella città lagunare poté accedere agli archivi della Repubblica e ne ricavò materia per una Storia del governo di Venezia (1676) che provocò la reazione furibonda dell'ambasciatore veneziano a Parigi, Contarini.
C'è chi sospettò che fosse una sorta di agente provocatore al soldo di Colbert.
Fu comunque un archivista erudito ed esperto e per lunghi anni fu sodale di Frédéric Léonard, “libraio del Re, di Monsieur e del Clero di Francia”, la cui bottega “Allo scudo di Venezia”, si trovava, a Parigi, in rue Saint-Jacques.
Comunque, a parte le vicissitudini di questo singolare traduttore (che si esercitò anche sulle opere di Machiavelli), quello che più conta è che la sua traduzione travisa, subito, fin dal titolo, l'opera di Gracián.
Nell'originale spagnolo non è traccia di questo “Uomo di corte” che campeggia nella versione francese e che influenzerà sensibilmente la lettura del testo in tutta Europa.
Per Amelot le trecento massime di Gracián sono un breviario per vivere a corte, dove la Corte è quella di Luigi XIV. Nell'ambito di questa cornice, dove la segretezza del monarca si riserva gelosamente la decisione politica, si apre però un vasto campo di eccellenza civile, nel settore dell'amministrazione, della diplomazia, del servizio armato, dell'urbanità, delle belle arti e delle lettere. Il suddito del Gran Re deve dotarsi di un'arte d'autogoverno, così come il Re è dotato dell'arte di governare lo Stato, che in Lui s'incarna. A questa educazione del suddito eminente francese Amelot porta il suo contributo con la traduzione del testo di Gracián.
Si sfiora però il controsenso, dato che lo Spagnolo in realtà non è stato certo mai tenero con la Corte di Filippo IV, né nel suo epistolario, né nelle pagine del Criticón.
Baltasar Gracián non intendeva affatto il suo Oracolo come una bussola per la vita di corte, bensì come il foglio di viaggio per grandi anime libere, destinate a restare padrone di se stesse in ogni circostanza durante la loro missione, quale che fosse, nel mondo civile e politico.
Egli voleva superare da un lato la morale arcaica iberica del “punto d'onore”, troppo rigida per la vita moderna, dall'altro quella visione del mondo terreno come luogo di pura perdizione, tipica di certe interpretazioni rigoriste francesi, quali quelle del Giansenismo.
Per il nostro gesuita, che non è un molinista ma nemmeno un seguace di Arnaud, il secolo è un terreno di azioni e operazioni rischiose ma possibili. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Se per Pascal, Arnaud, Saint Cyran, tutti seguaci del vescovo Giansenio e del suo agostinismo radicale, il mondo è una “regio dissimilitudinis”, un luogo dove la distanza da Dio è assoluta, e la difformità dell'essere umano da Lui infinita, e quindi in quanto tale un abisso di tenebra, peccato e perdizione da cui tenersi debitamente lontani (per esempio rifugiandosi nell'eremo di Port Royal des Champs), viceversa, per certi gesuiti lassisti come Suarez e Molina, con il mondo, così com'è, con tutti i suoi limiti, si può però venire tranquillamente a patti; fin troppo, anzi, forti di tutta una accomodante casistica per tacitare in mille modi brillanti la propria coscienza di peccatori nelle circostanze più spinose.
Tra il Dio che salva chi vuole lui, indipendentemente dalle opere (grazia sufficiente) e il Dio con cui si può bellamente cooperare (grazia efficace), tra l'inflessibilità del Giansenismo francese e la sdrucciolevole cedevolezza del Gesuitismo spagnolo, si apre la terza via di Gracián.
Egli, con le sue trecento massime, intende forgiare lo strumento capace di guidare nel mondo un'élite aristocratica, che nel mondo si muove, agisce, ma senza lasciarsene assorbire troppo, con la mira costante, non solo agli scopi contingenti terreni, ma anche a Dio, e, perché no?, anche a una possibile santità finale. Infatti “Santo” è intitolato l'ultimo dei trecento aforismi della raccolta (“In una parola, santo”, per la precisione).
L'uomo cui si indirizza l'Oracolo manuale vive bensì nel tempo del secolo, ma non perde d'occhio la meta, che è l'eternità.

Qui ed ora deve soprattutto imparare ad agire in quello che è il “tempo debito”. Non dev'essere né troppo avventato né troppo lento. Non deve né anticipare gli eventi né lasciarseli sfuggire. Il tempo opportuno aveva un nome preciso nelle saggezze antiche che qui il nostro autore riattualizza: in greco è “kairós”, in latino “occasio”.
Si legga infatti dall'aforisma 268: “L'uno fa le stesse cose dell'altro. La differenza sta nei tempi: l'uno agisce al momento giusto, l'altro no”. Dal 277: “Ognuno ha il suo momento: lo si sappia cogliere, ché non tutti i giorni si potrà trionfare”. Dal 288, intitolato significativamente “Vivere secondo l'occasione”: “Governare, argomentare, tutto dovrà dipendere dal momento... il saggio sa che il Nord della prudenza consiste nel conformarsi all'occasione”.
Come si vede martellano tutti sullo stesso fondamentale concetto.
L'uomo prudente non si adatta solo ai tempi, ma anche alle persone con cui via via viene in contatto.
È un “saggio Proteo”, come recita l'aforisma 77: “dotto con il dotto e santo con il santo. Grande arte il sapersi conquistare tutti, perché la somiglianza concilia la benevolenza. Osservare i caratteri e conformarsi a ciascuno di essi: al serio e al gioviale, assecondandoli di volta in volta, con astuta trasformazione”.
Del resto l'Oracolo inizia con la constatazione che oggi “tutto è ormai al suo culmine e l'essere persona al più alto” (aforisma 1). Dove rilevante è quel termine “persona”, di profonda ambiguità: da un lato “maschera” alla latina, dall'altro con tutte le risonanze cristiane insite nella parola, la cui unicità, identità, vocazione, libertà e talenti portano il sigillo di Dio, che la isola dall'insieme indistinto dei peccatori.
L'uomo di Gracián incede mascherato nel mondo, come un attore. Deve recitare la sua parte e, soprattutto, non deve mai mostrarsi quale realmente è. “Dissimulazione” è una delle parole chiave del testo. Esattamente come nella Dissimulazione onesta del quasi contemporaneo (1641) Torquato Accetto, la cui biografia è “un ritaglio di nebbia” (S.S. Nigro).
“Milizia è la vita dell'uomo contro la malizia dell'uomo. La sagacia combatte con mirati stratagemmi. Non fa mai ciò che indica; suggerisce sì, ma per sviare; accenna vagamente con abilità e opera in maniera impensata, sempre attenta a confondere...” (13).
“Le passioni sono i pertugi dell'anima. Il più sperimentato sapere consiste nel dissimulare: rischia di perdere tutto chi gioca a carte scoperte. La cautela del riservato gareggi con l'avvertenza dell'accorto: a linci della ragione, seppie dell'intimo”. (98) E qui si noti il gusto delle metafore ardite, assai appropriate del resto al teorico dell'agudeza. Il celebre trattato Agudeza y arte de ingenio uscì giusto un anno dopo l'Oracolo (e undici anni dopo quello Delle acutezze del bolognese Matteo Peregrini, come non mancò di far notare Benedetto Croce a suo tempo con malcelata fierezza nazionalistica).
L'aforisma 144 raccomanda di “entrare con l'altrui volontà per uscirsene con la propria”, esattamente come fa il maligno ricordato negli Esercizi di Sant'Ignazio, perché si tratta di un’“importante dissimulazione”. L'uomo prudente può servirsi anche all'occorrenza delle arti più malvagie. “Le intenzioni nascoste sono la quintessenza della perspicacia”.
Non ci si deve comportare come fossimo di vetro (173). E, siccome la verità è “un salasso del cuore” (181) non occorre dirla sempre tutta, anche senza dover essere costretti ad arrivare fino alla menzogna.
Non bisogna ostentare. Non bisogna cedere all'affettazione. E nemmeno, che è anche peggio, all'affettazione della non affettazione (123).
Eppure Gracián, nonostante questa insistenza sulla necessità di dissimulare, può tranquillamente prendere le distanze da essa: l'uomo integro, l'uomo leale “giudica la dissimulazione una sorta di tradimento”; egli si pregia più d'esser tenace che sagace, perché “si trova dove si trova la verità” (29).
Stupisce questa giravolta? È forse il frutto supremo della dissimulazione? (Dissimulazione dissimulata?). No, assai più semplicemente è la dimostrazione dell'estrema flessibilità dell'uomo prudente, che non si fissa mai nemmeno alle proprie regole, che non si cura della tenuta del suo “sistema”, ma sa sempre prodursi nelle agili piroette e imprevedibili veroniche del torero richieste dagli eventi.
Bisogna saper “gettare il mantello al toro dell'invidia per salvare l'immortalità” (83).
Questa tauromachia cristiana ha modo di esercitarsi soprattutto contro una particolare categoria del Male del mondo, quella rappresentata dagli stupidi, che sono perniciosissimi.
La lotta contro la stupidità è forse una delle più efficaci sonde che si possano lanciare nel corpo dell'Oracolo, al fine di avvicinarsi sempre più alla sua intima sostanza.
In effetti sono moltissimi i passi che la tematizzano.
A cominciare dal numero 48 che così conclude: “se c'è uno stupido che provoca, evita che con lui siano due”. Che fa il paio, è proprio il caso di dire, con il n.214 che recita: “Di una scempiaggine non farne due”. Anche perché, come puntualizza il n.126, “non è stupido chi fa la stupidaggine, ma chi, una volta fatta, non la sa nascondere”, e del resto, “saper dimenticare” è un'altra “grande regola del vivere”. Così come “saper sopportare gli stupidi” che fornisce il titolo al n.159. Perché al mondo “se bisogna tollerare tutte le scempiaggini, ci sarà bisogno di tanta pazienza”. Se però qualcuno, continua il n.159, non riesce a tollerare, “ricorra al ritiro in sé stesso, ammesso che riesca a tollerare almeno sé stesso”.
Gli stupidi, che si tollerino o meno, sono comunque pericolosi per le frequentazioni superficiali e sicuramente un danno per quelle intime. Inoltre sono disgraziatissimi, dato che la disgrazia è il “soprosso della stupidità”: per questo, ribadisce il Nostro, MAI IMPELAGARSI CON GLI STUPIDI (n.197). Cosa che risulta peraltro assai ardua, dato che “metà del mondo ride dell'altra metà e la scempiaggine è generale” (101). Siccome la stupidità si è ormai imposta al mondo, lo stupido più grande è colui che non sa di esserlo e chiama così tutti gli altri. “Nonostante che il mondo sia pieno di stupidi, non c'è nessuno che creda di non esserlo e neppure lo sospetti” (201).
Come conclusione, provvisoria, di tutto questo complesso e rischioso confronto continuo con l'onnipresente minaccia della stupidità può forse valere il n.208, che così finisce: “stupido è chi muore perché ne sa troppo. Cosicché alcuni muoiono perché sanno, altri vivono perché non sanno. Tuttavia anche se molti muoiono da stupidi, pochi sono gli stupidi che muoiono”.
La conclusione vera è però un'altra. Gracián, che non è il machiavellico cortigiano che vorrebbe Amelot de la Houssaie, né un cinico gesuita rotto ad ogni compromesso, né, tanto meno, un La Rochefoucauld tutto teso a smascherare le finte virtù per trovarvi solo il sottostante “amour propre” (la prima edizione delle Maximes è del 1665), ma un cristiano che vuole vivere nel mondo senza soccombervi e per trovarvi anzi salvezza e redenzione, Gracián, dunque, gioca la carta del saggio, del “saggio più grande”, quello che, all'occasione, “sa servirsi della stupidità” (240). Con gli stupidi infatti “non importa essere saggi, né con i pazzi avveduti; a ciascuno bisogna parlare nella sua lingua”.
Come si nota, è di nuovo la lezione di “Proteo”. L'estrema adattabilità. Quella che Jankélévitch, che detestava Gracián, stroncò come ipocrisia, in un saggio del 1957. A torto, secondo Fumaroli.
Ma è solo uno dei vari fraintendimenti, o appropriazioni indebite, di cui fu oggetto il Nostro autore.
Amato da Schopenhauer, che ne fece una traduzione, ma non da Amelot, bensì dall'originale spagnolo, rifiutata da vari editori e pubblicata postuma solo nel 1863. Apprezzato da Nietzsche in un primo momento e poi abbandonato. Utilizzato da Debord, come esergo del capitolo sesto (“Il tempo spettacolare”), della celeberrima Società dello spettacolo, “questo Libretto rosso francese” di quella “famosa rivoluzione di Maggio di cui l'ironia della storia fece la precorritrice in Francia della società dei consumi che essa voleva evitare” (Fumaroli). Commentato da Lacan nel suo diciottesimo seminario (Di un discorso che non sarebbe del sembiante) e l'oggetto del commento è – e si capisce! – il n.181, che così termina: “Non tutte le verità si possono dire; alcune perché riguardano noi stessi, altre perché l'altro”.
Anche Borges è da annoverare tra i disprezzatori di Gracián. Nella poesia che gli dedicò in El otro, el mismo (1964) ne fa un cieco cultore di “labirinti, allitterazioni, emblemi” (laberintos, retruécanos, emblemas) che, talmente preso da questi suoi stratagemmi verbali, non si accorge nemmeno, dopo morto, delle bellezze del Paradiso in cui si trova.
Del resto, avevamo pur citato sopra proprio la frase di Borges secondo cui la celebrità è solo una forma d'incomprensione, forse la peggiore.