Dalla cinofilia alla lupofilia / Cani e lupi
Essere con il cane e non essere con il lupo. Possiamo riassumere così la nostra storia bio-culturale di specie, a partire da una biforcazione che significa: star dentro alla civiltà (esser con il cane) o mettersi ai margini (non essere con il lupo). Con una premessa. Mentre il versante canino nasce dalla condivisione di una storia evolutiva, quello lupesco passa attraverso un rapporto di vicinanza-distanza che ha avuto come massima espressione l’eradicazione quasi completa del lupo. Si tratta quindi di storie che si sovrappongono e che, contemporaneamente, si affiancano e si distanziano, in un complesso gioco di acquisizioni, rimandi, rifiuti. Quanto appare certo è il nostro stare, come sapiens, dentro a questo movimento e non fuori, da attori con un ruolo rilevante certo, ma non da registi che dall’alto dirigono la relazione con le altre specie, cartesianamente predestinate ad un percorso subalterno e determinato. Gli approdi del postumanesimo ritrovano, secondo una prospettiva tracciata innanzitutto da Lévi-Strauss, le radici del mito, testimonianza di un mondo in cui uomo e animale stanno dalla stessa parte. Per costruire il percorso che ci ha condotti fino a qui è dunque necessario misurarsi con l’“altro”: il cane, con cui abbiamo condiviso tutte le nostre esperienze cardine; il lupo, con cui ci siamo scontrati e da cui abbiamo avuto bisogno, in tutti i modi e fino ad epoche recenti, di distanziarci. Due libri, entrambi comparsi in Inghilterra, ci aiutano a compiere l’itinerario: Il cane di Susan McHugh, pubblicato in edizione originale nel 2004, Il lupo di Garry Martin, risalente al 2012 (ora entrambi pubblicati da Nottetempo, nella traduzione rispettivamente di Alice Basso e di Anna Rusconi).
Si tratta di due studi che non si limitano a elencarci le caratteristiche di cani e lupi o ad indicare soltanto come, nel tempo, si è strutturato il loro rapporto con sapiens. Il loro intento è di dimostrare una tesi, contestando il concetto di addomesticamento che fa del cane esclusivamente un selvaggio forgiato da mani umane (McHugh); sottolineando quanto la paura profonda del lupo abbia origine da una iniziale concorrenza tra specie in competizione e dunque più affini di quanto si possa pensare (Marvin).
McHugh – intrecciando una ricchissima tavola di fonti mitologiche, letterarie, pittoriche e cinematografiche – costruisce il suo ragionamento a partire da come due specie, “siano diventate contemporaneamente “compagne” l’una per l’altra”. Cane e uomo si sono coevoluti, in quello spazio temporale che viene collocato intorno a 12 mila anni fa (ma le datazioni risalgono fino a 40 mila anni), quando si verifica il cosiddetto primo addomesticamento, che, come abbiamo detto, non è da intendere esclusivamente come un piegare la natura del cane al nostro servizio. Insieme abbiamo condiviso le tappe essenziali della nostra storia: il passaggio dalla caccia e dalla raccolta all’agricoltura e all’allevamento, la formazione di comunità sedentarie, il culto dei morti, la guerra, fino alla definizione dei ceti sociali. Un intreccio di rapporti così denso, da rendere plausibile, come ha scritto il romanziere settecentesco Horace Walpole, una ridefinizione dell’umanità come “dogmanity”, ovvero “canumanità”.
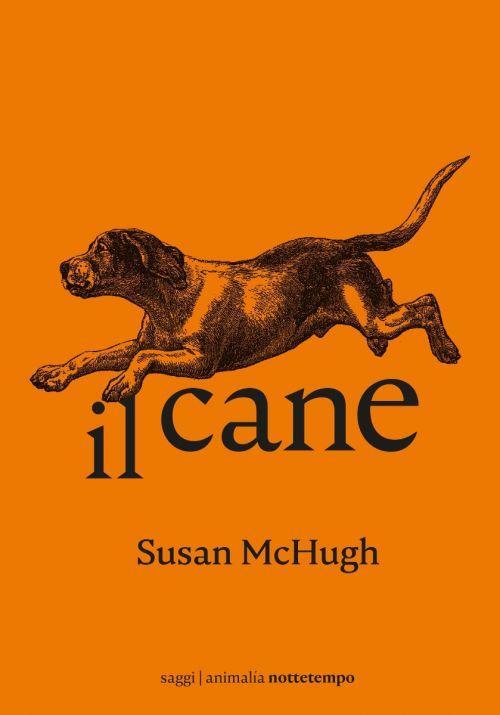
Su questa base McHugh sottolinea l’inevitabile complessità del cane, che, unico anche in questo, arriva a mettere in crisi la stessa definizione di specie come gruppo dotato di caratteristiche morfologiche omogenee (lo si può dire di esemplari così diversi come un alano e un chihuaha?), rendendo, nello stesso tempo, più problematica l’individuazione delle sue origini. È così certo che i cani siano “per natura” dei lupi? Per McHugh questa convinzione – oggi in gran parte avvalorata dalle più recenti acquisizioni della genetica – sottintende una narrazione orientata a ribadire la centralità degli uomini che “hanno strappato i cani alla natura e li hanno introdotti, anzi, innalzati alla cultura, esercitando così un dominio assoluto sul mondo animale”. Con conseguenze chiaramente inseribili all’interno di un percorso ben noto, perché, “una volta che il lupo più debole è stato tramutato in cane dalla compagnia civilizzatrice dell’uomo, gli altri lupi, per contrasto, sono diventati i buoni selvaggi e, proprio come prevede lo stereotipo dell’indigeno nella versione colonialista, sono caduti uno dopo l’altro insieme a quel che rimaneva della loro dignità”.
L’elemento decisivo di questa teoria “è la ri-creazione del cane come figura dipendente: tramutato in servitore o parassita, il cane è una creatura maledetta perché ha pervertito la propria natura”. Teoria perlomeno riduttiva (anche se è servita spesso a giustificare molti abusi umani sui cani), poiché sottovaluta che “abitare un mondo plasmato dagli uomini richiede creatività, intelligenza e generosità anche da parte dei cani”, per molti aspetti indubbiamente dipendenti dagli uomini per il nutrimento o come animali domestici o da lavoro. Senza dimenticare che “il vantaggio della convivenza è reciproco”, data “l’estrema disponibilità dei cani” a mettersi al nostro servizio in mille modi, a partire dal ruolo storico di “agenti di contenimento o di conversione del cibo”, chiamati a consumare quanto prodotto “in eccesso durante i mesi di abbondanza” e diventando “essi stessi cibo in quello di penuria” (i cani sono stati e sono mangiati da culture diffuse in ogni punto del pianeta anche se – o di conseguenza – la “cinofagia” è stata usata come strumento di discriminazione).

Marco Bettio, Ciò che non siamo ci identifica e ci svela, 2017, Olio su lino, 30x40cm.
La parola chiave in tal senso è “versatilità”: il cane è portato a interpretare ruoli diversi con grande disinvoltura. L’essere con il cane ha pertanto assunto per l’uomo significati diversi e contraddittori. Se, come evidenzia lo storico David Gordon White (in un suo fondamentale studio del 1991, Myths of the Dog-Man, mai pubblicato in Italia), i cynephali, gli ibridi uomo-cane, sono presso le antiche culture europee, indiane e cinesi la rappresentazione dei “paria” e delle “culture remote”, e se, leggendo le Favole di Esopo, al cane vengono attribuiti i vizi umani (codardia, presunzione, arroganza), è anche vero che, capovolgendo la prospettiva, in numerose tradizioni mitologiche il cane sta prima dell’uomo e molte popolazioni si proclamano discendenti dai cani, spingendo il “canino” ad avvicinarsi al “divino”.
Lo testimonia la funzione di “guardiani delle soglie”, attribuita ai cani dagli aborigeni australiani, dagli Egizi (Anubi), da Maya ed Aztechi (il dio Xolotl), dai Greci (Cerbero, il guardiano dell’Ade). Funzione di altissimo profilo che però probabilmente nasce dall’abitudine necrofaga del cane, destinata, nelle antiche tradizioni indiane, dei nativi americani e del Vicino Oriente, a farlo diventare simbolo di un “comportamento ripugnante”. L’ambivalente ruolo del cane – compagno di vita e reietto, dio e essere subalterno – si è venuta ulteriormente definendo negli ultimi due secoli attraverso la contrapposizione cane di razza-cane non di razza. I due fitti capitoli dedicati all’argomento da McHugh evidenziano come la determinazione delle razze, messa a punto nell’Inghilterra vittoriana, corrisponda alla creazione di uno status canino che è riflesso di uno status sociale umano. Il cane di razza è il cane borghese, il cane perbene, il cane che fa parte a pieno titolo della famiglia rispettabile, spesso in qualità di succedaneo del figlio. La sua vocazione – come evidenziano alcuni personaggi del cinema novecentesco, su tutti Lassie – è quella di essere al servizio permanente di una famiglia, preferibilmente eterosessuale e nucleare. Il cane di razza normalizza, o ancor meglio, pone degli argini entro cui far muovere la dialettica tra le classi. In qualche modo è una risposta ai profondi smottamenti sociali che si verificano all’alba dell’età contemporanea, nell’età dell’imperialismo razzista.
All’opposto il bastardo ha – da Baudelaire e dallo Scraps di Chaplin in avanti – rappresentato gli ultimi, identificandosi con le classi sociali gregarie, con i naufraghi dell’umanità. Ruolo che gli ha consentito, col tempo, di acquisire una corrosiva funzione di critica sociale, ponendosi a fianco – con valenza metaforica ma anche metonimica – dei movimenti che si battono per la parità dei diritti (da quelli dei lavoratori a quelli delle donne).
Alla difficoltà che si incontra nel chiudere l’essere con il cane all’interno di una definizione nitida, si oppone la relativa facilità con cui si procede alla delimitazione dell’essere con il lupo. Il lupo è – per una lunga fase della storia – il non uomo. Marvin fa notare come a renderlo evidente sia il nome scientifico che identifica il lupo, Canis lupus. Nel definirlo, Linneo, nel 1758, pensa al cane come a una specie di riferimento per il lupo, che in quest’ottica si configura come un “incidente di percorso, una creatura selvatica sviluppatasi a partire da un animale domestico”. Se il cane compagno dell’uomo è la civiltà, il lupo, nemico dell’uomo, di conseguenza, è “soltanto” una pericolosa deviazione dall’ordine. E, come tutte le deviazioni, in primo luogo fa paura. Il lupo per secoli è stato la minaccia, l’oscuro abitante dei recessi del bosco (la parte tecnicamente definita “selva”, dove non si deve entrare), l’essere “rapace, avido, ingordo, infido, criminale, assassino”.
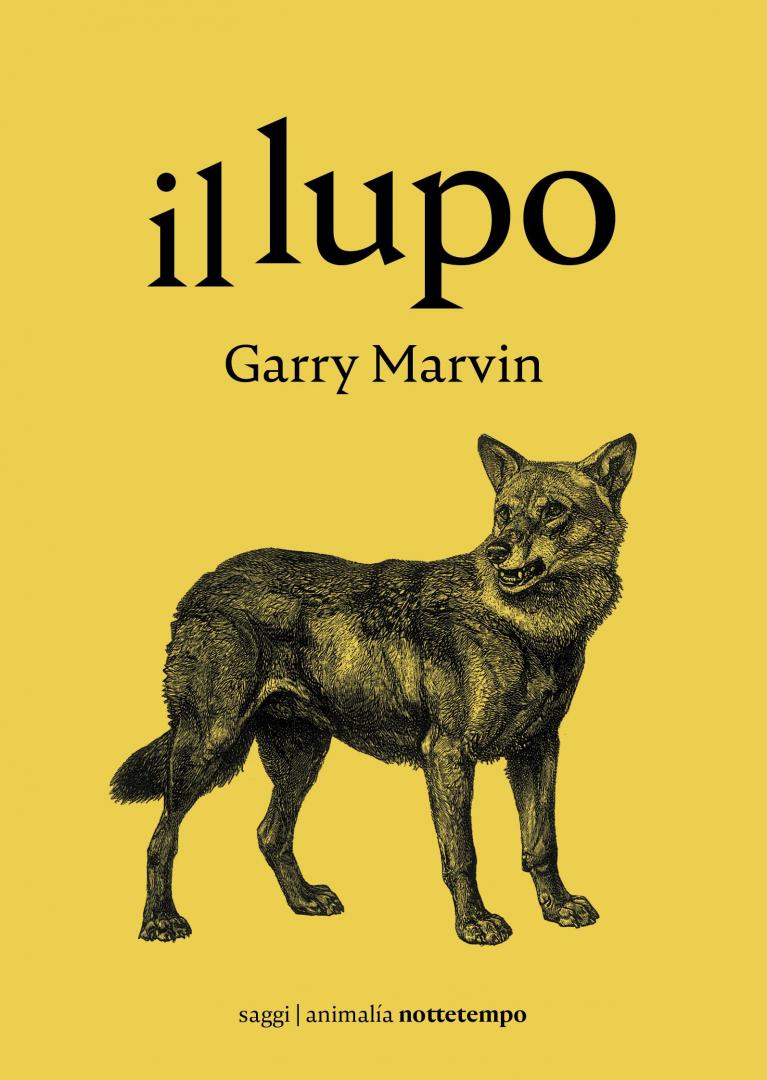
Perché è così? Marvin invita a riflettere su un aspetto poco immediato. I lupi ci assomigliano. Come noi sono carnivori, si nutrono delle nostre stesse prede. E poi, particolare che spesso sfugge, i lupi hanno dimensioni equivalenti alle nostre. Un lupo adulto maschio misura, dal naso alla coda, tra i 150 e i 200 centimetri, la femmina va dai 140 ai 185. Il pastore tedesco (cane che molti considerano simile al lupo) è lungo dai 62 ai 70 centimetri. Anche lo stile di vita non è dissimile dal nostro. La loro vita quotidiana scorre su “due binari”, quelli esterni della caccia, compiuta in modo collaborativo e collettivo, e quelli interni delle relazioni di branco, che negli ultimi decenni si è venuto delineando come una unità familiare guidata dalla coppia con prole, dove i conflitti interni sono battibecchi e non lotte di potere per il conseguimento della posizione di “maschio alfa”. Sul piano storico, la rottura delle relazioni uomo-lupo si colloca tra 10 mila e 6 mila anni fa, quando si affermano le società pastorali e il gregge e la mandria diventano le prede del lupo. Una frattura definitivamente sancita dal Nuovo Testamento, incentrato sull’immagine di un Gesù pastore che mette in guardia il suo gregge dalle insidie del lupo, animale capace di doppiezza morale (si sa travestire da pecora) e di cattiveria diabolica.
Si tratta di un passaggio determinante per capire le successive persecuzioni verso i lupi, che non vengono uccisi solo per gli attacchi al patrimonio umano, ma anche perché percepiti come “male intenzionati”, “animali criminali” appunto. Capaci oltretutto di manifestarsi con più facce, tra cui quella, insidiosissima, della licantropia, le cui prime attestazioni appartengono all’età classica (il mito di Licaone, raccontato da Ovidio), per poi conoscere particolare diffusione nel medioevo e tra Ottocento e Novecento, in versioni letterarie e cinematografiche che danno crescente spazio al conflitto interiore dell’uomo-lupo. Malvagità che diventa qualità per il nazismo (Hitler si paragona al lupo che salva l’umanità rovesciando la parabola evangelica) e che, facendo leva sull’audacia, sul disprezzo del pericolo, sull’inesorabilità, diventa componente fondativa di gruppi militari e paramilitari della destra estrema fino ai giorni nostri.
La millenaria paura del lupo è andata di pari passo con l’odio nei suoi confronti, che lo ha trasformato in un avversario da annientare, a partire dal IX secolo, quando Carlo Magno fonda la Louveterie, istituzione dedicata all’abbattimento dei lupi nelle tenute reali. All’inizio del 1500 i lupi sono eradicati dall’Inghilterra, nell’Ottocento sono quasi scomparsi dalla gran parte dei paesi europei occidentali. In America, con l’arrivo dei primi coloni, i lupi sono subito demonizzati e nell’arco di un secolo si diffonde la pratica della taglia, fondata sul presupposto che il lupo sia l’unico animale equiparabile a un fuorilegge.
L’eliminazione dei lupi negli Stati Uniti a fine Ottocento diventa sistematica – ricorrendo anche all’avvelenamento per mezzo della stricnina collocata nelle carcasse dei bisonti di cui si nutrono – sia perché sono pericolosi rivali dell’uomo nella caccia e continue minacce al bestiame, sia perché la loro pelle è particolarmente richiesta per confezionare abiti, tra cui i pastrani dell’esercito russo. Ma nell’attacco umano al lupo si continua a cogliere qualcosa di diverso dalla pura esigenza di difendersi da un razziatore di mandrie ed è lo spirito di vendetta: il lupo catturato dopo complicati inseguimenti, viene messo alla berlina, ucciso in modo esemplare, punito davanti a tutti con sopraffina crudeltà proprio per ristabilire l’ordine.
Significativamente il lupo è stato invece amato ed apprezzato dalle società di cacciatori che non considerano separato il mondo umano da quello animale. I Navajo dicono di aver imparato a cacciare dai lupi, così gli Ainu in Giappone. Presso queste culture, del resto, non esisteva l’idea di una natura selvaggia come spazio “altro”. Uomini e lupi condividevano lo stesso territorio. Né i lupi rappresentavano una minaccia di tipo economico, poiché, in assenza di pastorizia, non c’era nulla che potessero sottrarre all’uomo. L’esposizione diretta con i lupi – a loro diretto contatto – faceva inoltre parte dei rituali di iniziazione: dai lupi si ricevevano i segreti del potere, i lupi rendevano i giovani “idonei a partecipare pienamente alla vita rituale della comunità”. È la stessa idea che si ritrova nel topos mitico di Romolo e Remo allevati dalla lupa.
In epoca contemporanea il recupero dell’immagine del lupo si viene definendo all’inizio dello scorso secolo, nell’ambito della scoperta della wilderness, il piacere della vita a contatto con la natura. L’essere dalla parte del lupo diventa allora scelta di una vita alternativa, che si nutre anche di narrazioni su esperienze limite – quali quelle dei bambini-lupo compendiati da Mowgli nel Libro della giungla di Kipling – e su quanto può significare il ritorno alla vita originaria, resa per la prima volta popolare, nel mondo anglosassone, dall’Almanacco di un mondo semplice di Aldo Leopold (1949). Al piano divulgativo si affianca, sempre a partire dagli anni Quaranta, l’avvio di studi sistematici sull’ecologia della specie, che hanno evidenziato come il lupo fosse “una creatura sociale complessa ed intelligentissima che non rappresentava una minaccia agli ecosistemi, ma influiva anzi in maniera benefica su quelli in cui ancora resisteva o era possibile reintrodurlo”. Ed è così che il lupo, ignorato e frainteso fino all’inizio del Novecento, è stato finalmente tutelato dalla legge ed è diventato non solo il mammifero più studiato alla fine dello stesso secolo, ma anche “una creatura avvolta da un’aura carismatica”, al centro di una vera e propria lupofilia collettiva. Con qualche eccezione certo. Non tutti – soprattutto tra gli allevatori – sono favorevoli alla sua reintroduzione mirata. Nonostante tutto, il lupo rimane un animale controverso.









